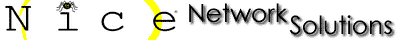|
"A noi tutti piacciono le opere in costruzione molto
più che terminate". Può cominciare così
questo breve
discorso critico su Frank Gehry, "architetto interprete di
se stesso".
Canadese, nato nel 1929, si forma quasi da autodidatta
fino ad approdare, ormai in California, presso lo studio
di Victor Gruen che lo inizia (o meglio che lo rende
partecipe) ai problemi di funzionalità della
città contemporanea. Dopo alcuni mesi trascorsi in Europa,
principalmente a Parigi, torna in America dove, in una
zona industriale della periferia di Los Angeles, apre uno
studio insieme al designer Greg Walsh.
I primi lavori (che esulano dal ristretto campo
dell'architettura vera e propria) risentono dell'influenza
dell'arte pop e minimal dovuta alla frequentazione assidua
di artisti come André, Davis, Francis, Judd e Serra. Con i
prototipi di "Easy Edges Furniture" (strati di cartone
stracciati, lacerati) Gehry si pone come esempio di
"autorepressione espressiva", conseguenza diretta della
accurata riflessione sul vero significato dei concetti di
semplicità, austerità e "astinenza artistica".
Introduce
allora il cosiddetto "striptease" architettonico in
evidente contrasto con il metodo costruttivo tradizionale
tanto povero (forse squallido?) quanto usato e
inflazionato. E' dunque nella fusione di schemi originali
e provocatori che Gehry giunge all'invenzione del suo
stesso ruolo: architetto, artista e uomo d'affari.
Nella prima metà degli anni sessanta si pongono le
basi per il futuro compositivo dell'artista californiano:
prima un'architettura neoplastica legata a superfici
grezze e trascurate, poi le grandi tele zincate lasciate
senza alcuna protezione, punto di partenza per il rilancio
della "wreck-architecture" composta di avanzi, di stracci,
di relitti. Senza entrare in dettagli tecnici questi
metodi di progettazione e costruzione si possono
interpretare come una violenta esigenza di rottura nei
confronti di un accademismo oppressivo (rimasto tanto
pressante solo in architettura) allora imperante negli
Stati Uniti. E' per lo stesso motivo che Gehry si dedica
all'ideazione o alla ristrutturazione (sempre nel rispetto
dell'edificio preesistente) di abitazioni, condomini,
centri commerciali e parcheggi.
Un discorso a parte merita il luogo dove Gehry vive e
lavora: Los Angeles è un universo in continuo movimento
che va dall'autoesaltazione alla paura di non potersi
considerare più neanche "città". Non a caso è
stato detto
che coloro che si entusiasmano per Los Angeles non possono
che essere giornalisti o designers. E' dunque in questo
ambito che Gehry vive l'arte (non solo l'architettura)
come free game, come sperimentazione, come esperienza
ludica; ed è sempre in riferimento al contesto che usa
materiali grezzi, scarsamente lavorati e poco adatti a
resistere al passare degli anni.
Dalla serialità degli edifici (case uguali a migliaia
di altre) Gehry trae spunto per un tentativo di
personalizzazione della città; operando una
ristrutturazione (non una ricostruzione) sovrappone e
dilata materiale, fa respirare le strutture portanti fino
a trovare un equilibrio perfetto tra la non originalità di
base della casa e il libero sfogo della fantasia
(architettura viva e divertente).
Quanto alle opere limiteremo il discorso a due esempi:
la Gehry House a Santa Monica e l'intervento a Euro
Disney. Nel primo caso sono concentrati praticamente tutti
gli accorgimenti stilistici più importanti: rifiuto di
omogeneizzazione, esaltazione della fruizione multipla;
Germano Celant la considera (insieme alla Loyola School of
Law) un'acropoli contemporanea nella cui agorà si scatena
il caos allo stesso tempo creato e controllato
dall'architetto. Per quanto riguarda le strutture interne
basta riferirsi al nucleo vitale della casa: la
"living-kitchen-dining-room". Il recentissimo intervento a
Euro Disney (un complesso di 66 torri rivestite di
pannelli di acciaio colorato) è su basi completamente
differenti: prima di tutto lo sforzo di integrare un
complesso "contemporaneo" in una struttura semplicemente
"moderna"; in secondo luogo il ritorno ad un'architettura
vista come sfogo di colori (quasi la tavolozza di un
pittore) e di geometrie eccentriche.
Concludendo, e collegandosi così alla definizione
iniziale, Gehry rappresenta un unicum incredibilmente
completo: architetto, cliente, interprete, ricordando che
il costante riferimento a se stesso non è mai
interpretabile in una visione sterile e banalmente
narcisistica.
NOTA BIBLIOGRAFICA
G. Celant, "Architettura letteraria e pulsionale: Frank
Gehry" in: Artmakers, Feltrinelli 1984
L. Rubino, "Frank O. Gehry: finalmente un architetto che
interpreta se stesso" e "Verso un surrealismo
architettonico, verso un'architettura invisibile" in:
Frank O. Gehry special, Edizioni Kappa 1984
A. Vidler, "Opere recenti di Frank O. Gehry" e "Il
movimento nell'architettura di Frank Gehry" in: Casabella
ndeg. 553
G. Celant, "Il terremoto dell'architettura" e "La
progettazione della casualità" in: Casabella ndeg. 554
M. Bacher, "Considerazioni sulla ricostruzione dei centri
storici nella Repubblica Federale Tedesca" in: Abitare ndeg.
226
F. Bucci, "L'abilità artigianale nella lastra metallica:
il progresso nella costruzione" in: L'architettura ndeg. 392
S. Stempler, "Weekend con l'elicottero: nei dintorni di
New York, due case come fossero una sola" in:
Architectural Digest ndeg. 46
|