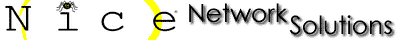|
Fin
da quando, alla metà del secolo scorso, lo storico Hubert Jedin ha
proposto di affiancare, al termine Controriforma,
la nozione di Riforma
cattolica,
il profondo rinnovamento dell'ideale di vita cristiana è stato
legato, negli studi, a una maturazione dottrinale intrinseca al mondo
cattolico scoppiata dopo lo scisma luterano .
Il
più grave attacco dei protestanti alla Chiesa di Roma è stata la
messa in discussione della purezza dell'ecclesia
primitiva e
della gerarchia delle fonti sacre, affidando la dottrina solo alla
nuda
parola
dei Padri. Riunitisi a Trento fin dal 1545, i cardinali sentono la
forte esigenza non solo di proporre politiche censorie contro le
ingannevoli interpretazioni delle fonti, ma di riappropriarsi in
primo luogo della storia del Cristianesimo e della Chiesa delle
origini. Un ruolo decisivo nei ragionamenti conciliari lo gioca il
continuo ricorso alla patristica, a quei capisaldi del Cristianesimo
che da un lato potevano permettere precise verifiche dottrinali ,
dall'altro consentivano di modellare il concetto di autenticità
della fede, da più parti considerato il più innovativo assunto
della religiosità controriformata. Non è autentico solo ciò che è
proprio della fonte stessa, come predicava Lutero; vi è anche una
autenticità
per tradizione,
perché inserita in una continuità di fede che è essa stessa
garanzia di verità .
Una
nuova classicità
Andando
di pari passo con le questioni dottrinali, la compagine protestante
arriva persino a rigettare il valore storico dei manufatti
architettonici della Chiesa di Roma. In tal senso, i cardinali del
Concilio riprendono le antiche argomentazioni, applicate fin dal
Concilio Niceno II (787), relative all'uso della materia
per avvicinare l'uomo a Dio .
Viene modellato il concetto di una ecclesia
semper renovanda,
di un Cristianesimo concepito come elemento fondante una nuova
cultura moderna, in cui la conoscenza delle prime architetture
cristiane risulta essenziale per opporsi «alle favole contro il
papato»
diramate dai novatori
religiosi.
Storici di rilievo, come Carlo Sigonio (1520-84), contaminano
l'eredità dell'Umanesimo con le necessità cultuali
controriformate, arrivando a plasmare i primi rudimenti di quella che
si potrebbe definire l'archeologia
cristiana .
Siamo di fronte a una nuova disciplina che mira a rivalutare le
antiquitates
cristiane in funzione apologetica, per dimostrare la supremazia del
Cristianesimo anche sotto il profilo storico-artistico .
È
stato Sisto V il più grande artefice del restauro
del culto cattolico negli anni post-conciliari .
Se da un lato, con la fondazione della Tipografia vaticana (1587),
contribuisce in modo determinante a rilanciare in chiave cattolica le
visioni patristiche (tutte in divina
concordanza
fra loro), dall'altro riorganizza la città di Roma partendo da
quel sistema di basiliche (S. Maria Maggiore e la corona delle altre
sei) già esistente nel Medioevo e ripristinato in
syderis formam .
Roma
torna ad essere fulcro di un nuovo centralismo papale, inaugurando un
moderno concetto di classicità. Sfogliando le pagine dei trattati
composti in quegli anni, è evidente la tendenza ad annoverare fra i
monumenti ‘classici' della capitale anche gli edifici di culto
paleocristiani; è sul finire del Cinquecento che, per la prima
volta, le “trecento chiese” della Roma cristiana sono poste sullo
stesso piano dei monumenti della Roma antica .
In questa ottica, mirata alla produzione di una «maniera anticamente
moderna, e modernamente antica» ,
vanno interpretate,
ad esempio, le affermazioni del Serlio che propone agli architetti di
“mescolare”, “mischiare”, “comporre” ,
perché talvolta, per dirla con Daniele Barbaro, «la bella
mescolanza diletta, et le cose che sono tutte ad un modo vengono in
fastidio» .
Scriveva
nel 1975 James Ackerman che Carlo Borromeo, con le sue Instructionum
Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae (1577),
non aveva fatto altro che adeguare all'edilizia ecclesiastica
«l'usanza stabilita nel decennio dopo il 1560 dai più importanti
architetti di quella generazione» . (Fig. 1)
 Fig. 1 – Frontespizio della prima edizione
Fig. 1 – Frontespizio della prima edizione
delle Instructionum Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae
di Carlo Borromeo (1577)
Cortesia di Francesco Del Sole
Anche se lo studioso ha poi in parte rettificato la propria posizione
,
è utile sottolineare che quel concetto di mescolanza,
presente nei coevi trattati di architettura come pratica di
contaminazione, è anche la chiave per comprendere l'innovatività
del trattato carolino. Il prototipo della Chiesa ideale immaginata
dal cardinale milanese si basa proprio sulla fusione fra le parti
selezionate di edifici della tradizione paleocristiana e le
innovazioni di volta in volta proposte dagli architetti. Si tratta di
una vera e propria dinamica operativa che si riflette anche nella
necessaria mescolanza
che deve intercorrere fra i compiti del vescovo e quelli
dell'architetto. Al primo compete la funzione di tenere ben
presenti le finalità spirituali dell'edificio ;
al secondo spetta il compito di fornire soluzioni architettoniche in
cui unica “unità di misura” è il fedele nella sua condizione di
fruitore .
Questo dualismo ricorre frequentemente nei capitoli delle
Instructiones,
dove il vescovo conclude la trattazione affidandosi al «di lui
parere». Per dirla con il Borromeo, quando si costruisce (o si
restaura) un edificio religioso è necessario fare riferimento «alle
valutazioni di architetti esperti in materia» e, al tempo stesso,
«all'antica
pietà e
religione dei fedeli […] che ben si palesarono nella costruzione
degli edifici sacri»
(Fig. 2).
 Fig. 2 - San Carlo e i principali edifici sacri
Fig. 2 - San Carlo e i principali edifici sacri
costruiti negli anni del suo episcopato
(Milano, Biblioteca Ambrosiana)
Cortesia di Francesco Del Sole
Le
Instructiones
caroline possono essere lette come una gigantesca opera di smontaggio
della fabbrica religiosa nelle sue parti, scendendo progressivamente
di scala .
Legandosi al recupero che il Concilio fa dell'esperienza
proto-cristiana, gli esempi ai quali guarda il Borromeo sono
innanzitutto le basiliche di Roma e Milano. Nel capitolo dedicato
alla posizione dell'edificio, il cardinale invita a scegliere un
sito isolato «nel modo stabilito dagli antichi istituti» ,
per evitare la contiguità con gli edifici civili. Poco oltre, nei
paragrafi dedicati all'impianto planimetrico della chiesa, afferma
che il vescovo dovrà affidarsi alla maestria dell'architetto,
anche se «a onor del vero, la pianta da preferire risulta quella
cruciforme, che ci viene tramandata sin dal tempo degli Apostoli,
così come è possibile vedere nelle principali Basiliche romane» ,
mentre quella circolare era stata adoperata in antico «per i templi
pagani; molto meno per il popolo cristiano» .
Che il Borromeo veda nell'architettura paleocristiana la
concretizzazione della nuova devozionalità controriformata lo
confermano alcune annotazioni come quelle usate a proposito delle
coperture, laddove afferma che «come l'impiego nelle Basiliche
Romane ci insegna, così la suggestione mistica ci porta a costruire
nelle chiese tetti a lacunari» .
Va precisato che le parole del cardinale non intendono essere
precetti da seguire rigidamente, ma riferimenti mediati, sperimentati
con successo nella diocesi milanese e indicati come modello. Proprio
a proposito del tetto della chiesa, nonostante l'invito a preferire
la soluzione a lacunari, aggiunge che «tuttavia non verrà visto
come inopportuno il costruire coperture voltate, prendendo spunto
dalle consuetudini del luogo» .
Soglie
reali e simboliche
Scelto
il sito e la pianta della chiesa, il portico antistante l'edificio
e i portali d'accesso sono le prime soglie
che
introducono il fedele nel grandioso palcoscenico liturgico. Dietro le
frasi dedicate al portico nelle Instructiones
(proporzionato all'ampiezza della chiesa, eretto su colonne di
marmo o pilastri di pietra o laterizio) ,
si leggono fra le righe figure e tipi propri dell'architettura
paleocristiana, chiamati in causa per dare al portale principale il
necessario rilievo, in quanto tramite «che introduce all'aula in
penombra» .
I portali devono essere architravati «come si vedono nelle Basiliche
più antiche […] dal momento che devono distinguersi da quelli
civili» .
Il Borromeo rimanda ancora allo «splendore delle sacre Basiliche»
affermando che «le imposte delle porte devono mostrare piuttosto la
solidità che l'ornamentazione». Aggiunge che «nella parte
superiore si può inserire una cornice decorosamente lavorata […]
così come è possibile apprezzare nelle antiche e più insigni
Basiliche milanesi» .
Il riferimento può essere anche ai portali delle basiliche romane,
«realizzati non in bronzo, bensì in argento, o almeno laminati
d'argento» .
Quanto al numero degli accessi, deve essere multiplo e possibilmente
dispari. La scelta di un numero corrispondente a quello delle navate
si giustifica con l'originaria funzione che prevedeva la
separazione dell'ingresso degli uomini da quello delle donne.
Questa separazione dei ruoli, che riguarda più in generale quella
fra il clero e i fedeli, si riverbera nella ripartizione degli spazi
ed è una delle maggiori eredità di matrice paleocristiana presenti
nell'edificio controriformato. Prima fra tutte, è bene ricordare
la necessità di prevedere l'assito per dividere la chiesa,
descritto minuziosamente in un intero capitolo .
Collocato sull'asse principale dell'edificio,
è da
impostare a partire dalla porta principale sino all'ingresso della
cappella maggiore
«in
modo che la chiesa sia divisa a metà […] secondo un'antica
consuetudine, testimoniata dal beato Crisostomo, che vede gli uomini
separati dalle donne» .
Doveva essere alto circa cinque cubiti e avere sezioni abbassabili in
corrispondenza del pulpito (o dell'ambone) e ove fosse necessario
seguire una parte della cerimonia che si svolge nel settore
opposto.
L'aula
è delineata come un percorso che «scandisce l'itinerario
dell'anima»
con l'obiettivo di dar vita a un uomo nuovo, inteso come tempio di
Dio, «chiesa di pietre vive» .
Questa visione, alla base delle Instructiones,
va ricercata nella strutturazione complessiva dello spazio liturgico,
nel rapporto dialettico tra navata e presbiterio, tra chiesa e
piazza, tra esterno e interno. Lo spazio sacro deve essere una linea
di tensione verso il sacrario. Gli altari, che fino ad allora erano
stati posti «sotto pulpiti o cantorie, dove si suoni l'organo o si
legga il Vangelo, […] tra pilastri e colonne» ,
devono essere eliminati del tutto, per realizzare «un percorso
rettilineo che non sopporta interruzioni» .
Sfogliando le pagine delle Instructiones,
ci si accorge che gli elementi architettonici dell'intero edificio
sono descritti secondo una precisa gerarchia, scandita dall'utilizzo
di vere e proprie soglie
- reali
e simboliche - che guardano alla tradizione medievale. Il fedele è
un semplice spettatore; deve partecipare alla celebrazione
eucaristica dal
basso
e
da lontano,
limitato da barriere fisiche e studiati rialzi dei piani. Elementi di
forte rilevanza liturgica come l'altare, il tabernacolo e il
battistero diventano luoghi quasi inaccessibili, protetti da cancelli
che permettono la sola visione da parte del fedele, sempre a debita
distanza. Le cappelle, compresa quella maggiore, devono essere
protette con inferriate o balaustre in marmo o in pietra .
Lo stesso dicasi per il coro che deve essere «separato dalla parte
della chiesa dove stanno i fedeli e chiuso da cancelli, come da
antico costume e per ragioni di disciplina» .
Qualora lo spazio non dovesse permetterlo, il vescovo dovrà fare in
modo «di tenere la folla a una certa distanza dal sacerdote che
celebra» .
Queste
soglie
fisiche rispondono non solo all'esigenza pratica di mettere ordine
all'interno dell'assemblea liturgica, ma di sottolineare le
differenze gerarchiche, riabilitando il ministero sacerdotale
profondamente messo in discussione dalla dottrina protestante. In
questa stessa ottica va interpretata l'attenzione riservata ai
gradini e ai diversi piani nei quali si articola lo spazio sacro,
riflesso della struttura piramidale in cui è organizzata l'intera
societas
christiana.
Fin
dal capitolo dedicato all'ubicazione della chiesa, il Borromeo
ricorda quanto sia importante che l'edificio sorga «in una
posizione alquanto elevata […] così che vi si acceda per meno di
tre gradini, cinque al massimo» .
Il nono capitolo è interamente dedicato a quest'argomento. Egli
chiede all'architetto di realizzare una gradinata esterna «ampia
in proporzione alle dimensioni della chiesa» prevedendo, ogni tre o
cinque gradini, un piano di calpestio più largo per una salita
comoda. Anche nel capitolo relativo all'altare maggiore sono
fornite indicazioni sul pavimento che «sarà più alto rispetto al
suolo della chiesa […] di otto once almeno e al massimo di un
cubito» .
Emblematica, sotto questo aspetto, è la risistemazione operata da
Pellegrino Tibaldi, l'architetto di fiducia del Borromeo, nel Duomo
di Milano .
In linea assiale, la basilica tibaldiana presenta la navata riservata
ai fedeli; più in alto, il coro senatorio riservato alle autorità
civili; infine, ancor più elevato, il presbiterio con l'altare
(Fig. 3).
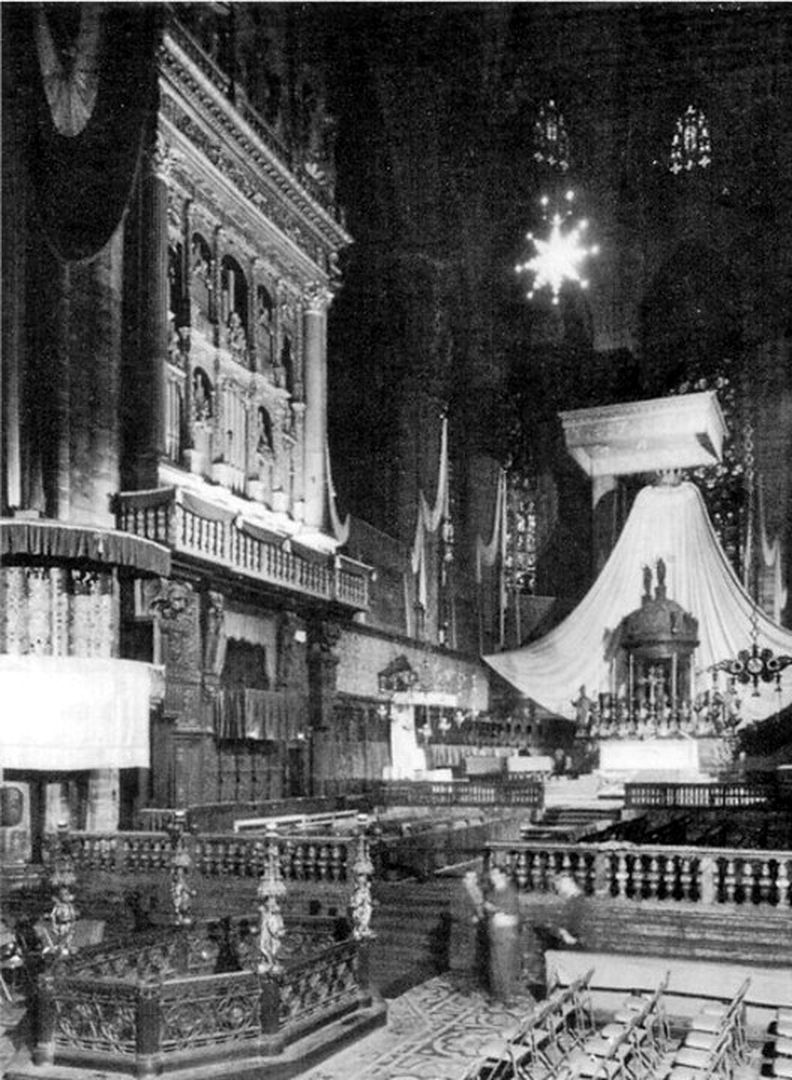 Fig. 3 – Foto storica della zona presbiteriale
Fig. 3 – Foto storica della zona presbiteriale
del Duomo di Milano realizzata
secondo le istruzioni di Carlo Borromeo
Cortesia di Francesco Del Sole
La
netta divisione del presbiterio, su un piano più elevato rispetto
alla navata, è l'accorgimento che, più di ogni altro, è lo
specchio dell'intera riforma carolina. La liturgia, da sempre
condizionata dal rapporto fra navata e presbiterio, è stata
profondamente innovata dal Borromeo nelle modalità di ripartizione
degli spazi, che influenzano profondamente «la norma e la forma, in
maniera che siano conformi ai criteri indicati dai Padri circa la
costruzione […] dell'edificio» .
Fra
norma ed erudizione
A
partire dal 1577 le
Instructiones
si diffondono nel mondo cattolico e le ristampe si susseguono almeno
fino alla fine del Seicento .
L'attenzione riservata dal Borromeo all'architettura delle
basiliche paleocristiane sarà un tema centrale anche nelle varianti
periferiche del trattato carolino. L'esempio forse più eclatante
sono i due volumi che, fra il 1686 e il 1688, sono dati alle stampe
per volere del vescovo di Benevento Vincenzo Maria Orsini, futuro
papa Benedetto XIII: la Antica
Basilicografia
di Pompeo Sarnelli e il Rettore
ecclesiastico
di Marcello Cavalieri.
La
Antica
Basilicografia
tenta di ricostruire idealmente, tramite un uso ‘spericolato'
delle fonti, gli spazi dell'edificio-chiesa primitivo rifacendosi
alla basilica di età paleocristiana. Nella chiesa delle origini, di
cui l'autore propone una ricostruzione grafica ,
Sarnelli individua l'unico modello proponibile per un edificio
sacro, opponendo alla «sconcertante mutevolezza delle forme la
sicura uniformità del tipo»
(Fig. 4).
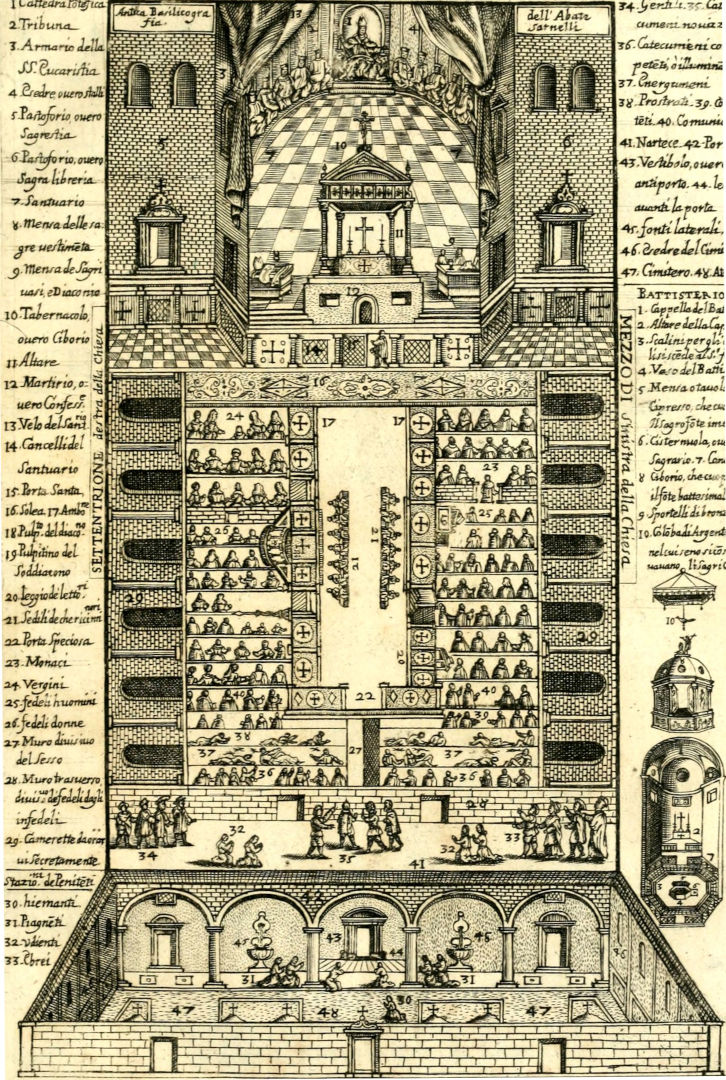 Fig. 4 - Modello di Basilica paleocristiana
Fig. 4 - Modello di Basilica paleocristiana
(da P. Sarnelli, Antica Basilicografia, 1686)
Cortesia di Francesco Del Sole
L'architettura, in questo caso, non prende avvio dal dialogo fra il
vescovo e l'architetto, ma solo dall'auctoritas
del passato ricostruito pezzo per pezzo con grande ostinazione. Se i
primi tempi dell'episcopato orsiniano a Benevento permettono una
certa riflessione erudita sull'architettura religiosa, nel 1688 si
avverte l'urgenza di passare alla cruda operatività dopo il
terremoto che colpisce la città riducendo in macerie molti edifici
sacri. Con un nuovo spirito l'Orsini si rivolge al padre Marcello
Cavalieri commissionandogli la stesura del Rettore
ecclesiastico
che, al contrario della Basilicografia,
si contiene «nei limiti di una nuda e letterale istruzione» .
Non è necessario, secondo il Cavalieri, compiere ragionamenti
eruditi sulla primitiva chiesa cristiana perché era stato proprio
Carlo Borromeo ad aver «accomodato» le antiche pratiche alle
«costumanze moderne» e ai «dettami dell'architettura».
Questi
due volumi, stampati a due anni di distanza, sono la prova di quanto
stava accadendo nella produzione letteraria post-tridentina, composta
da opere che oscillano fra una ricerca erudita e la praticità del
prontuario parrocchiale utile ad accomodare le «chiese diroccate e
rimettere in piè la disciplina» .
Proprio a metà strada fra queste due necessità si colloca il
‘revival
paleocristiano' proposto dal Borromeo, che non è soltanto un
richiamo a un passato letto in chiave mitica, ma un vero e proprio
modello sicuro e insindacabile .
A un primo approccio, le pagine delle Instructiones
possono sembrare un astratto intendimento, frutto di ricerche erudite
condotte nell'ambito delle ‘memorie della Santa Chiesa Romana';
lo studio approfondito delle norme caroline (e delle loro varianti
locali) fa invece comprendere quanto il Borromeo abbia compiuto
un'opera di demitizzazione delle antiche auctoritates
cristiane, eliminando i complessi intrecci della simbologia medievale
e riconducendo la pratica architettonica all'interno di una
tradizione attenta alle funzioni pratiche dell'edificio sacro. Le
Instructiones
costituiscono dunque una delle fonti normative attraverso cui
studiare l'architettura religiosa del XVII e XVIII secolo, che si
nutre di non pochi rimandi medievali in un'ottica di ordine e
disciplina della liturgia e dello spazio.
NOTE
BIBLIOGRAFIA
ACKERMANN
1975
James
ACKERMANN,
Il contributo dell'Alessi alla tipologia della chiesa
longitudinale,
in Galeazzo
Alessi e l'architettura del Cinquecento,
Genova, Poleggi, 1975.
ACKERMANN
1986
James
ACKERMANN, Pellegrino
Tibaldi, San Carlo Borromeo e l'architettura ecclesiastica del loro
tempo,
in San
Carlo e il suo tempo
(Atti del convegno internazionale nel IV centenario dalla morte -
Milano, 21-26 maggio 1984), Roma, Ediz.
di Storia e Letteratura, 1986, vol. I.
ASOR
ROSA 1974
Alberto
ASOR ROSA, La
cultura della Controriforma,
Bari, Laterza, 1974.
BARBARO
1556
Daniele
BARBARO, Vitruvius.
De Architectura,
Venezia, De Franceschi, 1556.
BARBIERI
2018
Lara
Maria Rosa BARBIERI, Carlo
Borromeo, Gabriele Paleotti e Trento: Il Discorso intorno alle
immagini sacre,
in Religione,
cerimoniale e società nelle terre milanesi dell'età moderna,
atti dei convegni di Milano (2013-2015), a cura di Danilo Zardin,
Fabrizio Pagani, Carlo Alessandro Pisoni, Germignaga, Magazzeno
Storico Verbanese, 2018, pp. 125-137.
BAROCCHI
1962
Paola
BAROCCHI, Trattati
d'arte del Cinquecento,
III, Bari, Laterza, 1962, pp. 1-123.
BASILE
BONSANTE 1982
Mariella
BASILE BONSANTE, Architettura
e committenza religiosa: l'Antica Basilicografia di Pompeo
Sarnelli,
in «Archivio storico pugliese», anno XXXV, fasc. I-IV, 1982, pp.
205-235.
BENATI,
REPISHTI 2010
Giulia
BENATI, Francesco REPISHTI, Carlo
Borromeo, Pellegrino Tibaldi e la trasformazione interna del Duomo di
Milano: nuove acquisizioni critiche e documentarie
(Atti della Giornata di studi, Milano, 10 giugno 2010), Milano,
Veneranda Fabbrica del Duomo, 2010.
BENEDETTI
1984
Sandro
BENEDETTI, Fuori
dal classicismo. Sintetismo, tipologia, ragione nell'architettura
del Cinquecento,
Roma, Bonsignori, 1984.
BLUNT
1940
Antony
BLUNT, Artistic
Theory in Italy, 1450-1600,
Oxford, 1940, pp. 127-132; ed. it. Le
teorie artistiche in Italia dal Rinascimento,
Torino, Einaudi, 1966.
BORROMEO
1577
Carlo BORROMEO,
Instructionum
fabricae et supellectilis ecclesiasticae,
Milano 1577, trad. di M. Marinelli, Città del Vaticano, Casa
Editrice Vaticana, 2000.
CAVALIERI
1688
Marcello
CAVALIERI, Il
Rettore ecclesiastico istruito sulle regole della fabbrica e delle
suppellettili…,
Napoli, Fusco editore 1688.
DEL SOLE
2022
Francesco DEL SOLE, Architectural Instructions in Italy between the 16th and 18th Centuries, in «Athens Journal of Architecture», Volume 8, Issue 4, October 2022, pp. 359-378
FAGIOLO
1976
Marcello
FAGIOLO, La
Roma di Sisto V. Le matrici del policentrismo,
in «Psicon. Rivista internazionale di Architettura», n. 8-9, 1976,
pp. 24-39.
FAGIOLO,
MADONNA 1985
Marcello
FAGIOLO,
Maria
Luisa
MADONNA,
a cura di, Roma
sancta. La città delle basiliche. L'arte degli anni santi, il
significato del giubileo,
Roma, Gangemi, 1985.
FAGIOLO,
MADONNA 1993
Marcello
FAGIOLO,
Maria
Luisa
MADONNA,
a cura di, Roma
di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco,
Roma, De Luca, 1993.
GATTI
PERER 1980
Maria
Luisa GATTI PERER, Prospettive
nuove aperte da S. Carlo nelle sue Norme per l'Arte Sacra,
in «Atti dell'Accademia di S. Carlo», Milano, 1980, pp. 15-33.
GATTI
PERER 1986
Maria
Luisa GATTI PERER,
Progetto
e destino dell'edificio sacro dopo S. Carlo,
in San
Carlo e il suo tempo
(Atti del convegno internazionale nel IV centenario dalla morte -
Milano, 21-26 maggio 1984), Roma, Ediz.di Storia e Letteratura, 1986,
vol. I, pp. 611-631.
GRASSI
1966
Liliana
GRASSI, Provincia
del Barocco e del Rococò.
Proposta
di un lessico biobibliografico di architettura in Lombardia,
Milano, Ceschina, 1966.
MAINARDI
1931
Luigi
MAINARDI, La
contesa per la sedia dei governatori spagnoli nel presbiterio della
nostra metropolitana,
in «Ambrosius», 7, 12, 1931, pp. 348-354.
PAYNE
1998 Creativity
Alina
PAYNE, Creativity
and bricolage in architectural literature of the Renaissance,
in «RES. Journal of Aesthetics and Anthropology», 1998, pp. 20-38.
PAYNE
1998 Mescolare
Alina
PAYNE, Mescolare,
composti and Monsters in Italian Architectural Theory of the
Renaissance, in
Disarmonia, brutezza e
bizzarria nel Rinascimento,
Firenze, Franco Cesati, 1998, pp. 271-89.
PRODI
1980
Paolo
PRODI, Il
binomio jediniano ‘riforma cattolica e controriforma' e la
storiografia italiana,
in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VI,
1980, pp. 85-98.
RUSSO
2008
Valentina
RUSSO, Architettura
nelle preesistenze tra Controriforma e barocco. ‘Istruzioni',
progetti e cantieri nei contesti di Napoli e Roma,
in Verso
una storia del restauro. Dall'età classica al primo Ottocento,
Firenze, Alinea, 2008, pp. 139-206.
SACHET
2018
Paolo
SACHET, La
chiesa davanti ai Padri: Erasmo, gli umanisti riformati e la
patristica cattolica romana fra Rinascimento e Controriforma,
in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 2018, n. 2, anno
54, pp. 389-420.
SÉNÉCAL
2000
Robert
SÉNÉCAL, Carlo
Borromeo's Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae
and its origins in the Rome of his time,
in «Papers of the British School at Rome», vol. 68, 2000, pp.
241–267.
VARAGNOLI
2005
Claudio
VARAGNOLI, Metamorfosi
degli déi, metamorfosi del restauro,
in Memoria
e restauro dell'architettura. Saggi in onore di Salvatore
Boscarino,
, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 291-300
VASARI
1568
Giorgio
VASARI, Le
vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori,
Firenze, Giunti, 1568.
VON
PASTOR 1943
Ludwig
VON PASTOR, Storia
dei papi,
1943
|