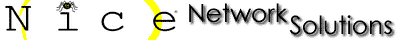|
|
Abstract
L'architettura ha evoluto il suo
linguaggio in risposta ai cambiamenti
sociali, economici e tecnologici, passando
dalla razionalizzazione industriale a un
modello più fluido e interattivo. Oggi,
nel contesto della società
dell'informazione e della transizione
ecologica, sta emergendo come un sistema
dinamico in grado di integrare nuove
tecnologie e affrontare le sfide
ambientali.
Metápolis propone
un'architettura come pratica relazionale
e processuale, mentre la rewild
architecture
promuove la coesistenza e la
rigenerazione ecologica, unendo
l'ambiente costruito e naturale.
L'intelligenza artificiale (IA)
sta rivoluzionando il settore, permettendo
la progettazione generativa e la creazione
di spazi adattivi che rispondono alle
esigenze ecologiche, sociali e
comportamentali. In questo nuovo
paradigma, l'architetto non è più visto
come creatore di forme statiche, ma come
facilitatore di relazioni ecologiche e
tecnologiche, promuovendo la simbiosi tra
natura e tecnologia. L'integrazione
dell'IA con principi ecologici apre la
strada a un'architettura resiliente e
sostenibile, capace di rispondere alle
sfide globali del XXI secolo, contribuendo
attivamente alla rigenerazione dei sistemi
ecologici.
La
convergenza
tra tecnologia e natura, attraverso la
"simbiosi aumentata", sta ridisegnando
l'architettura contemporanea, sfidando
la separazione tra l'ambiente costruito
e quello naturale. Esempi come il Living
Architecture Project
mostrano come la tecnologia, l'IA e
l'ecologia possano trasformare gli
edifici in organismi viventi che si
adattano continuamente all'ambiente. La
progettazione sta evolvendo verso una
visione sistemica, con la figura
dell'"ecologo digitale", che integra
scienze naturali e tecnologie avanzate.
Questo approccio olistico cambia anche
la formazione degli architetti,
preparandoli a creare soluzioni
innovative per le sfide ecologiche e
climatiche. L'architettura del futuro
sarà così un agente di cambiamento
ecologico e sociale, capace di
rigenerare e preservare i sistemi
ecologici globali.
|
|
|
Introduzione
L'architettura,
espressione
materiale della cultura umana, ha sempre agito
come interfaccia tra innovazione tecnologica e
trasformazioni sociali. Questa relazione, che
Lewis Mumford definì “determinismo tecnologico” ,
descrive come le innovazioni tecniche non solo
influenzino ma modellino nuovi spazi e linguaggi
architettonici.
L'era
industriale, segnata dalla meccanizzazione e
dall'urbanizzazione, incrinò i modelli
architettonici tradizionali. La rivoluzione del
XIX secolo introdusse materiali come ferro,
acciaio e cemento armato, rendendo obsoleti i
sistemi costruttivi storici .
A questa rottura tecnologica si affiancarono
profondi cambiamenti sociali: l'ascesa della
classe operaia, la concentrazione urbana, la
standardizzazione produttiva.
In tale
contesto nacque il movimento moderno, che sviluppò
un linguaggio coerente con i nuovi paradigmi
industriali. Le Corbusier formulò i “Cinque punti
dell'architettura” (1926), traducendo in chiave
spaziale i principi della produzione seriale: pilotis, tetto-giardino,
pianta libera, finestra a nastro e facciata
libera. L'edificio come “macchina per abitare”
sintetizzava un'idea di architettura efficiente e
razionale.
Walter
Gropius, con la Bauhaus, promosse il
concetto di Gesamtkunstwerk industriale: una
sintesi tra design, architettura e produzione,
basata su prefabbricazione e standardizzazione per
rendere l'architettura accessibile .
Mies van der Rohe portò questa visione
all'essenziale con il suo less is more, valorizzando
struttura, spazio e luce in opere come il
Padiglione di Barcellona (1929) e l'IIT di
Chicago.
 Fig. 1 – MIES VAN DER ROHE, Padiglione di Barcellona, 1929
Fig. 1 – MIES VAN DER ROHE, Padiglione di Barcellona, 1929
(foto © di S. Rugino, cortesia di S. Rugino)
Nonostante il successo, il modernismo
presentava contraddizioni interne. L'approccio
deterministico, che subordinava la progettazione
alle logiche produttive, mostrava presto i suoi
limiti:
-
riduzionismo funzionale: l'abitare
ridotto a funzioni elementari ignorava la
ricchezza dell'esperienza umana e la dimensione
simbolica dello spazio;
-
universalismo astratto: la ricerca di
soluzioni valide ovunque annullava le
specificità locali:
-
separazione natura-cultura: la rottura
con l'ambiente naturale privilegiava il
controllo tecnologico a scapito dell'ecologia;
Negli anni ‘60, del novecento, queste
criticità divennero evidenti. Jacobs denunciò
l'impatto disgregante dell'urbanistica modernista,
mentre Alexander propose metodi progettuali più
organici e partecipativi.
Con
l'avvento della società post-industriale — dominata da
servizi, informazione e reti digitali — i modelli
modernisti apparvero inadeguati. La rigidità
spaziale del modernismo mal si adattava a una
realtà fluida e in continua evoluzione. A partire
dagli anni ‘90, del novecento, l'architettura
cominciò a orientarsi verso modelli più
flessibili, interattivi e adattivi, capaci di
rispondere alla complessità contemporanea.
Il
manifesto Metápolis, pubblicato nel
1999 da Manuel Gausa e altri membri dell'Institute
for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), rappresenta
una svolta teorica nel passaggio da
un'architettura modernista, fondata su logiche
funzionaliste e universaliste, a un approccio
relazionale, processuale e adattivo. Questo
documento anticipa la necessità di una
progettazione non più orientata a oggetti statici,
ma a sistemi complessi in continua interazione con
le dinamiche socio-tecnologiche contemporanee.
Come afferma Gausa, non si tratta più di
progettare forme finite, ma di organizzare sistemi
aperti, flessibili, interattivi, capaci di
evolvere nel tempo .
Tale
visione prefigura un'architettura pensata come
infrastruttura cognitiva, non semplicemente
materiale, capace di incorporare l'informazione
come componente essenziale del progetto. In questo
senso, Metápolis anticipa molte
delle istanze che oggi trovano concretizzazione
nell'integrazione dell'intelligenza artificiale
nei processi progettuali. Il passaggio dal
paradigma della forma a quello del processo, e da
quello della tipologia a quello del comportamento,
prepara il terreno a un'architettura
computazionale in grado di apprendere, simulare,
adattarsi e reagire al contesto in tempo reale.
Con
l'introduzione dell'IA nei flussi progettuali,
l'architettura acquisisce nuove capacità
predittive e adattive. Algoritmi di apprendimento
automatico, simulazioni generative e sistemi
parametrici permettono di gestire la complessità
ambientale, sociale e tecnologica in modo
dinamico. Come sostiene Antoine Picon,
l'architettura digitale inaugura una “nuova
episteme progettuale”, dove il progetto non si
limita più a una rappresentazione formale della
volontà dell'architetto, ma diventa una
piattaforma operativa che media tra dati, vincoli
e intenzioni .
In
questo quadro, l'IA non rappresenta solo uno
strumento di ottimizzazione, ma un agente
epistemologico che modifica la natura stessa del
progetto. L'architetto assume un nuovo ruolo: da
autore formale a facilitatore di sistemi
intelligenti e relazionali, capace di orchestrare
processi complessi piuttosto che imporre soluzioni
univoche. Come osserva Mario Carpo (2021), il
progetto architettonico, nell'epoca
dell'algoritmo, non è più un'interpretazione del
mondo, ma un'interazione con esso .
In
continuità
con la visione delineata dal Metápolis
Dictionary
of Advanced Architecture, l'architettura
computazionale
e l'intelligenza artificiale (IA) convergono verso
una nuova concezione sistemica del progetto. In
questa prospettiva, l'ambiente costruito non è più
uno sfondo inerte o un mero contenitore
funzionale, ma un agente attivo che interagisce
dinamicamente con i sistemi ecologici e le
trasformazioni sociali. Questo passaggio segna una
svolta epistemologica profonda: si abbandona una
concezione dell'architettura come forma autonoma e
finita, per abbracciare un modello in cui lo
spazio è inteso come parte di “un'ecologia
dell'informazione” ,
continuamente alimentata da flussi di dati,
interazioni e adattamenti.
La
progettazione, in questo contesto, non può più
essere concepita come un atto isolato, definito
una volta per tutte. Diventa un processo aperto,
dinamico e interattivo, che deve misurarsi con l'eterogeneità e la complessità
dei sistemi viventi. L'architettura deve quindi
essere sostenibile, resiliente e sensibile ai
segnali provenienti dall'ambiente naturale, dalle
comunità locali e dalle infrastrutture
tecnologiche. Le tecniche di IA — come il machine learning, l'ottimizzazione
generativa e le simulazioni ambientali in tempo
reale — offrono strumenti per progettare spazi
capaci di apprendere e adattarsi, rispondendo in
modo proattivo ai cambiamenti climatici, all'uso
energetico, ai flussi umani e alla biodiversità.
In
parallelo, si afferma il paradigma della rewild
architecture,
che propone un ribaltamento della visione
antropocentrica moderna, promuovendo invece una
coabitazione attiva tra esseri umani e non umani.
In questa prospettiva, l'architettura non è più
barriera o dominio, ma strumento di riconnessione
ecologica. Si configura come dispositivo
relazionale in grado di facilitare interazioni
simbiotiche tra differenti forme di vita e i loro
habitat, sia naturali che costruiti. L'architetto,
quindi, non è più un autore solitario che impone
un ordine formale, ma diventa un facilitatore
di
ecologie,
capace di orchestrare relazioni complesse tra
ambiente, tecnologia e cultura.
L'incontro
tra
IA e rewilding impone dunque una
nuova grammatica progettuale, in cui
l'intelligenza algoritmica si integra con la
sensibilità ecologica. Non si tratta semplicemente
di digitalizzare l'ecologia o di rendere “più
verdi” gli edifici, ma di concepire ambienti
costruiti come sistemi viventi, adattivi e
rigenerativi. Un'architettura intelligente che
evolve con i suoi contesti, capace di contribuire
attivamente al riequilibrio ecologico e alla
resilienza dei territori.
Questa
convergenza apre una riflessione profonda sul
ruolo del progetto oggi: qual è la funzione
dell'architetto in un mondo in cui l'IA partecipa
ai processi decisionali? Come possiamo integrare
dati ecologici, climatici e comportamentali in
tempo reale nel processo progettuale? E
soprattutto, come progettare ambienti capaci di
rispondere alle trasformazioni sociali e
ambientali non con rigide soluzioni tipologiche,
ma con adattabilità, sensibilità e responsabilità?
In
conclusione, il presente saggio esplora l'ipotesi
che l'integrazione tra intelligenza artificiale e
rewild
architecture
possa generare un nuovo paradigma progettuale. Non
più un'architettura intesa come artefatto statico,
ma come organismo vivo, dotato di intelligenza
distribuita e responsabilità ecologica. Una
visione in cui teoria, tecnologia ed etica si
intrecciano per affrontare le sfide complesse del
XXI secolo, trasformando il progetto in un atto
relazionale, rigenerativo e consapevole.
In
questo contesto emergente, prende forma il
concetto di simbiosi aumentata, in cui ambienti
naturali, sistemi artificiali e intelligenze –
umane e non umane – coevolvono in modo sinergico.
L'architettura non è più separata dall'ambiente,
ma lo potenzia, lo interpreta e lo rigenera
attraverso sistemi interattivi e adattivi che
amplificano la biodiversità e favoriscono nuovi
equilibri ecosistemici. Si tratta di un cambio di
prospettiva profondo: il progetto non agisce sulla natura, ma con la natura, in un
dialogo continuo tra materia, dati e vita.
All‘interno di questo
orizzonte, l'architetto assume il ruolo di
“ecologo digitale”, un mediatore tra intelligenze
artificiali, processi naturali e bisogni umani.
Una figura capace di tradurre i flussi informativi
complessi in strategie spaziali sostenibili, di
progettare con algoritmi ma anche con empatia, di
leggere il territorio come una rete vivente da
ascoltare, tutelare e rigenerare. L'ecologo
digitale non si limita a produrre forme, ma
coltiva relazioni: tra specie, tecnologie e
culture, orientando il progetto verso un futuro
più simbiotico, inclusivo e resiliente.
Discontinuità
post-industriale
e nuovi paradigmi computazionali
La
transizione dalla società industriale a quella
post-industriale ha trasformato profondamente i
modelli di produzione, l'organizzazione del lavoro
e la concezione dello spazio. Daniel Bell
individua tre tratti distintivi di questa nuova
condizione: il passaggio da un'economia centrata
sui beni materiali a una basata sui servizi, il
ruolo centrale della conoscenza teorica come leva
dell'innovazione e l'emergere di tecnologie
intellettuali per la risoluzione di problemi
complessi .
Questi
mutamenti danno origine a nuove spazialità,
analizzate da Manuel Castells nel concetto di
“spazio dei flussi” , in
contrapposizione allo “spazio dei luoghi” tipico
della società industriale. Lo spazio
post-industriale non si organizza più attorno alla
prossimità fisica, ma attraverso reti globali di
interazione istantanea. La struttura urbana si
riconfigura in una rete di nodi interconnessi,
come centri finanziari e infrastrutture
tecnologiche, frequentati da una nuova élite
manageriale globale che abita spazi standardizzati
e deterritorializzati.
Parallelamente,
Richard
Sennett osserva come il nuovo capitalismo, fondato
su flessibilità, customizzazione e lavoro
cognitivo, richieda ambienti molto diversi da
quelli pensati dal modernismo .
La rigidità funzionale e la compartimentazione
tipiche dell'era industriale si rivelano
inadeguate a supportare forme di lavoro basate
sulla collaborazione, sull'innovazione diffusa e
sulla mobilità.
La
smaterializzazione produttiva ridefinisce le
logiche spaziali: le strutture organizzative
diventano modulari e ricombinabili, richiedendo
ambienti adattabili; l'innovazione emerge
dall'interazione tra competenze diverse, favorendo
spazi che facilitano lo scambio informale e la
creatività; la virtualizzazione di molte
attività
riduce la necessità di funzioni spaziali rigide,
aprendo a modelli ibridi fisico-digitali.
Il
collettivo
Metápolis
sintetizza queste trasformazioni, delineando un
paradigma progettuale per la società
dell'informazione che propone un'architettura
intesa come sistema aperto e trasformabile, capace
di accogliere usi imprevisti e mutazioni future.
Il progetto non definisce più uno stato finale, ma
governa processi evolutivi in continua
trasformazione, ponendo l'accento sulle relazioni
con il contesto urbano, sociale e ambientale. La
tecnologia digitale non è più un elemento
decorativo, ma parte strutturale, consentendo agli
edifici di raccogliere, elaborare e rispondere a
dati ambientali e d'uso.
 Fig. 2 – ENRIC RUIZ GELI, Media - TIC, Barcellona, 2009
Fig. 2 – ENRIC RUIZ GELI, Media - TIC, Barcellona, 2009
(da https://www.archdaily.com/49150/media-tic-enric-ruiz-geli)
Foto cortesia di S. Rugino
Questa
visione rappresenta una profonda svolta
epistemologica per l'architettura, segnando il
passaggio da una disciplina tradizionalmente
ancorata alla rappresentazione geometrica statica
a un campo incentrato sull'elaborazione
informazionale dinamica e complessa. Oxman
definisce questa trasformazione come il passaggio
al “design computazionale” ,
una nuova pratica progettuale che si fonda su
logiche evolutive, algoritmiche e performative. In
altre parole, l'architettura non è più solo
questione di forme da disegnare e riprodurre, ma
di processi da simulare, ottimizzare e far
evolvere continuamente, grazie all'interazione con
dati e sistemi digitali.
Un
esempio concreto di questa evoluzione è
l'integrazione degli algoritmi genetici,
sviluppati da pionieri come John Frazer (1995) e
Karl Chu (2006). Questi algoritmi si ispirano ai
meccanismi della selezione naturale e
dell'evoluzione biologica per generare morfologie
architettoniche complesse e adattative. Attraverso
simulazioni evolutive, parametri progettuali
codificati matematicamente – i cosiddetti “genotipi” – producono
configurazioni spaziali, i “fenotipi”, che vengono
poi valutate in base a criteri di performance
definiti, come efficienza energetica, stabilità
strutturale o funzionalità. Il sistema applica
processi di selezione, mutazione e crossover, analoghi a quelli
biologici, per creare soluzioni innovative e
ibride che sfuggono alla rigidità del progetto
tradizionale, permettendo così di esplorare un
vasto spazio di possibilità progettuali.
Parallelamente,
l'avanzamento
del machine
learning
e delle reti neurali sta trasformando
ulteriormente il processo progettuale, facendone
una pratica predittiva e data-driven. Questi algoritmi
sono in grado di analizzare enormi dataset che includono
informazioni climatiche, comportamentali e urbane,
per ottimizzare la disposizione degli spazi in
modo che rispondano efficacemente ai pattern d'uso
reali, anticipino variazioni ambientali e
migliorino il comfort e la sostenibilità. La
manutenzione predittiva, resa possibile dal
monitoraggio continuo tramite sensori
intelligenti, contribuisce a prevenire guasti
strutturali o impiantistici, estendendo la durata
e l'efficienza degli edifici.
Il
contributo di Achim Menges con il concetto di “material
computation”
aggiunge un ulteriore livello di complessità a
questa trasformazione. In questo approccio, le
proprietà fisiche e comportamentali dei materiali
non sono più viste come semplici elementi passivi
da modellare, ma come componenti attivi del
processo computazionale .
Attraverso simulazioni sofisticate è possibile
modellare fenomeni come deformazioni,
invecchiamento e interazioni ambientali,
permettendo di ottimizzare la distribuzione dei
materiali e delle forze in modo topologico, ma
anche di progettare elementi architettonici capaci
di rispondere dinamicamente agli stimoli esterni,
come variazioni di temperatura o umidità. Questo
approccio trasforma l'architettura in un organismo
“vivente”, che interagisce attivamente con il
proprio ambiente.
L'insieme
di
queste metodologie dà origine a un'architettura
cognitiva, intesa come un sistema complesso e
intelligente che percepisce l'ambiente circostante
attraverso reti sensoriali integrate, elabora
grandi quantità di dati per identificare pattern e
tendenze, e si adatta dinamicamente ai cambiamenti
esterni. Questo processo di apprendimento continuo
e feedback
loop
migliora progressivamente le performance degli
spazi, permettendo una progettazione che non è mai
definitiva, ma sempre in evoluzione.
Questa profonda trasformazione non investe
solo gli strumenti e i linguaggi dell'architettura,
ma ne ridefinisce l'essenza stessa, incidendo in
modo radicale sul ruolo dell'architetto all'interno
della società contemporanea. L'architetto non è più
(o non può più essere) semplicemente il creatore di
forme statiche, chiuse e autoreferenziali, ma
diventa un regista di complessità, un facilitatore
di relazioni, chiamato a operare in un contesto in
continua evoluzione, segnato da crisi ambientali,
trasformazioni urbane, emergenze climatiche e
mutamenti socio-culturali.
In questo nuovo scenario, l'architetto
assume un ruolo interdisciplinare e sistemico: deve
saper leggere e interpretare dati complessi
(ambientali, sociali, energetici, tecnologici),
integrare competenze provenienti da ambiti
differenti (come l'ingegneria, la biologia,
l'informatica o le scienze sociali) e orchestrare
processi progettuali flessibili, adattivi e aperti
all'imprevisto. L'opera architettonica non è più
intesa come un risultato definitivo, ma come un
sistema dinamico, capace di evolvere nel tempo, di
dialogare con l'ambiente circostante e di interagire
con chi lo abita.
L'architettura diventa così un organismo
intelligente, un'infrastruttura sensibile e
responsiva, dotata di capacità di apprendimento
(grazie anche all'uso di tecnologie digitali,
sensori, intelligenza artificiale e analisi dei
dati), in grado di contribuire attivamente alla
rigenerazione ecologica e sociale dei territori.
Essa si configura come un'interfaccia tra natura e
cultura, tra innovazione tecnologica e tradizione
locale, tra esigenze individuali e bisogni
collettivi.
 Fig. 3 – JEAN NOUVEL, Musée du Quai Branly, Parigi, 2009
Fig. 3 – JEAN NOUVEL, Musée du Quai Branly, Parigi, 2009
(foto © S. Rugino, cortesia di S. Rugino)
In questo contesto, progettare significa
prendersi cura: della terra, delle persone, delle
risorse. L'architetto, in quanto mediatore critico,
non si limita a risolvere problemi tecnici, ma
assume una responsabilità etica e politica,
orientando le scelte progettuali verso modelli di
sviluppo più equitativi, inclusivi e sostenibili.
L'architettura, dunque, non è più un oggetto da
contemplare, ma un agente attivo di trasformazione,
una pratica relazionale e rigenerativa che abita il
tempo, i conflitti e le fragilità del presente,
offrendo visioni concrete e trasformative per il
futuro.
Rewilding architettonico:
verso un paradigma ecocentrico
Il
concetto di rewilding è emerso negli anni
‘90 all'interno dell'ecologia della conservazione
come risposta alla crescente frammentazione degli
ecosistemi naturali e alla crisi globale
rappresentata dalla sesta estinzione di massa.
Questo approccio propone una trasformazione
radicale della gestione ambientale, orientata non
solo a proteggere singole specie o habitat, ma a
ristabilire le dinamiche ecologiche complesse e
autonome degli ecosistemi. Soulé e
Noss (1998) hanno sintetizzato il rewilding nei tre principi
fondamentali, le cosiddette “tre C”: cores (nuclei), corridors
(corridoi) e carnivores (carnivori).
I “cores” sono ampie aree
protette capaci di ospitare popolazioni vitali di
specie native, inclusi i grandi predatori, che
necessitano di habitat estesi e continui. I “corridors” sono corridoi
ecologici che collegano queste aree, facilitando
lo scambio genetico e i movimenti migratori
essenziali per la sopravvivenza delle specie.
Infine, la presenza dei “carnivores”, cioè la
reintroduzione di predatori apicali, è cruciale
per ristabilire le cosiddette “trophic
cascades”:
la loro azione di regolazione sulle popolazioni di
erbivori evita il sovrasfruttamento della
vegetazione, consentendo la rigenerazione e il
mantenimento della biodiversità .
Il
successo di iniziative come il Yellowstone
Wolf
Project,
avviato nel 1995, ha dimostrato come la
reintroduzione di lupi possa ripristinare
equilibri ecologici complessi, influenzando la
struttura della fauna e della flora. Analogamente,
i progetti nei Paesi Bassi (Oostvaardersplassen) hanno mostrato l'efficacia
del
rewilding
nella creazione di habitat dinamici e resilienti.
Tuttavia, applicare questi principi in contesti
antropizzati, come le aree urbane o agricole, pone
sfide che richiedono un ripensamento profondo del
concetto stesso di ecosistema.
 Fig. 4 – Totora Reed Floating, (da Julia Whatson,
Fig. 4 – Totora Reed Floating, (da Julia Whatson,
Lo-TEK. Design by radical indigenism, Cologne, Taschen, 2019, pag. 287)
Cortesia di S. Rugino
Jørgensen (2015) ha
introdotto la nozione di “novel ecosystems” ,
ovvero sistemi ecologici nuovi, ibridi, che
nascono dall'interazione tra elementi naturali e
antropici senza precedenti storici. Questo
riconoscimento implica che gli ambienti urbani e
antropizzati non possono tornare a uno stato
pristino o naturale tradizionale, ma possono
sviluppare nuove forme di biodiversità e offrire
servizi ecosistemici innovativi, spesso più
funzionali e adattativi rispetto ai modelli
naturali classici.
In questo contesto, l'architettura
occidentale tradizionale si è dimostrata
storicamente antropocentrica, basata sulla
separazione netta tra uomo e natura. Il paradigma
consolidato, incarnato dalla Carta di Atene (1933),
concepisce lo spazio costruito come funzionale alle
esigenze umane, relegando la natura a semplice
decorazione o risorsa da sfruttare. Questa visione
limita la possibilità di integrare realmente la
natura negli ambienti urbani.
Il
filosofo e paesaggista Gilles Clément
propone
una visione alternativa attraverso la teoria del
“Terzo Paesaggio”. Clément
individua
negli spazi abbandonati, incolti e marginali delle
città —luoghi
spesso trascurati o considerati rifiuti urbani— le
vere riserve di biodiversità. Questi “spazi
dell'abbandono” consentono alla natura di
esprimere liberamente la propria dinamica
evolutiva, dimostrando che la vita può prosperare
anche in ambienti fortemente antropizzati, purché
liberata
da un controllo eccessivo .
Parallelamente,
l'antropologa
Anna Tsing ha elaborato il concetto di “more-than-human
worlds”
,
che supera la tradizionale dicotomia
natura/cultura. In questa prospettiva, le città e
i loro ecosistemi sono visti come ambienti ibridi
in cui specie native, esotiche e sinantropiche
coevolvono attraverso relazioni complesse e
simbiotiche. La biodiversità urbana diventa così
un processo emergente, non un semplice residuo di
ecosistemi passati, e l'architettura può assumere
un ruolo attivo come infrastruttura ecologica che
supporta questi processi coevolutivi.
Il rewilding architettonico si
concentra quindi sulla creazione di condizioni
favorevoli all'auto-organizzazione ecologica,
piuttosto che sulla definizione di configurazioni
spaziali rigide e statiche. Questo approccio
implica la progettazione di successioni ecologiche
programmate: gli spazi inizialmente controllati
evolvono nel tempo verso ambienti semi-naturali,
con edifici e infrastrutture che incorporano
substrati, microhabitat e materiali che
facilitano la colonizzazione spontanea di specie
pioniere. La gestione adattiva è essenziale, con
un monitoraggio continuo delle dinamiche emergenti
e interventi minimi che assecondano piuttosto che
dirigono i processi naturali.
Inoltre,
il
riconoscimento della “temporalità non-umana”
richiede che l'architettura incorpori la
dimensione dei tempi ecologici —cicli vitali,
successioni, adattamenti— spesso molto più lunghi
e imprevedibili rispetto ai tempi progettuali
umani. Progettare per la durata e il cambiamento è
quindi un elemento cruciale per il successo del rewilding urbano.
La
progettazione ecologica richiede competenze
specifiche: la creazione di nicchie integrate in
elementi architettonici (coperture verdi, sistemi
di raccolta delle acque, facciate vegetali) che
svolgano funzioni tecniche ed ecologiche
contemporaneamente; la definizione di reti di
connettività che collegano habitat frammentati
attraverso corridoi verdi, ponti ecologici e stepping stones; la progettazione
di microhabitat calibrati sulle
esigenze di specie target, come nidi per uccelli,
rifugi per chirotteri e zone per impollinatori.
Il principio della coevoluzione, mutuato
dalla biologia, si traduce in architetture adattive,
modulari e capaci di modificarsi in risposta alle
dinamiche ecologiche. L'integrazione di sistemi di
monitoraggio permette all'edificio di “apprendere” e
adattarsi, regolando aspetti come illuminazione o
accessi in base alla presenza di fauna. L'idea di
invecchiamento programmato trasforma l'obsolescenza
in un'opportunità, concependo strutture pensate per
essere colonizzate e trasformate dalla vegetazione
spontanea nel tempo.
L'osservazione
di
come la natura colonizza le rovine urbane e
l'archeologia industriale ispira queste strategie.
Le “rovine del futuro” di Robert Smithson
anticipano l'idea di architetture che integrano
fin dall'origine processi di decadimento e
rinaturalizzazione . La
biomimesi in questo ambito non si limita alla
forma ma include funzioni ecologiche, come la
riproduzione di canopy urbane stratificate
o superfici che offrono substrati di
colonizzazione per specie vegetali e animali.
Artisti come Smithson, Nancy Holt e Andy
Goldsworthy hanno esplorato le relazioni tra arte,
architettura e processi naturali, creando opere
viventi e dinamiche che influenzano fortemente
l'approccio progettuale contemporaneo verso edifici
come sculture in continua trasformazione.
 Fig. 5 – ROBERT SMITHSON, Broken circle/spiral hill, 2021
Fig. 5 – ROBERT SMITHSON, Broken circle/spiral hill, 2021
(da https://www.exibart.com/arte-contemporanea/
broken-circle-spiral-hill-di-robert-smithson-cinquantanni-dopo/)
Cortesia di S. Rugino
Questo nuovo paradigma ridefinisce
radicalmente il ruolo dell'architetto, che non
progetta più configurazioni definitive ma condizioni
per processi emergenti e interattivi. Sono
necessarie competenze ecologiche avanzate, una
visione sistemica orientata ai processi e una
gestione dell'incertezza, accettando che i risultati
emergeranno da complesse interazioni non
completamente prevedibili. L'architetto diventa
mediatore tra esigenze umane e non-umane,
sviluppando conoscenze di etologia applicata,
ecologia urbana e forme di comunicazione
multispecifica che dialogano con diverse specie.
Il
paradosso del rewilding architettonico
consiste nel tentativo di progettare la
spontaneità, in una disciplina tradizionalmente
legata al controllo e alla definizione rigida
degli spazi. L'introduzione di dinamiche
ecologiche “selvagge” negli ambienti urbani
solleva questioni di sicurezza, salute pubblica e
conformità normativa, dovute alla presenza di
fauna selvatica, vegetazione spontanea e accumulo
di biomassa. Per questo, il successo del rewilding dipende anche
dall'accettazione sociale di estetiche più
disordinate e processi meno controllati, che
richiedono programmi educativi e di
sensibilizzazione per modificare la percezione
comune della natura urbana.
Nonostante
queste
sfide, il rewilding architettonico
rappresenta una direzione di ricerca e pratica
fondamentale per immaginare forme di coabitazione
sostenibile e rispettosa tra umani e non-umani
negli ambienti urbani del XXI secolo, contribuendo
a ridefinire i confini tra città e natura e a
promuovere ecosistemi più resilienti, dinamici e
biodiversi.
Simbiosi
aumentata:
framework teorico
La
simbiosi aumentata rappresenta un cambiamento di
paradigma nell'architettura contemporanea,
superando la dicotomia tra natura e tecnologia
attraverso l'integrazione tra intelligenza
artificiale e processi di rewilding. Gli edifici non
sono più concepiti come oggetti statici, ma come
organismi viventi capaci di adattarsi alle
dinamiche ecologiche circostanti.
Radicata nella teoria dei sistemi complessi
adattivi (Holland, 1995; Gell-Mann, 1994), questa
visione configura l'architettura come interfaccia
attiva tra biosfera e tecnosfera. Come teorizzato da
Bateson, la simbiosi non è solo funzionale ma
ontologica: edificio ed ecosistema co-evolvono,
influenzandosi reciprocamente, secondo i principi
della coevoluzione.
L'edificio
diventa
un organismo percettivo, dotato di un sistema
nervoso distribuito. Sensori ambientali operano su
diverse scale: micro (qualità dell'aria,
temperatura dei materiali), meso (microclima,
presenza di fauna) e macro (pattern climatici,
connettività ecologica), permettendo
all'intelligenza artificiale di elaborare una
comprensione olistica delle dinamiche ambientali.
I dati raccolti alimentano sistemi responsivi che
trasformano fisicamente lo spazio: pareti che
regolano la permeabilità, coperture che modulano
l'ombreggiamento in base ai cicli vegetativi,
aperture che seguono i flussi migratori.
L'edificio si adatta, interpretando l'ambiente in
tempo reale, secondo i principi della responsive
architecture
e della biomimicry .
Questa
adattività si estende anche al metabolismo: i
flussi energetici e idrici si sincronizzano con i
ritmi naturali. L'IA ottimizza il funzionamento
dell'edificio seguendo cicli circadiani e
stagionali, integrando fitodepurazione,
ventilazione naturale e raccolta idrica secondo
una logica ecologica del metabolismo urbano .
La
progettazione si apre a un processo co-evolutivo
che include attivamente anche altre specie. Gli
algoritmi simulano i comportamenti di insetti,
uccelli, mammiferi e piante per generare
configurazioni spaziali che integrano microhabitat
e
percorsi ecologici. Le esigenze multispecifiche
vengono bilanciate attraverso design generativi
che ottimizzano simultaneamente per le necessità
umane e non-umane: giardini verticali, facciate
con nidi integrati, corridoi ecologici urbani. Le
strutture si trasformano in interfacce
interspecifiche, capaci di mediare relazioni:
superfici che favoriscono la crescita di muschi,
sistemi di irrigazione che fungono da abbeveratoi
per la fauna, elementi architettonici che svolgono
funzioni ecologiche e sociali simultaneamente.
Questa
logica relazionale si ispira al concetto di “boundary objects” elaborato da Star
e Griesemer, reinterpretato in chiave
architettonica all'interno di una visione
post-antropocentrica. In questo contesto,
l'edificio non è più un oggetto statico, ma un
sistema in evoluzione continua, capace di
adattarsi, apprendere e trasformarsi in risposta
al proprio ambiente .
L'intelligenza
artificiale,
integrata nei processi costruttivi e gestionali,
apprende dai cicli ambientali, dal comportamento
degli abitanti e dalle variazioni climatiche,
affinando nel tempo le proprie strategie
attraverso modelli di machine
learning
e principi di adaptive management
. L'architettura si
fa così intelligente e sensibile, capace di
reagire dinamicamente alle sollecitazioni esterne.
Materiali
biologici
integrati nella struttura si autoriparano, sistemi
robotici automatizzano la manutenzione e i moduli
architettonici si riconfigurano in base ai
mutamenti del contesto. In questo modo, l'edificio
sviluppa proprietà autopoietiche :
mantiene la propria coerenza interna mentre si
rinnova continuamente, come un organismo vivente.
L'evoluzione
architettonica
si distribuisce su diverse scale temporali, dai
microcicli quotidiani alle trasformazioni più
lente e profonde che si dispiegano nell'arco di
decenni. L'intelligenza artificiale, in questo
scenario, funge da regista della complessità
cronologica, anticipando traiettorie di sviluppo
secondo i principi della coevolutionary
theory
e dell'ecologia temporale .
Questo paradigma ridefinisce radicalmente
il significato dell'abitare: non si tratta più di
occupare uno spazio, ma di partecipare a un
ecosistema dinamico. Gli esseri umani diventano
coabitanti all'interno di una comunità
biotecnologica, in cui le scelte abitative
influenzano — e sono al tempo stesso influenzate —
da processi ecologici in continua trasformazione.
Le
riflessioni fenomenologiche di Heidegger
sull'”abitare” costituiscono un punto di partenza
fondamentale per ripensare il rapporto tra
l'essere umano e il mondo. Nel saggio Costruire,
abitare, pensare,
Heidegger afferma che abitare non è semplicemente
occupare uno spazio fisico, ma è un modo
essenziale dell'essere, un rapporto di cura e
appartenenza con il mondo. L'”abitare” autentico,
secondo il filosofo, implica una relazione
radicata, non strumentale, con la terra, gli altri
e il divino, ponendo l'essere umano non come
dominatore, ma come custode del mondo .
Questa
visione viene ampliata e messa in dialogo con
l'ecologia relazionale di Tim Ingold, secondo cui
gli esseri viventi non si muovono in uno spazio
già dato, ma “crescono con” l'ambiente attraverso
un processo continuo di interazione e
co-evoluzione. Per Ingold, abitare significa
essere immersi in un flusso di relazioni materiali
e percettive, dove la distinzione tra natura e
cultura perde di significato. Il paesaggio non è
uno sfondo inerte, ma un tessuto vivente che si
forma insieme a chi lo attraversa e lo abita.
L'abitare, in questo senso, è un gesto ecologico e
creativo, che implica una partecipazione attiva
alla vita dei luoghi .
A
completare questa prospettiva si inserisce
l'ontologia simbiotica di Philippe Descola, che
mette in discussione la visione occidentale
dualistica di natura e cultura. Descola mostra
come diverse culture non separino gli esseri umani
dagli altri viventi, ma li concepiscano come parte
di una rete simbiotica e interdipendente.
Nell'ontologia simbiotica, il mondo è abitato da
una pluralità di agenti – umani, animali,
vegetali, spiriti, elementi – tra i quali si
instaurano relazioni di reciprocità e
co-esistenza. Questa visione apre la strada a una
concezione dell'abitare non antropocentrica, in
cui l'architettura non è costruita solo per l'umano, ma insieme ad altri esseri e
in ascolto delle ecologie locali .
L'intreccio di queste tre prospettive —
fenomenologica, relazionale e simbiotica — permette
di ripensare radicalmente l'architettura e il
progetto dello spazio abitato. L'abitare non è più
un gesto individuale o funzionale, ma un atto etico
ed ecologico, che implica la partecipazione
consapevole a una rete di relazioni viventi.
In questo quadro, il progetto
architettonico si configura come una pratica
situata, sensibile e interconnessa, capace di
generare luoghi che non solo accolgono la vita, ma
la coltivano, la amplificano e la rigenerano.
L'architettura, così intesa, non si limita a
rispondere a esigenze funzionali o estetiche, ma si
inserisce attivamente nei cicli vitali del
territorio, diventando un elemento trasformativo
all'interno degli ecosistemi.
È in questo contesto che si colloca il
concetto di simbiosi aumentata, una prospettiva che
va oltre la semplice sostenibilità. Non si tratta
più di limitare i danni ambientali o ridurre
l'impronta ecologica, ma di generare valore
ecologico positivo, contribuendo in modo attivo alla
salute e alla resilienza dei sistemi viventi.
L'architettura diventa così un agente rigenerativo,
capace di incrementare la biodiversità, migliorare
la qualità dell'aria e del suolo, regolare i flussi
idrici e rafforzare le reti ecologiche locali.
Questa evoluzione progettuale si fonda su
approcci sistemici e integrativi, che ripensano in
profondità il rapporto tra architettura, ambiente e
società. L'ambiente costruito non è più visto come
un'entità separata o correttiva rispetto alla
natura, ma come una componente attiva dei cicli
ecologici, capace di contribuire alla rigenerazione
dei territori. Modelli ispirati ai processi naturali
offrono strategie resilienti, basate
sull'interazione sinergica tra elementi e sulla
valorizzazione delle risorse locali. Allo stesso
tempo, si amplia la nozione di valore
architettonico, includendo dimensioni ambientali,
sociali e temporali all'interno delle decisioni di
progetto.
Tuttavia, le sfide che accompagnano questa
trasformazione sono rilevanti. La crescente
complessità tecnologica richiede nuove competenze
interdisciplinari e una revisione profonda dei
riferimenti culturali ed etici della progettazione.
Diventa centrale il riconoscimento di soggettività
non-umane all'interno del processo progettuale,
evidenziando la necessità di considerare diritti
ecologici e relazioni multi-specie come parte
integrante della costruzione dello spazio. In questo
scenario emergono anche nuovi quadri normativi,
capaci di riconoscere la legittimità di agenti come
animali, piante, microbi ed ecosistemi nella
definizione delle regole che governano l'abitare
collettivo.
Numerosi
progetti
anticipano già questi scenari futuri. Dalla Blur Building di Diller +
Scofidio (2002), che dissolve i confini materiali
dell'edificio attraverso una nuvola artificiale,
all'Algae
House dello
studio Splitterwerk (2013), che integra alghe
fotosintetiche per la produzione di energia.
 Fig. 6 – DILLER + SCOFIDIO, Blur Building, 2002
Fig. 6 – DILLER + SCOFIDIO, Blur Building, 2002
(da https://publicdelivery.org/blur-building/)
Cortesia S. Rugino
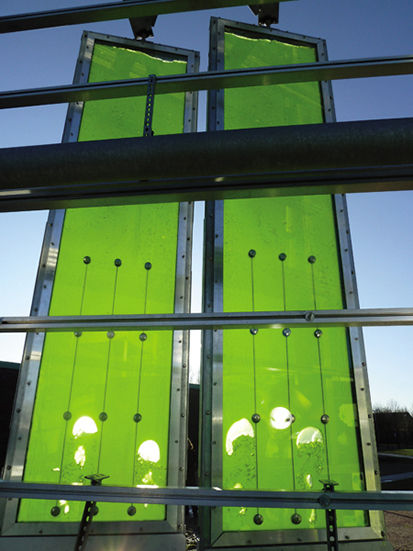 Fig. 7 – SPLITTERWERK, Algae House, 2013
Fig. 7 – SPLITTERWERK, Algae House, 2013
(da https://www.fastcompany.com/3005162/splitterwerk-architects-biq-house)
Cortesia S. Rugino
Il
programma Living
Architecture
(LIAR) dell'Università di Newcastle sperimenta con
materiali microbiologici capaci di processare
rifiuti e produrre risorse, mentre il MIT
Media Lab esplora l'impiego
di
organismi geneticamente modificati come componenti
architettonici attivi.
Il
padiglione HygroScope
del
FRAC Centre, progettato da Achim Menges, dimostra
invece le potenzialità dei materiali igroscopici,
in grado di modificare la propria forma in
risposta all'umidità
atmosferica.
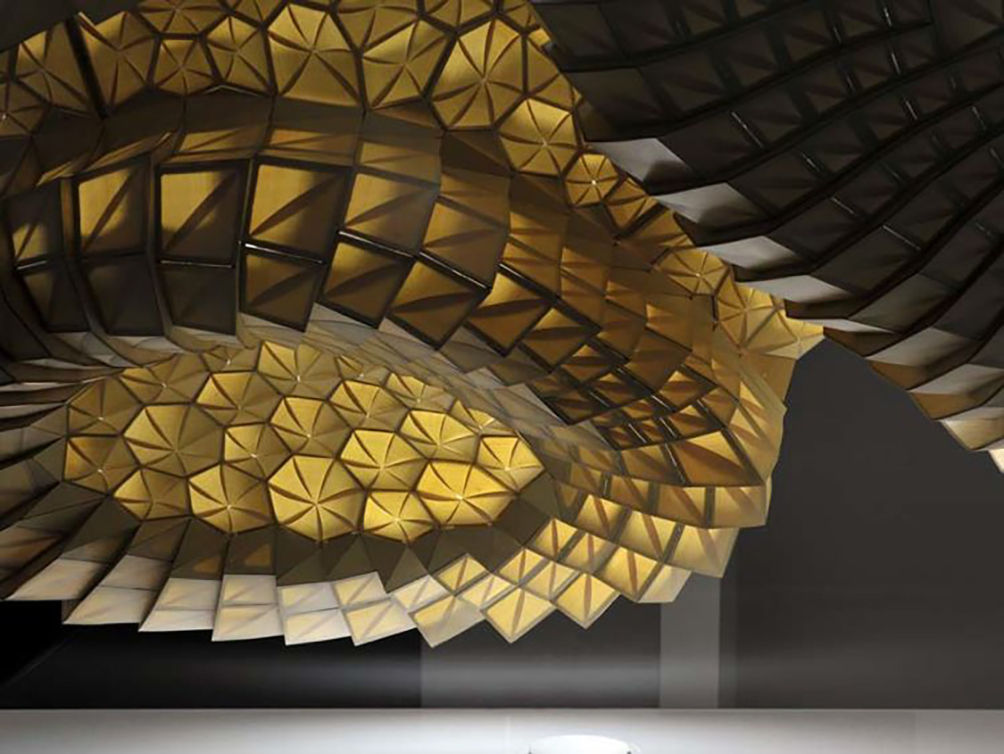 Fig. 8 – ACHIM MENGES, HygroScope, 2018
Fig. 8 – ACHIM MENGES, HygroScope, 2018
(da https://parametric-architecture.com/hygroscope-meteorosensitive-morphology/)
Cortesia S. Rugino
Guardando
al
futuro, l'architettura potrà integrare organismi
progettati in laboratorio, frutto di avanzamenti
nella biologia sintetica, e sfruttare reti neurali
ispirate ai sistemi ecologici, in grado di
coordinare dinamicamente le interazioni tra
componenti viventi e artificiali. In questo
scenario, emergeranno nuove forme di intelligenza
collettiva, in cui la coscienza naturale, umana e
artificiale si connettono e si potenziano
reciprocamente, dando origine a sistemi
progettuali distribuiti, adattivi e profondamente
interrelati con l'ambiente.
L'obiettivo ultimo è dar forma a habitat
urbani capaci di comportarsi come ecosistemi
viventi: ambienti che si rigenerano, si adattano, e
supportano attivamente la biodiversità. In questo
scenario, la tradizionale separazione tra natura e
architettura si dissolve, lasciando spazio a una
nuova visione dell'abitare planetario.
La tecnologia non si contrappone più alla
biologia, ma si fonde con essa in sistemi
coevolutivi complessi, dando forma a un'architettura
capace di integrarsi nei cicli vitali del pianeta.
In questo scenario, il progetto non è più solo
costruzione di spazio, ma diventa coltivazione di
relazioni viventi, in un equilibrio dinamico tra
artificio e natura.
Applicazioni e casi studio
Come abbiamo evidenziato in precedenza,
l'architettura contemporanea sta vivendo una
profonda trasformazione epistemologica, superando la
tradizionale concezione dell'edificio come entità
statica per abbracciare una visione dinamica e
sistemica, strettamente integrata con i processi
biologici e ambientali. L'impiego di intelligenza
artificiale e tecnologie ambientali avanzate sta
ridefinendo il rapporto tra ambiente costruito e
natura, configurando gli edifici come sistemi
complessi e viventi, capaci di adattarsi e
rispondere in modo proattivo alle variabili
climatiche e agli stimoli ambientali.
Tra gli
sviluppi più rilevanti si segnala l'integrazione
tra algoritmi ambientali e vegetazione viva, che
dà origine a sistemi bio-responsivi in grado di
monitorare e regolare in tempo reale parametri
quali temperatura, umidità, CO₂, luce e qualità
dell'aria. Sensori avanzati raccolgono dati
costantemente, mentre algoritmi predittivi
anticipano scenari futuri, consentendo ai sistemi
di adattarsi e ottimizzare funzioni come
l'irrigazione, l'ombreggiamento e l'orientamento
delle superfici verdi. Questo continuo circuito di
feedback garantisce sia la salute delle piante sia
l'efficienza energetica dell'edifício.
I benefici di tali sistemi sono molteplici:
riduzione del consumo energetico, miglioramento
della qualità dell'aria e creazione di habitat
urbani a supporto della biodiversità. Inoltre,
l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla
pianificazione urbana permette di progettare
corridoi verdi funzionali, simulando le migrazioni
faunistiche, la dispersione vegetale e valutando gli
impatti climatici sugli ecosistemi urbani.
L'ottimizzazione della connettività ecologica
facilita la continuità tra habitat frammentati,
promuovendo il flusso genetico e integrando in modo
armonioso infrastrutture grigie e verdi.
La
nuova generazione di edifici intelligenti impiega
sistemi auto apprendenti per massimizzare i
servizi ecosistemici, regolando la vegetazione, i
flussi d'aria e sfruttando superfici
fotocatalitiche per purificare l'ambiente.
Fondamentale è anche la gestione idrica, che
attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque
meteoriche, la fitodepurazione e la regolazione
del microclima urbano, si avvale di elementi
vegetali integrati all'interno delle strutture
edilizie. La regolazione termica si basa
sull'inerzia della biomassa, sull'ombreggiamento
dinamico e sulla ventilazione naturale indotta
dalla vegetazione.
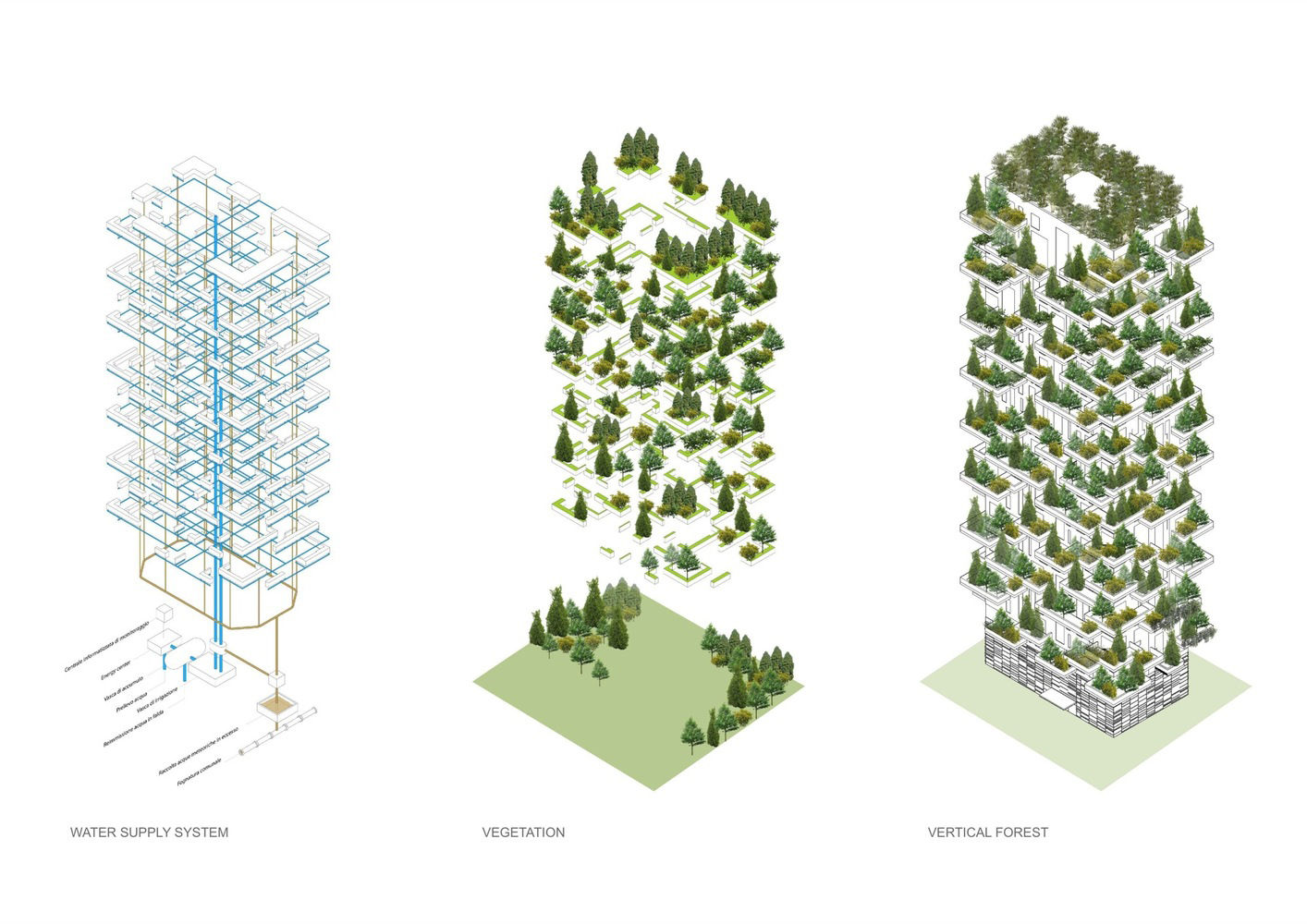 Fig. 9 – STEFANO BOERI, Bosco Verticale, Milano, 2014
Fig. 9 – STEFANO BOERI, Bosco Verticale, Milano, 2014
(da https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti/
564e7c88e58ece4d730003a5-bosco-verticale-stefano-boeri-architetti-detail)
Cortesia S. Rugino
Esempi
emblematici di queste pratiche sono il Bosco
Verticale
di Milano, che ospita oltre 20.000 piante, assorbe
grandi quantità di CO₂ e riduce
significativamente il consumo energetico, e il non
realizzato Garden Bridge di
Londra, una visione innovativa di infrastruttura
verde sospesa e corridoio ecologico. Progetti come
il Living
Architecture Project
sperimentano edifici capaci di auto-ripararsi,
adattarsi e integrarsi nei cicli biologici, mentre
iniziative come quelle di Terreform ONE promuovono
un'architettura rigenerativa focalizzata su
biodiversità, sequestro del carbonio e chiusura
dei cicli materiali.
 Fig. 10 – TERREFORM ONE, Arboreal Tower, 2025
Fig. 10 – TERREFORM ONE, Arboreal Tower, 2025
(da www.terreform.org)
Cortesia S. Rugino
A
queste esperienze si affiancano quelle di Lo-TEK, che esplora le
tecniche costruttive tradizionali e sostenibili
delle culture indigene, valorizzando sistemi
ingegneristici basati su conoscenze ancestrali di
simbiosi con l'ambiente naturale, applicate in
chiave contemporanea. Analogamente, Studio Weave si distingue per un
approccio interdisciplinare che integra
architettura, arte e scienze ambientali,
sviluppando progetti incentrati sulla
partecipazione attiva della comunità e la
rigenerazione degli spazi urbani attraverso
soluzioni sensibili e adattive.
Questi approcci stanno trasformando la
città in una rete ecologica integrata, dove ogni
edificio diventa un nodo attivo nel supporto alla
salute dell'ecosistema urbano. Corridoi verdi e
sincronizzazioni biologiche tra città e natura
assumono un ruolo centrale nel disegno urbano
contemporaneo, rafforzando la resilienza climatica
attraverso adattabilità, ridondanza ecologica e
risposte rapide ai cambiamenti ambientali.
 Fig. 11 – STUDIO WEAVE, Paleys upon Pilers, 2012
Fig. 11 – STUDIO WEAVE, Paleys upon Pilers, 2012
(da www.studioweave.com)
Cortesia S. Rugino
La complessità di questi sistemi richiede
modelli predittivi avanzati, sensori biologici
integrati e interfacce intuitive per una gestione
efficace e armoniosa delle relazioni tra esseri
umani e natura. La sostenibilità economica si basa
sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici,
sull'automazione che riduce i costi di gestione e
sulla creazione di mercati per crediti di carbonio e
biodiversità.
L'architettura bio-integrata rappresenta
così non solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero
e proprio cambio di paradigma, dove gli edifici si
trasformano in attori ecologici attivi. Per
realizzare questo nuovo modello è indispensabile un
approccio multidisciplinare che connetta
architettura, biologia, ingegneria, informatica e
scienze sociali. Il futuro dell'architettura
sostenibile è fatto di edifici capaci non solo di
minimizzare l'impatto ambientale, ma di rigenerare
attivamente gli ecosistemi urbani, promuovendo
biodiversità e benessere delle comunità.
Tutto ciò implica un ripensamento profondo
dei processi progettuali, normativi ed economici,
per dare vita a un'architettura davvero rigenerativa
e simbiotica con la natura.
Implicazioni teoriche e metodologiche
La
simbiosi aumentata rappresenta un paradigma
rivoluzionario che trasforma l'architettura
contemporanea, spostando l'attenzione dalla
costruzione di oggetti edilizi alla progettazione
di ecosistemi viventi e responsivi. Come
sottolinea Gruber, l'architettura del futuro non
sarà più basata su strutture inerti, ma sulla
coltivazione di sistemi viventi integrati
nell'ambiente costruito .
Questa transizione ridefinisce radicalmente il
ruolo dell'architetto, che da semplice autore
diventa orchestratore di complesse relazioni tra
organismi viventi, algoritmi, materiali
intelligenti e processi ambientali, richiedendo
una comprensione sistemica delle interazioni e dei
loro effetti a cascata.
Latour
evidenzia che l'”agentività” non è più
esclusivamente umana, ma distribuita tra attori
umani e non-umani che co-costituiscono reti
socio-tecniche, costringendo il progettista a
operare nell'incertezza, riconoscendo pattern
emergenti e adattando dinamicamente le proprie
strategie . La
progettazione computazionale si configura così
come strumento essenziale per esplorare scenari
complessi, dove algoritmi genetici, reti neurali e
sistemi multiagente permettono di generare
soluzioni emergenti dall'interazione tra
molteplici parametri. Frazer descrive questa
architettura evolutiva come un processo basato su
variazione, selezione ed ereditarietà, in grado di
adattarsi dinamicamente alle condizioni
ambientali.
L'ecologia applicata offre un solido
quadro teorico per tradurre le dinamiche naturali in
principi progettuali concreti. Concetti chiave come
resilienza, diversità e cicli dei nutrienti diventano
strumenti operativi utili a interpretare e guidare il
progetto. La resilienza, intesa come la capacità di un
sistema di assorbire disturbi mantenendo le proprie
funzioni e struttura, diventa centrale per affrontare
l'incertezza e la variabilità ambientale. Questo approccio
sistemico consente di riconoscere proprietà emergenti e di
progettare interventi capaci di amplificare sinergie e
ridurre gli effetti collaterali, trasformando la
progettazione in un processo iterativo e non lineare,
fondato sull'osservazione, l'azione e l'adattamento.
All'interno di questo processo, i
meccanismi di feedback assumono un ruolo strutturale.
Sensori, algoritmi e sistemi di monitoraggio continuo
forniscono dati in tempo reale, trasformando l'edificio in
un sistema adattivo capace di apprendere dal proprio
comportamento. Questa capacità di autoregolazione, basata
sull'analisi dei risultati precedenti, rende possibile una
progettazione evolutiva e dinamica.
La modellazione parametrica e generativa,
ispirata a processi di selezione naturale, consente di
esplorare un'ampia varietà di soluzioni progettuali,
mantenendo flessibilità e adattabilità durante tutto il
ciclo di vita dell'edificio. In questo contesto, la
struttura fisica non è più un semplice contenitore, ma un
supporto attivo per processi dinamici come la crescita
biologica, l'adattamento climatico e la trasformazione
metabolica. L'uso di materiali viventi e superfici
responsive trasforma l'edificio in un organismo
architettonico vero e proprio.
Questa nuova concezione mette in
discussione la tradizionale distinzione tra vivente e
non-vivente, generando ibridi che integrano entrambe le
dimensioni. L'architettura assume così una temporalità
complessa, in cui i cicli biologici e tecnologici si
intrecciano continuamente. Per rappresentare questa
dimensione dinamica, servono nuovi strumenti: diagrammi di
flusso, mappe sistemiche, visualizzazioni interattive e
simulazioni in tempo reale affiancano i disegni tecnici
tradizionali, offrendo una comprensione più articolata del
divenire spaziale.
Anche i criteri di valutazione del
progetto si evolvono: al posto della performance statica
si considerano metriche come biodiversità, resilienza,
adattabilità e capacità rigenerativa. L'obiettivo non è
più solo la funzionalità immediata, ma la capacità
dell'edificio di co-evolvere con il proprio ambiente nel
tempo.
Questa trasformazione richiede un
approccio interdisciplinare, che integri competenze
biologiche, informatiche, ingegneristiche e sociali. La
progettazione diventa un atto collettivo, dove umani,
algoritmi e sistemi naturali co-partecipano attivamente.
In questa visione, ogni elemento del progetto – umano o
non-umano – partecipa alla definizione della realtà
architettonica, trasformando il progetto in un processo di
negoziazione continua tra intelligenze artificiali,
biologiche e umane.
La simbiosi aumentata, quindi, non
rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma una
profonda trasformazione dei nostri modi di pensare e
abitare lo spazio. Imitare la natura non è più soltanto
una strategia progettuale, ma l'espressione di un nuovo
paradigma basato sulla cooperazione tra vita, ambiente e
tecnologia. Realizzare questa trasformazione richiede uno
sforzo collettivo per sviluppare nuove competenze,
strumenti e politiche capaci di sostenere un'architettura
realmente simbiotica con i sistemi naturali.
Sfide e prospettive future
La
complessità computazionale che caratterizza i
sistemi integrati biologico-artificiali
rappresenta una delle principali sfide
nell'implementazione pratica della simbiosi
aumentata in architettura. Progettare edifici come
ecosistemi viventi e responsivi implica la
modellazione di interazioni complesse tra
componenti biologici, tecnologici e ambientali,
che richiedono capacità di calcolo estremamente
elevate, spesso superiori alle infrastrutture
attualmente disponibili. Come evidenzia Mitchell,
i sistemi complessi adattivi presentano proprietà
emergenti non prevedibili a partire dai singoli
componenti ,
rendendo la simulazione e il controllo di tali
sistemi un compito di elevata complessità.
Nel contesto progettuale, la sfida
consiste nell'integrare modelli multiscala, che spaziano
dal livello molecolare a quello ecosistemico, gestendo
simultaneamente migliaia di variabili interconnesse. Si
propone l'adozione di approcci ibridi, in cui la
modellazione matematica tradizionale si combina con
algoritmi bio-ispirati di machine learning, per
comprendere la dinamica di questi ecosistemi artificiali e
permettere risposte adattative in tempo reale.
L'implementazione richiede inoltre
l'integrazione di sensori biologici, algoritmi di
controllo e sistemi ambientali distribuiti, capaci di
monitorare e regolare continuamente parametri quali
temperatura, umidità, qualità dell'aria e ciclo dei
nutrienti. Imparare dalla natura significa accettare
l'incertezza come parte integrante del progetto, non come
un errore da eliminare. Questo implica considerare nei
processi progettuali non solo la complessità
computazionale, ma anche l'imprevedibilità intrinseca dei
sistemi viventi, ampliando così il ruolo dell'architetto
da semplice progettista a orchestratore di sistemi
adattivi.
Dal punto di vista normativo,
l'integrazione di componenti biologiche nell'architettura
si scontra con un vuoto regolatorio significativo. Le
attuali normative edilizie non prevedono edifici con
sistemi viventi o adattivi, né affrontano questioni di
biosicurezza e responsabilità legale. È urgente sviluppare
un nuovo quadro normativo che integri aspetti edilizi e
biotecnologici e valuti l'impatto ecosistemico a lungo
termine degli interventi. Inoltre, il progetto deve
affrontare la complessità delle responsabilità legali
connesse a sistemi autonomi in grado di influenzare
l'ambiente circostante, ponendo domande cruciali sulla
certificazione e gestione di tali sistemi.
Sul piano economico, l'architettura
bio-ibrida comporta costi iniziali elevati e investimenti
significativi in ricerca e infrastrutture specializzate,
come bioreattori e sistemi di manutenzione per organismi
viventi. Tuttavia, il potenziale della simbiosi aumentata
come risposta alla crisi climatica è straordinario.
Strutture biologicamente attive potrebbero sequestrare
grandi quantità di CO₂, posizionando edifici fotosintetici
come potenti serbatoi urbani di carbonio. Progetti con
facciate viventi, sistemi radicali per la gestione
dell'umidità o coperture adattive stagionali rappresentano
strumenti innovativi per ridurre drasticamente i consumi
energetici. Inoltre, materiali biologici autoriparanti
potrebbero estendere la durata degli edifici e ridurne
l'impatto ambientale.
L'architettura intesa come ecosistema
multispecie apre nuove prospettive per la biodiversità
urbana. Città biofile potrebbero ospitare una quota
significativa della biodiversità terrestre, con edifici
ecosistemici che connettono frammenti ecologici e
trasformano gli spazi urbani in hotspot biologici.
Progettare edifici autosufficienti e verticali, capaci di
purificare l'acqua, produrre cibo e gestire rifiuti
organici, supera la tradizionale separazione tra ambiente
naturale e costruito, dando vita a strutture rigenerative
che producono più risorse di quante consumano.
Per realizzare questi progetti sono
necessarie strategie graduali e coordinate, con
sperimentazioni pilota che forniscano dati utili a
convincere regolatori, investitori e utenti. Fondamentale
è anche la formazione di nuove figure professionali
interdisciplinari, in grado di integrare ecologia,
biotecnologie e design computazionale, affinché emerga una
nuova figura professionale capace di unire scienze
naturali e tecnologie avanzate.
Infine, la standardizzazione e la
collaborazione industriale sono strumenti chiave per
ridurre i costi e accelerare la diffusione di questa nuova
architettura. Consorzi che uniscano aziende
biotecnologiche, edilizie e informatiche favoriranno
interoperabilità ed economie di scala, permettendo un
approccio progettuale coerente e rigenerativo. La simbiosi
aumentata rappresenta così non solo una sfida tecnologica,
ma un cambiamento sistemico, il cui successo dipenderà
dalla capacità di integrare ricerca, innovazione,
normative e modelli economici in un ecosistema progettuale
realmente sostenibile.
Conclusioni
La
simbiosi aumentata si configura oggi come un
paradigma emergente e rivoluzionario che supera la
tradizionale dicotomia tra naturale e artificiale,
proponendo un'architettura intesa non più come
semplice costruzione inerte, ma come un sistema
vivente, intelligente e in continua evoluzione. In
questo contesto, l'integrazione tra intelligenza
artificiale e pratiche di rewilding apre nuove
prospettive per una progettazione realmente
rigenerativa, capace non solo di ridurre l'impatto
ambientale, ma di contribuire attivamente al
ripristino e alla rinaturalizzazione degli
ecosistemi a scala globale.
Nel corso del XXI secolo, l'architettura
sta vivendo una trasformazione profonda, spinta
dalla convergenza tra innovazioni tecnologiche
avanzate e l'urgenza di risposte efficaci alle crisi
ambientali e climatiche. Se nel passato l'approccio
dominante si fondava su principi razionalisti e
funzionalisti, oggi emerge la necessità di un
modello progettuale più dinamico, interattivo e
integrato con i cicli e le reti degli ecosistemi
naturali. Questa evoluzione ridefinisce radicalmente
il ruolo dell'architetto, che da creatore solitario
e autore di forme statiche diventa un facilitatore e
orchestratore di complesse relazioni ecologiche,
tecnologiche e sociali, in grado di progettare
ambienti capaci di interagire e adattarsi in modo
continuo con il contesto circostante.
L'intelligenza artificiale si presenta come
uno strumento chiave di questa nuova visione,
abilitando forme di progettazione generativa e
adattativa che permettono all'architettura di
evolvere in tempo reale in risposta ai dati
provenienti dall'ambiente e dagli utenti. Grazie a
modelli predittivi e algoritmi di machine learning,
l'edificio diventa un organismo intelligente, capace
di ottimizzare consumi energetici, migliorare la
qualità della vita degli abitanti e aumentare la
resilienza rispetto agli eventi climatici estremi,
offrendo soluzioni personalizzate e sostenibili che
si adattano ai mutamenti ambientali in modo fluido e
continuo.
Parallelamente, si afferma con forza un
approccio ecocentrico che spinge oltre i confini
tradizionali della sostenibilità, promuovendo la
reintegrazione attiva della natura negli spazi
costruiti.
La rewild
architecture,
ovvero l'architettura che favorisce il ritorno
della natura negli ambienti urbani, stimola la
biodiversità, crea habitat ecologici integrati e
incorpora sistemi naturali di gestione delle
risorse come il ciclo dell'acqua, il trattamento
dei rifiuti organici e la regolazione
microclimatica. Questo approccio trasforma gli
edifici da oggetti isolati a parti vitali di reti
ecologiche urbane, contribuendo a restituire agli
ecosistemi urbani funzionalità spesso compromesse.
In questo scenario complesso e dinamico,
l'architettura assume il ruolo di vero e proprio
motore di trasformazione ambientale e sociale. La
fusione sinergica tra natura e tecnologia genera
ambienti intelligenti, vitali e resilienti, in grado
di autoregolarsi, rigenerarsi e migliorare la
qualità della vita degli esseri umani e non umani
che li abitano. A supporto di questa trasformazione,
la formazione accademica e professionale si orienta
verso un approccio sistemico, preparando una nuova
generazione di progettisti capaci di considerare in
modo integrato le interazioni tra edificio, ambiente
e società, con un'attenzione costante alle dinamiche
ecologiche e tecnologiche.
Da questa evoluzione nasce la figura
emergente dell'”ecologo digitale”, un progettista
multidisciplinare che integra competenze ecologiche,
tecnologiche e progettuali per affrontare le
complesse sfide contemporanee. Questo professionista
è in grado di dialogare con sistemi naturali e
artificiali, utilizzando biomateriali innovativi e
soluzioni adattive che rendono possibile
un'architettura veramente vivente.
Il nuovo paradigma della simbiosi aumentata
implica quindi un ripensamento profondo delle
pratiche progettuali, fondato sulla collaborazione
attiva con sistemi naturali e intelligenti, e
sull'adozione di metodologie che combinano
sostenibilità, rigenerazione e tecnologia.
Parallelamente, la ricerca dovrà concentrarsi sullo
sviluppo di regolamenti e normative che ne
facilitino l'adozione su larga scala, superando le
barriere legali, economiche e tecniche ancora
presenti.
In
definitiva,
l‘architetto
del
futuro sarà prima di tutto un facilitatore di
simbiosi, capace di mediare e armonizzare le
relazioni tra ambiente naturale e tecnologia,
promuovendo un'architettura resiliente,
sostenibile e profondamente integrata con i cicli
della natura.
NOTE
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Diccionario Metápolis 2001
Diccionario Metápolis de arquitectura
avanzada, Actar, Barcelona, 2001.
Novel ecosystems
2006
Novel ecosystems:
theoretical and management aspects of the new
ecologicalworld order,
Global Ecology and
Biogeography, 15(1), 1–7, 2006.
BANHAM 1978
Reyner BANHAM, Ambiente e tecnica nell'architettura
moderna, Roma-Bari, Laterza, 1978.
BATESON 2000
Gregory BATESON, Verso un'ecologia della mente, Milano,
Adelphi, 2000.
BELL 1973
Daniel BELL, The Coming of
Post-Industrial Society,
New York, Basic Books, 1973.
BRATTON 2016
Benjamin H. BRATTON, The
Stack: On Software and Sovereignty,
Cambridge, MIT Press, 2016.
CARPO 2022
Mario CARPO, “Design and automation at the end of
modernity: theteachings of the pandemic”, Architectural
Intelligence, vol. 1, n. 1, 2022.
CASTELLS 2002
Manuel CASTELLS, L'età dell'informazione: economia, società
e cultura. Vol. 1: L'ascesadella società in rete, Milano,
Università Bocconi, 2002.
CHU 2006
Karl CHU, Metaphysics of Genetic Architecture and
Computation, Architectural Design, 76(4),
38–45, 2006.
CLEMENT 2005
Gilles CLÉMENT, Manifesto del Terzo paesaggio,
Macerata, Quodlibet, 2005.
DESCOLA 2021
Philippe DESCOLA, Oltre natura e cultura, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2021.
EHRLICH & RAVEN 1964
Paul R. EHRLICH, Peter H. RAVEN, Butterflies
and
plants: a study in coevolution,
Evolution,
18(4), 1964.
FRAZER 1995
John H. FRAZER, An Evolutionary
Architecture, Londra, Architectural
Association Publications, 1995.
GELL-MANN 1996
Murray GELL-MANN, Il quark e il giaguaro. Avventura nel
semplice e nel complesso, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.
GRUBER 2011
Peter GRUBER, Biomimetics in Architecture, Berlin, Springer, 2011.
HEIDEGGER 1951
Martin HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare, in Saggi e
discorsi, a cura di Gianni Vattimo, Milano, Mursia,
1976 (pp. 96–108).
HOLLAND 1995
John H. HOLLAND, Hidden Order: How
Adaptation Builds Complexity,
Cambridge, Perseus Books, 1995.
HOLLING 1978
C. S. HOLLING, Adaptive Environmental
Assessment and Management,
New York, John Wiley & Sons, 1978.
INGOLD 2000
Tim INGOLD, The Perception of the
Environment: Essays on Livelihood, Dwelling
andSkill, London, Routledge, 2000.
KENNEDY, CUDDIHY &
ENGEL-YAN 2007
Colin KENNEDY, John CUDDIHY, Jenny ENGEL-YAN, The
changing
metabolism of cities,
Journal of Industrial
Ecology, 11(2), 2007.
LATOUR 1995
Bruno LATOUR, Non siamo mai stati moderni. Saggio di
antropologia simmetrica, Milano, Elèuthera, 1995.
LE CORBUSIER 1973
Le CORBUSIER, Verso un'architettura, Milano,
Longanesi, 1973.
MATURANA & VARELA 1985
Humberto MATURANA, Francisco VARELA, Autopoiesi
e cognizione. La realizzazione del
vivente, Venezia, Marsilio, 1985.
MENGES 2012
Achim MENGES, Material computation:
Higher integration in morphogenetic design,
Architectural Design,
82(2), 2012.
MITCHELL 1997
Tom MITCHELL, Machine Learning,
New York, McGraw Hill, 1997.
MITCHELL 2009
Melanie MITCHELL, Complexity: A Guided
Tour, Oxford, Oxford
University Press, 2009.
MUNFORD 1934
Lewis MUNFORD, Technics and
Civilization, London, Allen &
Unwin, 1934.
NEGROPONTE 1975
Nicholas NEGROPONTE, Soft
Architecture Machines,
Cambridge, MIT Press, 1975.
OXMAN 2017
Neri OXMAN, Age of Entanglement,
Journal of Design and
Science, 3, 2017.
PICON 2010
Antoine PICON, Digital Culture in
Architecture: An Introduction for the Design
Professions, Basilea, Birkhäuser,
2010.
SENNETT 2006
Richard SENNETT, La cultura del nuovo capitalismo, Bologna,
Il Mulino, 2006.
SMITHSON 1967
Robert SMITHSON, A Tour of the Monuments
of Passaic, New Jersey,
Artforum,
ottobre 1967.
SOULÉ & NOSS 1998
Michael SOULÉ, Reed NOSS, Rewilding
and biodiversity: complementary goals for
continental conservation,
Wild Earth,
8, 1998.
STAR & GRIESEMER
1989
Susan L. STAR, James R. GRIESEMER, Institutional
ecology,
‘translations' and boundary objects,
Social Studies of
Science, 19(3), 1989.
THOMPSON 2005
John N. THOMPSON, The Geographic Mosaic of
Coevolution, Chicago, University of
Chicago Press, 2005.
TSING 2015
Anna Lowenhaupt TSING, The
Mushroom at the End of the World: On the
Possibility of Life inCapitalist Ruins,
Princeton, Princeton University Press, 2015.
WINGLER 1969
Hans M. WINGLER, The Bauhaus: Weimar,
Dessau, Berlin, Chicago,
Cambridge (MA), MIT Press, 1969.
WOLKOVICH 2012
Elizabeth M. WOLKOVICH, Warming
experiments underpredict plant phenological
responses to climatechange,
Nature,
485, 2012.
WOLMAN 1965
Abel WOLMAN, The Metabolism of Cities,
Scientific American,
213(3), 1965.
Vedi anche nel BTA:
USCITE DI ARCHITETTURA LIQUIDA
|
|
|