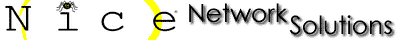|
Il contributo si propone
di ricapitolare e condensare alcune questioni sul pittore
Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milano 1571- Porto Ercole 1610)
che hanno animato il panorama storiografico dal Novecento ad oggi.
Con sguardo
didattico-scientifico, a beneficio di lettori ancora in formazione o
di esperti alla ricerca di una sintesi, ci immergiamo in un dibattito
le cui acque agitano, dal secolo scorso, senza sosta, la critica sul
Merisi, per sviluppare una lettura aggiornata, centrata su tre nodi
tematici: il drappo rosso intenso, la ricezione del termine
“schiamazzo” attraverso le sue stratificazioni semantiche e la
questione dei lavori rifiutati.
Alla cortina scarlatta,
introdotta quasi sistematicamente dal pittore, a partire dalla prima
maturità ,
l'artista affida la corda emotiva delle opere del periodo, essa
irrompe nelle composizioni, come un lampo nella notte, per
attraversare e dominare la narrazione scenica .
Non si tratta di un mero
colore collocato più o meno sapientemente, ma di un elemento
centrale dell'estetica caravaggesca a cui spetta accendere e tenere
viva la risposta emotiva e il coinvolgimento dello spettatore,
infondere vitalità e dinamismo al racconto, e, come una seconda
anima, parallela a quella estetico-visiva, vibrare e sostenere i
drammi e le passioni silenziosi e reali, nonché le imperfezioni e le
contraddizioni legate al suo realismo .
Un escamotage compositivo, profondamente innovativo per la
pittura sacra della Controriforma, la cui introduzione attiva
un processo dinamico che mette in dialogo e comunicazione arte e
fedeli. Dunque, non un felice elemento decorativo, ma un dispositivo
simbolico fondamentale, sostenuto dalla classica teatralità del
periodo barocco, a cui il maestro affida la diffusione del sentimento
di forte devozione che fuoriesce con vivido senso di realtà dalle
sue opere .
In
Giuditta ed Oloferne (Fig. 1)
,
nella Morte della Vergine
e nella Madonna del Rosario (1607, olio su tela, 364 x 249 cm,
Vienna, Kunsthistorisches Museum), per esempio, il drappo
scarlatto funge sia da interlocutore che da cornice dell'evento
tragico: ad esso, che delinea lo spazio esattamente come una quinta
teatrale, è, infatti, assegnata la resa del pathos sacro che
con veemenza qualifica in senso drammatico la scena raccontata .
 Fig. 1 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO,
Fig. 1 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO,
Giuditta ed Oloferne, 1602, olio su tela, 148 × 195 cm
Roma, Galleria Nazionale di arte antica di Palazzo Barberini
Cortesia di Giorgia Duò
 Fig. 2 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
Fig. 2 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
Morte della Vergine, 1604, olio su tela, 369 × 245 cm
Parigi, Museo del Louvre
Cortesia di Giorgia Duò
Dal
punto di vista strettamente formale-compositivo, in tutte queste
invenzioni la cortina caldo-cremisi incombe dall'alto
e avvolge il racconto, esaltando l'umanità dei protagonisti; in
contrasto con il fondo buio, crea ed amplifica un chiaroscuro netto,
quindi, ispessisce la narrazione visiva, confinando gli attori in un
fronte scenico unico. Così operando, Caravaggio propone una
codificazione visiva di un sistema strutturato sulla teatralità ,
con un uso mirato della luce che simula l'illuminazione di scena,
e, contemporaneamente, nel mettere in dialogo arte, cornice e
spettatore, attiva una sperimentazione inedita dove la
rappresentazione chiusa, frontale, entra in contatto diretto con il
pubblico partecipante. Un processo profondamente innovativo per la
pittura sacra della Controriforma in cui l'elemento che
divide, mette anche in connessione lo spazio della rappresentazione
con quello dell'osservatore. Gli stessi personaggi sembrano
muoversi come attori di teatro, disposti in modo da essere percepiti
e fruibili dal riguardante, nessuno si trova su un piano nascosto,
proprio perché devono essere tutti oggetto di contemplazione del
fedele .
Il
velo immaginario che traccia il confine tra lo spazio reale e quello
del racconto, tra la vita e la morte, tra il sacro e il profano, come
un Velo di Maya ante litteram, è infranto. Si genera
in tal modo un dialogo interattivo tra arte, stage e
spettatore che rompe la tipica distanza formale tra episodio sacro ed
osservatore, il quale, in virtù del tendaggio scarlatto, percepito
come barriera aperta, diventa consapevole di essere di fronte a una
rappresentazione e, allo stesso tempo, si sente invitato a
partecipare emotivamente e drammaticamente alla stessa di cui diventa
co-attore emotivo. Assistiamo, cioè, alla teatralizzazione della sua
pittura, che il Merisi persegue non per fini propagandistici, come lo
spirito barocco vuole, o per speculazione fine a sé stesse, ma per
inseguire un rapporto diretto e sincretico tra realtà e finzione,
dove lo spettatore non è più esterno, ma sussunto, pervenendo così
al fine ultimo della diffusione del messaggio di devozione religiosa.
Sono diversi gli studiosi
contemporanei orientati in tal senso: già alla metà del secolo
scorso lo storico inglese Hinks, in riferimento al telo cremisi
sospeso, in alto sopra la testa di
Apostoli e della Vergine, riferisce di una grande tenda rossa, come
espediente di origine teatrale, derivato dall'esperienza degli
spettacoli popolari e della rappresentazione sacra, introdotto nei
dipinti a partire dalla Giuditta
ed Oloferne (Fig. 1)
.
Successivamente, nel 1987 Maurizio Marini, esperto e studioso del
Caravaggio, riprende il riferimento agli aspetti teatrali
dell'inglese, confermando la crescente tendenza alla
spettacolarizzazione delle opere del Lombardo .
Negli
stessi anni Maurizio Calvesi, storico ed esperto del Maestro,
a proposito della Morte
della Vergine (Fig. 2), attribuisce al “grande
drappo rosso”, al di sotto del quale, si svolge la scena, la
capacità di dare “respiro teatrale al cupo e umile ambiente invaso
dall'ombra” .
E più di recente Claudio Strinati, in occasione della mostra,
alle Scuderie del Quirinale, per i 400 anni dalla morte del
Maestro, interpreta il drappo, che si apprezza nella Dormitio
Virginis (fig. 2), come “quinta teatrale”, la cui funzione è
quella di delimitare ed aprire la scena, creando un effetto di
sospensione drammatica tra l'evento raffigurato e lo sguardo dello
spettatore .
Inoltre, il critico in diversi interventi pubblici e
interviste, ha sottolineato come il Pittore spesso cerchi di creare
un rapporto scenico tra opera e fruitore, facendo del quadro uno
spazio teatrale connotato da un'inedita sacralità.
Anche Rodolfo Papa a
proposito del pensiero figurativo di Caravaggio ravvede, nel drappo
rosso della composizione caravaggesca del Transito (fig.
2), un elemento di “teatralità costruttiva”, che attiva, cioè,
il dialogo tra realtà, rappresentazione e pubblico .
Sulla
stessa linea si pone l'interpretazione di Sergio Rossi, esperto del
maestro, il quale ritiene il tendaggio sollevato sopra la vicenda un
accorgimento di origine teatrale, introdotto dal Merisi, come
elemento scenico-liturgico: quasi un sipario che mette in movimento
uno spettacolo di morte reale e di tragico dolore. Nel IV capitolo,
sulla “Controversa iconografia della Vergine”, della sua recente
pubblicazione ,
considera la cortina rossa come segnale visivo e concettuale,
particolarmente efficace, che segna la transizione tra due stati:
allude, cioè, al passaggio tra la vita (gli Apostoli) e la morte (la
Madonna), tra il sacro (la Vergine) e il profano (il contesto
domestico e umano della vicenda).
La valenza
scenico-teatrale rilevata nelle rappresentazioni dell'artista, con
esplicito riferimento al sipario, non va, però, limitata al solo
elemento del sipario, ma estesa al sapiente utilizzo del colore rosso
lato sensu. Tutt'altro che casuale, la tinta riveste una
funzione simbolica, psicologica e compositiva, si lega, cioè, alla
dimensione narrativa del racconto. Inserito spesso al centro delle
composizioni, o in posizione strategica, qualificante stoffe, tessuti
e altri dettagli, il colore attrae, orienta e guida lo sguardo dello
spettatore per stimolarne il pensiero riflessivo e condurlo verso il
cuore narrativo ed emotivo della scena. In quanto punto focale è il
primo elemento con cui l'osservatore entra in contatto nonché
l'ultimo ricordo impresso nella sua mente. Vividi esempi di questo
impiego sono: la sopravveste rossa del San Matteo e
l'angelo (1602, olio su tela, 295 × 195 cm, Roma, Chiesa di
San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli) ,
il paramento sulle spalle del San Giovanni della Deposizione
vaticana (1602-1604, olio su tela, 300 × 203 cm, Città del
Vaticano, Pinacoteca Vaticana) ,
il lenzuolo di Cristo dell'Incoronazione di Spine (1603,
olio su tela, 127 × 165 cm, Vienna, Kunsthistorisches Museum)
,
in tutti questi quadri il rosso accende ed illumina la scena, genera
tensione e intensifica il coinvolgimento drammatico.
Il tono cremisi in
pittura ha una lunga tradizione simbolica che Caravaggio dimostra di
ben conoscere e riprendere, per offrire, però, un'interpretazione
assolutamente personale ed originale: il Pittore, spesso associa il
colore a momenti di crisi, svolta o rivelazione; soprattutto nei temi
sacri, allude al concetto di sacrificio, che, condito con una certa
sensibilità tormentata, caratterizza e si lega alle figure di Santi,
Martiri e alle scene della Passione .
La simbologia tradizionale si sposa con l'inedita e sincera
aderenza al dato reale che rende i soggetti religiosi individui
umani, genuini, dotati di una corporeità schietta, le cui vivide e
carnali presenze, caricate e munite di una gamma complessa e
credibile di emozioni, animano atmosfere autentiche ed immediate,
lontane dalle erudite raffigurazioni di corpi idealizzati o ascetici
e di ambienti accademicamente costruiti sulla scorta della cultura
trionfante del ‘600.
La pungente adesione a
fatti concreti, evidentemente, non può essere passata inosservata,
la pittura del maestro, prima di piacere, essere accettata e, infine,
spasmodicamente ricercata ,
ha sconvolto l'opinione pubblica che vede nel pittore “il
pervertitore del ‘buon costume' nella pittura, cui manca tutto
ciò che per la teoria del primo classicismo sacro (…) (è)
intangibile patrimonio delle sue formule scolastiche” ,
e dal Bellori gli vengono rimproverati “la mancanza di contegno
nelle sue storie, l'eccessiva umanità delle sue mezze figure e dei
suoi quadri di figure volgari” .
Caravaggio,
quindi, fa “rumore” non acustico, ma visivo ed etico, le sue
rappresentazioni troppo reali, i suoi Santi sporchi, le sue
Madonne con tratti da popolane e gesti quotidiani, creano
disturbo, infrangono il codice della decenza e del decoro figurativi.
Questo “rumore” è lo svelamento brutale del reale nel sacro
tipico della religiosità di stampo pauperistico-borromaico in cui il
Pittore cresce.
Le
fonti e cronache del tempo riferiscono sentimenti ed opinioni
contrastanti nei confronti di questo nuovo stile artistico, cd “dal
naturale”, disappunto e apprezzamento convivono dualisticamente
nelle testimonianze letterarie giunte a noi :
Gaspare Celio ,
nella sua biografia sul pittore, riporta che gente comune e
personaggi più colti ed esperti di pittura, in occasione
dell'apertura della Cappella Cantarelli (1599-1603, Roma,
San Luigi dei Francesi), lodano la sua arte .
Giovanni Baglione (1573
ca-1643), invidioso ed astioso collega del Merisi ,
tra ammirazione ed acredine afferma: “Se Michelagnolo Amerigi non
fusse morto sì presto, haveria fatto gran profitto nell'arte per
la buona maniera, che presa havea nel colorire del naturale, benché
egli nel rappresentar le cose non avesse molto giudicio di scegliere
il buono, e lasciare il cattivo. Nondimeno acquistò gran credito, e
più si pagano le sue teste, che l'altrui historie, tanto importa
l'aura popolare, che non giudica con gli occhi, ma guarda con le
orecchie. E nell'Accademia il suo ritratto è posto” .
Il critico riporta di “romori” e “schiamazzi” del popolo di
fronte allo scoprimento di alcune Madonne. I termini alludono,
in senso assolutamente neutro, a quel clamore e quella vitalità,
connotati da gioia, disordine, confusione e acceso vociare, creatisi
attorno alla sua pittura nel momento dello scoprimento ;
solo successivamente alla sua morte, nella feroce ed anonima critica
sei-ottocentesca, i termini sono messi in relazione a un presunto
gusto “popolare volgare” e acquisiscono l'accezione negativa,
di derisione, biasimo ed indignazione per un fare poco ortodosso,
derivante dal riconoscere nelle Vergini e nei Santi le
fattezze di popolani riconoscibili .
In quel contesto, l'opera di Caravaggio è vista come
eccessivamente realistica, teatrale e irreligiosa .
L'associazione dei
termini riferiti dal Baglioni con significati di biasimo, quindi,
deriva non direttamente dalle cronache coeve al Lombardo, come a
lungo si è creduto, ma da un successivo travisamento del reale
significato. A partire dall'indignazione manifestata dal Bellori,
segretario dell'Accademia di San Luca, che non condivide il
plauso (gli “schiamazzi”) con cui i lavori del Nostro sono stati
accolti dal pubblico, assistiamo ad un generale mutamento di
significato e valore per cui la critica tardo-secentesca, neoclassica
e accademico-ottocentesca, trasformano i lemmi in forme di derisione
e non apprezzamento, condivise diffusamente da critici, storici e
opinione pubblica che perdureranno per tutto il XIX, giungendo al XX
secolo, fino a Bernard Berenson .
Contemporaneamente, a
partire da Lionello Venturi e da Roberto Longhi, a cavallo della
prima metà del secolo scorso, passando per Calvesi, fino alle più
recenti interpretazioni di Claudio Strinati, Andrea Lonardi, Rodolfo
Papa e Marco Pupillo, si tende a ricondurre tali parole nell'alveo
neutro di origine, ossia, nel contesto della meraviglia e ammirazione
popolare per opere che parlano direttamente al fedele con un
linguaggio e una grammatica immediatamente comprensibile al pubblico
colto e meno colto.
A
riprova del tono se non positivo, almeno neutro, di certi termini,
citiamo ancora il Baglione che in occasione dell'inaugurazione
della Cappella Contarelli scrive: “Pur venendovi a vederla
Federico Zucchero, mentre io era presente, disse: che rumore è
questo? E guardando il tutto diligentemente, soggiunse: io non ci
vedo altro, che il pensiero di Giorgione nella tavola del Santo,
quando Cristo il chiamò all'Apostolato; e sogghignando, e
meravigliandosi di tanto rumore, voltò le spalle, e andossene con
Dio.” .
Sappiamo che Federico Zuccari, principe dell'Accademia
di San Luca, strenuo
difensore dell'arte classicista, nutre verso i modi
caravaggeschi una vera e propria avversione, pertanto nel domandarsi
cosa sia quel “rumore”, innescato dalla visione dei quadri appena
scoperti, intende,
quasi certamente, esprimere fastidio e stupore
per l'accoglienza positiva manifestata dalla gente, se sottintesi
ci fossero stati derisione e biasimo, in riferimento al “rumoro”,
il pittore non si sarebbe sorpreso della situazione. Il popolo
dimostra ammirazione e l'Accademico se ne va indignato, dopo aver
espresso il suo giudizio pungente, contrario all'unanime plauso e
chiacchiericcio del pubblico plebeo.
Sono
sempre gli “schiamazzi”, riporta il Baglione, ad indurre il
marchese Vincenzo Giustiniani, collezionista del Merisi, che si
assicura la prima versione del San Matteo, ad “invaghirsi”
delle opere del Milanese, gli stessi che fanno “cadere
al romore anche Ciriaco Matthei” ,
il quale commissiona al Pittore diversi opere .
A
riprova della neutralità del termine, in riferimento agli
“schiamazzi” per la Madonna di Loreto (1604-06, olio su
tela, 260 cm x 150 cm. Roma, Chiesa di Sant'Agostino) ,
il popolo, nelle parole dell'Autore, reagisce alle “leggerezze”,
non indecenze come interpreta la critica successiva, dei piedi
sporchi dei panni stracciati e sudici, con “estremo schiamazzo”,
probabile segno di approvazione per un racconto pittorico in cui
verosimilmente il volgo si riconosce, a conferma dell'efficacia
dell'azione pittorica del Maestro .
Non
riconosciamo, dunque, quelle connotazioni di indignazione e
sbigottimento, per poco decoro in relazione a quello “estremo
schiamazzo” testimoniato dal Baglione, che gli interpreti
tardo-secenteschi, settecenteschi ed ottocenteschi hanno voluto
individuare. Tale considerazione è avvalorata dal fatto che
l'invidia e l'inimicizia provate dal Biografo per il Lombardo lo
inducono, ove possibile, a scriver male dell'Artista, capace di
produrre mere “teste” e non “historie” come gli
“altrui” pittori ,
ma alla fine, per onestà intellettuale, non può non riconoscere
che Michelangelo abbia conseguito un “gran
credito”
presso un pubblico, connotato però da “incompetenza”
.
Tra
coloro che non hanno una piena considerazione del Pittore, in quanto
orientati in senso più classicista, c'è il diplomatico
pontificio, vescovo e scrittore, Giovanni Battista Agucchi (1570
– 1632) che, nel suo Trattato sulla pittura ,
riferisce a proposito del Milanese che è “eccellentissimo nel
colorire” ma che “ha lasciato indietro l'Idea della bellezza,
disposto di seguire del tutto la similitudine” ,
in sostanza il Monsignor non plaude all'eccessivo realismo. Del
medesimo parere è il medico privato di Papa Urbano VIII e
conoscitore d'arte dilettante, Giulio Mancini, che, nelle sue
Considerazioni, rileva una grande capacità di riprendere dal
vero, il cui impegno, però, va a scapito della narrazione e dei
sentimenti! E, infatti, sul Maestro scrive: “Proprio di questa
schola [di Caravaggio] è di lumeggiar con lume unito che venghi
d'alto senza reflessi, come sarebbe in una stanza da una fenestra con
le pariete colorite di negro, che così, havendo i chiari e l'ombre
molto chiare e molto oscure, vengono a dar rilievo alla pittura [...]
Questa schola in questo modo d'operare è molto osservante del vero,
che sempre lo tien davanti mentre ch'opera; fa bene una figura sola,
ma nella compositione dell'historia et esplicar affetto, pendendo
questo dall'immagination e non dall'osservanza della cosa, per ritrar
il vero che tengon sempre avanti, non mi par che vi vagliano, essendo
impossibil di mettere in una stanza una moltitudine d'huomini che
rappresentin l'historia con quel lume d'una fenestra sola, et haver
un che rida o pianga o faccia atto di camminare e stia fermo per
lasciarsi copiare, e così poi le lor figure, ancorché habbin forza,
mancano di moto e d'affetti, di gratia, che sta in quell'atto
d'operare come si dirà” .
Nella
seconda metà del XVII secolo, il già citato, Pietro Bellori,
scrittore, antiquario e storico dell'arte, abbiamo visto, considera
il Merisi un “pervertitore” dell'arte nonché “veleno
perniciosissimo” ,
nelle sue Vite, cavalca una posizione
classicistico-accademica, poco incline al nuovo stile caravaggesco,
che, non è un segreto, non apprezza affatto .
La sua biografia, però, ci è utile per corroborare la connotazione
originaria dei termini impiegati dal Baglione: e, a proposito della
Madonna lauretana, riferisce che “In Santo Agostino si
offeriscono le sozzure de' piedi del pellegrino”
e nonostante un procedere tutt'altro che decoroso (“tolta ogni
autorità all'antico e a Rafaelle” )
molti “invaghiti dalla sua maniera l'abbracciavano volentieri
(…). All'hora cominciò l'imitazione delle cose vili,
ricercandosi le sozzure e le deformità, come sogliono fare alcuni
ansiosamente: se essi hanno à dipingere un armatura, eleggono la più
rugginosa, se un vaso, non lo fanno intiero, masboccato e rotto. Sono
gli habiti loro calze, brache, e berrettoni, e così nell'imitare
li corpi, si fermano con tutto lo studio sopra rughe, e i difetti
della pelle e dintorni, formano le dita nodose, le membra alterate da
morbi. Per li quali modi il Caravaggio incontrò dispiaceri,
essendogli tolti li quadri da gli altari come in San Luigi (…)”
.
Le
parole del biografo, testimoniando del plauso tra pittori e
committenti del nuovo e “ansiosamente” ricercato modus
operandi del Merisi, vanno a beneficio di un'interpretazione
non negativa degli “schiamazzi” e del “rumore” di baglionesca
memoria.
Di
qualche anno più tardi è il trattato del Conte Carlo Cesare
Malvasia (1616-1693), anch'egli si dimostra critico nei confronti
della pittura del Nostro: “Non poté mai tollerare [si riferisce
all'Albani a cui è dedicato il capitolo], che si seguitasse
il Caravaggio, scorgendo essere quel modo il precipitio, e la
totale ruina della nobilissima, e compitissima virtù della Pittura,
poiché, se bene era da laudare in parte la semplice imitatione, era
nondimeno per partorire tutto quello, che ne è seguito in progresso
di 40 anni. [...] Non possono essere i Pittori egualmente eccellenti
in tutte le parti. Se il Caravaggio havesse havuto questi requisiti
saria stato Pittore dirò Divino, questo, non haveva cognitione nelle
cose sopranaturali, mà stava troppo attaccato al naturale” .
Unica
voce fuori dal coro, tra le fonti tardo-secentesche, è la
testimonianza di Giovan Battista Passeri che nelle sue Vite
dimostra di apprezzare il lavoro rivoluzionario del Milanese:
“Michel'Angelo da Caravaggio fece qualche giovamento al gusto di
quella nuova Scuola, perché, essendo uscito fuora con tanto empito,
e con quella sua maniera gagliarda, fece prender fiato al gusto
buono, et al naturale, il quale allora era bandito per la vita e reso
contumace dal comercio umano, e precipitato nell'abisso d'una
maniera ideale, e fantastica ad uso delle Grottesche dell'India.
Ben'à vero, che egli non rese adorno il gusto con quelle vaghezze,
con le quali la Scuola Caracciesca l'ha portato, pieno di
piacevolezze, e di delizie, ricco nelli componimenti, adorno
d'accompagnature, e discreto in tutto il portamento; tutta via
aperse una fenestra per la quale fece rivedere la Verità, che si era
già smarrita” .
La
letteratura artistica della seconda metà del ‘600 si rivela,
dunque, se non apertamente ostile alla pittura caravaggesca e alla
sua poetica naturalistica, poco disposta ad accogliere le istanze
estetiche da cui prende dichiaratamente le distanze. Da questo
momento in poi la figura del Pittore viene gradualmente
marginalizzata fino a essere relegata a un lungo periodo di oblio
critico-storiografico che cessa solo con lo sviluppo dall'intenso e
vivace dibattito degli anni Venti del secolo scorso.
La
successiva letteratura neoclassica, infatti, continua sulla medesima
impostazione e ritiene il Caravaggio un artista poco valido: Anton
Rafael Meng, teorico del Neoclassicismo, assieme a Johan Joachim
Winckelmann, nelle sue lezioni di pittura, scrive che
l'Artista “non aveva ne varietà ne correzione; e perciò era
tutto cattivo nel disegnò” .
Meno lapidario il resoconto di Stendhal (Rome, 1806), il
quale, nel suo Diario di viaggio, afferma che “per
l'orrore ch'egli sentiva dell'ideale sciocco, il Caravaggio non
correggeva nessuno dei difetti dei modelli ch'egli fermava nella
strada per farli posare. Ho veduto a Berlino alcuni suoi quadri che
furono rifiutati dalle persone che li avevano ordinati perché troppo
brutti. Il regno del brutto non era ancora” ,
l'affermazione evidentemente rammenta e suggella il mito dei quadri
rifiutati di cui parleremo in seguito.
Durante
il XIX secolo, in piena temperie romantica, l'interesse per
Caravaggio risorge, ma non senza ambivalenze. Alcuni critici lo
rivalutano per il suo anticonformismo e la drammaticità ,
per altri, invece, continua ad essere colui che non ha avuto rispetto
per l'arte .
All'inizio
del ‘900 Alois Riegl, storico dell'arte della scuola viennese, lo
celebra come un “Genie” (“II pittore che diede inizio al
movimento doveva quasi per necessità naturale essere un uomo
incolto, privo d'interessi per un passato culturale che non
conosceva- Ma, ciononostante, un genio che seppe portare con sé
anche la cultura attraverso i modi con cui attuò le proprie
personalissime intenzioni. Questi sono appunto i tratti
dell'iniziatore: Michelangelo da Caravaggio. Un uomo incolto ma un
genio”) ,
ma dobbiamo attendere il lavoro appassionato di studio e ricerca che
Adolfo Venturi e i suoi allievi mettono in campo a partire dagli anni
Venti del ‘900 per assistere al recupero della sua figura.
Con
Adolfo, sebbene persista un certo e sospettoso distacco nei confronti
di un'arte che continua a “disturbare” per troppa sfrontatezza,
violenza luministica e commistione tra sacro e profano, inizia un
timido, ma decisivo cambio di rotta, il Nostro è celebrato come il
precursore dei massimi geni del Seicento europeo .
Ma sono i suoi studenti a gettare una nuova luce sul Pittore:
Lionello Venturi ,
Roberto Longhi e, in misura minore, Antonio Muñoz si dedicano alla
ricerca per dare una soluzione alla neonata “questione
caravaggesca” e alla più generale rivalutazione della pittura
italiana del ‘600
che continua ad essere la cenerentola dell'arte per via
dell'imperante pensiero pregiudizievole, idealista, di stampo
crociano sul periodo barocco .
“Quando
guardiamo la Vocazione di San Matteo ci accorgiamo – scrive
Lionello Venturi - che qualcosa di nuovo è avvenuto, qualcosa che ha
mutato l'arte di Michelangelo da Caravaggio. Un nuovo modo di
subordinare ogni immagine all'effetto generale di luce e ombra appare
evidente, e poiché questo modo è essenziale a tutte le opere
posteriori, si può dedurne che il periodo delle ricerche è finito e
che lo stile dell'artista è perfettamente realizzato. Ci sono stati
in tutti i tempi dei pittori realisti, che sono stati grandi artisti.
Non perché abbiano riprodotto la realtà empirica in modo illusorio,
ma perché l'hanno interpretata, e cioè veduta e sentita, a seconda
della loro fantasia. E la loro differenza dai pittori della 'idea' è
che questi evadono fantasticamente dalla realtà, mentre i
'naturalisti' interpretano la realtà e ne danno ciò che a loro
sembra l'essenza. Giotto e Masaccio sono realisti come il Caravaggio,
con questa differenza, ch'essi sono realisti senza un preciso
programma, e il Caravaggio dovette farsi un programma per liberare
polemicamente la propria fantasia da un groviglio di regole e di
pregiudizi che il manierismo voleva imporgli” .
E se
l'avvio del rinnovato interesse sul Merisi si deve al giovane
Lionello, un di poco più giovane Longhi non rimane indifferente al
tema e inaugura la sua carriera con una tesi sull'Artista, discussa
con Pietro Toesca, allievo di Adolfo, nel 1911, all'Università di
Torino .
Alla fine degli anni Venti, scrive i celebri Quesiti caravaggeschi
(1928-1929) ,
ancora oggi punto di riferimento di fondamentale importanza per gli
studi sul Pittore, in cui la riflessione sulla dimensione
naturalistica dell'arte del Maestro, associata al retroterra
figurativo lombardo, particolarmente orientato in senso realistico,
contraddicono le appena diffuse tesi marangoniane che vorrebbero un
Merisi antirealistico!
“Dalle
esperienze luministiche dei suoi precursori, fra cui erano anche quel
Lotto che il Lomazzo [...] chiama "maestro del dare il lume"
e quel Savoldo in cui il Pino esalta "le ingegnose descrittioni
dell'oscurità", il Caravaggio scopre "la forma delle
ombre": uno stile dove il lume, non più asservito, finalmente,
alla definizione plastica dei corpi su cui incide, è anzi arbitro
coll'ombra seguace della loro esistenza stessa. Il principio era per
la prima volta immateriale; non di corpo ma di sostanza; esterno ed
ambiente all'uomo, non schiavo dell'uomo [...] Che cosa importasse
questo nuovo stile nei confronti col Rinascimento ch'era invece
partito dall'uomo, e vi aveva sopra edificato una superba mole
antropocentrica, cui anche la luce era anodina servente, è facile
intendere. All'artificio, al simbolo drammatico dello stile attendeva
ora il lume medesimo, non l'idea che l'uomo poteva aver formato di se
stesso. Ma quando in un battito del lume una cosa assommasse, e
poiché non era più luogo a preordinarla nella forma, nel disegno,
nel costume, e neppure nella rarità del colore, essa non poteva
sortire che terribilmente naturale. Il dirompersi delle tenebre
rilevava l'accaduto e nient'altro che l'accaduto; donde la sua
inesorabile naturalezza e la sua inevitabile varietà, la sua
incapacità di "scelta". Uomini, oggetti, paesi, ogni cosa
sullo stesso piano di costume, non in una scala gerarchica di
degnità...” .
E, a proposito, della
consapevole scelta di Michelangelo di non voler perseguire l'apologia
del corpo umano della tradizione classico-classicistica,
dall'antologia degli scritti del Torinese leggiamo: “La sua
ostinata deferenza al vero poté anzi confermarlo nella ingenua
credenza che fosse "l'occhio della camera" a guardar lui e
a suggerirgli tutto. Molte volte dovette incantarsi di fronte a
quella "magia naturale"; e ciò che più lo sorprese fu di
accorgersi che allo specchio non è punto necessaria la figura umana,
se, uscita questa dal suo campo, esso seguita a specchiare il
pavimento inclinato, l'ombra sul muro, il nastro caduto a terra. Che
altro potesse conseguire a questa
risoluzione di procedere dipingendo per specchiatura diretta della
realtà, non è troppo difficile intendere. Ne conseguiva la tabula
rasa del costume pittorico del tempo che, preparandosi gli argomenti
in carta e matita per via di erudizione storica e di astrazione
stilizzante, aveva elaborato una complessa classificazione del
rappresentabile, dove, per meglio servire alla società di allora,
non poteva che preferirsi l'aspetto della classe dominante. Ma il
Caravaggio pensa invece alla vita comune, ai sentimenti semplici,
all'aspetto feriale delle cose che valgono, nello specchio, come gli
uomini. [...] Anche il Caravaggio avvertiva il pericolo di ricadere
nell'apologetica del corpo umano, sublimata da Raffaello o
Michelangelo, o magari nel chiaroscuro melodrammatico del Tintoretto.
Ma ciò che gli andava confusamente balenando era ormai non tanto il
rilievo dei corpi quanto la forma delle tenebre che li interrompono.
Lì era il dramma della realtà più portante ch'egli intravedeva
dopo le calme specchiature dell'adolescenza. E la storia della
religione, di cui ora si impadroniva, gli tornava come un seguito di
drammi brevi e risolutivi la cui punta non può indugiarsi nella
durata sentimentale delle trasparenze, anzi inevitabilmente s'investe
del lampo abrupto della luce rivelante, fra gli strappi inconoscibili
dell'ombra. Uomini e santi si sarebbero impigliati in quel tragico
scherzo. Giacché, per restar fedeli alla natura del mondo, occorreva
far sì che il calcolo dell'ombra apparisse come casuale, e non
causato dai corpi; ove volesse esimersi dal riattribuire all'uomo la
sua funzione umanistica dirimente, di eterno protagonista e signore
del creato. Perciò il Caravaggio seguitò, e fu fatica di anni, ad
osservare la natura della luce e dell'ombra incidentali. [...] Chi
non sa che il Tintoretto studiava al lume di lucerna, non già il
vero, ma i modellini della Cappella Medicea? E che i modellini del
Greco erano cere dove si stiravano in una poetica follia le ultime
spire laocoontiche del disegno 'serpentinato'? Ma ora è la realtà
stessa a venir sopraggiunta dal lume per 'incidenza': il caso,
l'incidente luminoso, diventano causa efficiente della nuova pittura
(o poesia). Non v'è Vocazione di Matteo senza che il raggio, assieme
col Cristo, entri dalla porta socchiusa e ferisca quel turpe
spettacolo dei giocatori d'azzardo. In effetto Caravaggio stagliò
questa sua "descrizione di luce", questo poetico
"fotogramma", quando l'attimo di cronaca gli parve
emergere, non dico con un rilievo, ma con uno spicco, con un'evidenza
così memorabile, invariabile, monumentale, come dopo Masaccio non
s'era più visto” .
La lunga resistenza del
gusto idealizzante, di stampo belloriano, alla carica destabilizzante
del linguaggio caravaggesco, nutrito di realismo popolare, per cui
l'arte del Maestro stigmatizzata dalla bieca e moralistica visione
classicista, come antipoetica, sconveniente, indecorosa perché
“naturalista”, nel primo ‘900 viene, quindi, lentamente a
desistere nel panorama di un rinnovato interesse per il Barocco .
Ma lo “schiamazzo” e il “rumore”, in questa fase, continuano
a essere associati a significati negativi di disapprovazione e
biasimo per aver infranto i codici del decoro religioso, sovvertendo
l'ordine visivo-culturale della tradizionale iconografia. Solo nel
XXI secolo la critica comincia a rivisitare la semantica dei termini,
per cui il clamore risonante diventa stupore e non solo scandalo, lo
fa Pamela M. Jones ,
Marco Pupillo ,
Andrea Lonardo
ed altri, mentre contrario a questa lettura rimane Sergio Rossi per
il quale il termine non può avere avuto un significato positivo,
poiché, il malanimo del Baglione, afferma lo storico, piuttosto che
scriver bene di Caravaggio avrebbe preferito fare “la fine di
Giordano Bruno” .
Ma è anche vero che tra le righe del suo racconto l'animoso
Biografo riconosce al Nostro una certa bravura .
Da questa
riconsiderazione semantica delle parole usate dallo Scrittore emerge
la delicata questione dei rifiuti (o non-rifiuti) di alcune opere del
Merisi. Ancora oggi la cultura popolare si nutre della leggenda,
ripetuta per tre secoli, per la quale il Caravaggio, artista
maledetto, abbia collezionato clamorosi rifiuti, nutrendo
l'immaginazione dei più con fantomatiche e burrascose scene di
liti fra il Pittore e i suoi committenti. Abbiamo già detto come
spesso i resoconti dei biografi secenteschi (Baglione e Bellori),
volti a minare e screditare il Pittore, abbiano distorto pesantemente
la realtà degli avvenimenti e solo a partire dalla prima metà del
secolo scorso, attraverso un intenso lavoro di ricerca e recupero si
è giunti a far luce su alcuni episodi.
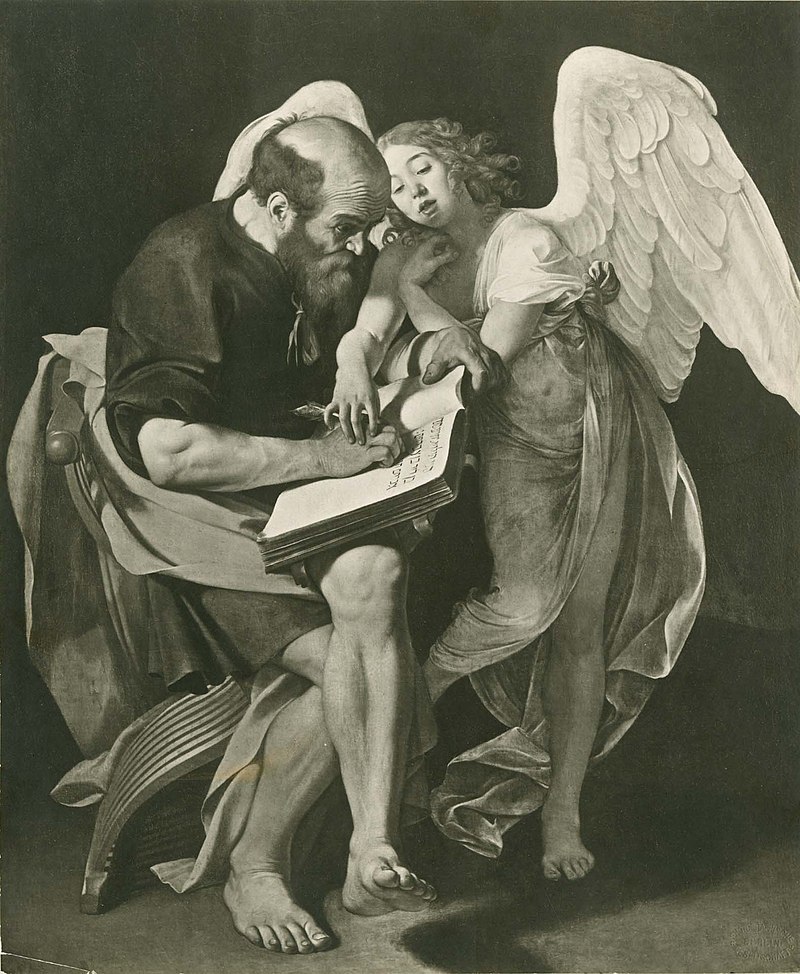 Fig. 3 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
Fig. 3 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
San Matteo e l'angelo, 1599, olio su tela
223 × 183 cm, opera perduta (fotografia colorata)
Cortesia di Giorgia Duò
La prima tela ad essere
riferita, a torto, un rifiuto, è la versione “originale” del S.
Matteo e l'angelo per la Cappella Contarelli (Fig. 3) .
La testimonianza del bilioso Baglione afferma che il dipinto “non
era (a) veruno piaciuto” ,
ad essa fa eco la successiva attestazione del Bellori secondo la
quale “avendo egli terminato il quadro di mezzo di San Matteo e
postolo su l'altare, fu tolto via dai preti, con dire che
quella figura non haveva decoro, né aspetto di santo, stando a
sedere con le gambe incavalcate e coi piedi rozzamente esposti al
popolo” .
Il malevolo Giovanni non racconta, però, di alcun rifiuto, ma
semplicemente riporta di un generico mancato apprezzamento,
fors'anche strumentale, della tela, sarà poi il fazioso
classicista romano a raccontare falsamente di una “rimozione”,
nessuna cronaca coeva al Pittore, infatti, ha lasciato intendere che
vi sia stato un ripensamento, per mancanza di decoro o irriverenza,
da parte dei confratelli di San Luigi dei francesi, a cui per
altro non spetta alcuna decisione al riguardo, poiché trattasi di
una commissione privata, della famiglia Contarelli.
Lo storico dell'arte
Luigi Spezzaferro, allievo di Argan, a partire dagli anni '80 del
secolo scorso, si dedica alla questione, e giunge, nel 2001, alla
formulazione della teoria per la quale la primitiva tela d'altare è
realizzata come elemento provvisorio, per consentire il normale
svolgimento delle funzioni liturgico-devozionali, in attesa
dell'opera definitiva del 1602 .
La composizione primitiva ha, quindi, assunto in tal modo un ruolo
centrale per il dinamico e florido mercato antiquariale, il dipinto
diventa, infatti, ambito “oggetto” di interesse per il fenomeno
del Collezionismo seicentesco .
Anche Calvesi inquadra la
vicenda della pala d'altare nel contesto della funzionalità
liturgico-devozionale, non come lo Spezzaferro, che riconduce la
sostituzione ad una necessità pratica, ma secondo un'ottica di
fede. In contrasto con quanto asserito dal credo ugonotto-francese,
per cui la salvezza è indipendente dalla volontà dell'individuo,
lo Storico ritiene il “bellissimo” San Matteo (un uomo
dalle ruvide fattezze di contadino analfabeta) figlio della rinnovata
disciplina uscita dal Concilio di Trento, così come recepita
in ambiente borromaico, per la quale l'uomo reprobo e peccatore è
capace di scegliere la grazia .
Ma la schietta
iconografia proposta dal Maestro, radicata nelle dispositiones
pauperistiche di area lombarda, cozza con le istanze tridentine
propugnate della Chiesa Trionfante Romana e all'indomani
della sua realizzazione, il Nostro, ben conscio ed informato
sull'estetica, aspetto e messaggio che le opere religiose devono
veicolare nella Roma del Seicento, può aver deciso
l'avvicendamento, in quanto la tela evidentemente non corrispondeva
alle richieste e ai precetti della Controriforma, sia dal
punto di vista teologico (un Santo troppo umile) che da quello
tecnico (forma e misure del quadro non rispettano le indicazioni
generali per le quali le pale d'altare devono avere un andamento
verticale (come la seconda versione di 295 x 195 cm), mentre il primo
San Matteo tendeva al quadrato (223 x 183 cm)).
A sostenere la versione
del “non rifiuto”, ma della scelta personale, c'è la
considerazione del Marini, secondo cui il dipinto perso, inserito
sull'altare, nel contesto della Cappella, per via di forma e
dimensioni ridotte, non avrebbe potuto reggere il costante confronto
con i laterali, di dimensioni molto più grandi del pannello
centrale. Pertanto ritiene che “la prima pala della Contarelli non
sia oggetto di un vero e proprio rifiuto (…) bensì di un
‘perfezionamento' o, meglio, di una più esplicita declinazione
controriformista rispetto alla traccia del 1591 da cui dipendono la
statua del Cobaert, il dipinto non eseguito del Cesari e,
naturalmente, il primo San Matteo del Caravaggio” .
Per lo studioso, infine, si è trattato di un momento nodale per la
crescita artistica del Pittore.
In
linea con la tesi della scelta di sostituire il quadro con una
seconda versione, è anche Rossella Vodret, esperta del Maestro, già
Soprintendente del Polo Museale della città di Roma, la quale pensa
che dopo aver collocato l'opera sull'altare l'Autore si sia
reso personalmente conto di due elementi dissonanti: il quadro si
mostrava sottodimensionato rispetto sia allo spazio del vano che
alle tele della Chiamata e del Martirio, e, dunque, mal
si inseriva nel contesto della Cappella, inoltre, la
composizione, autentica e originale, ma raffigurante un soggetto poco
diffuso nella Roma dell'epoca, e quindi, poco conosciuto dai
fedeli, avrebbe potuto prestarsi ad incomprensioni ed equivoci .
A partire da queste valutazioni la studiosa presume che la tavola
abbia assunto, quasi subito, il carattere di provvisorietà,
favorendone la sostituzione con una composizione più consona ed
allineata alle concezioni d'ispirazione divino-religiosa, dettate
dal Concilio del 1546. Dall'opera in situ, infatti,
risulta chiaro il messaggio di matrice cattolica per cui l'uomo
collabora con Dio attraverso un messo-angelo .
Un
vero e proprio giallo è, invece, quello relativo alla prima versione
della Conversione di Saulo (Fig. 4), della Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo
(Roma).
 Fig. 4 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
Fig. 4 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO
Conversione di Saulo, 1600-1601
olio su tavola di cipresso, 237 × 189 cm
Roma, Collezione Odescalchi
Cortesia di Giorgia Duò
Del quadro abbiamo molte informazioni (la data di
realizzazione, il committente, i passaggi di proprietà), non
conosciamo, però, il motivo dell'avvicendamento delle tavole con
le versioni su tela, decoranti attualmente il vano-Cappella
(Conversione di San Paolo, 1600-1601, olio su tela, 230 ×
175 cm, Roma, Basilica di Santa Maria del Popolo; Crocifissione di
San Pietro 1600-1601, olio su tela, 230 × 175 cm, Roma, Basilica
di Santa Maria del Popolo) .
Il
solito Baglione riporta di un rifiuto ,
ma nessuna altra fonte secentesca successiva, conferma il diniego, il
Bellori, a proposito del quadro parla sinteticamente di una “historia
affatto senza attione”, senza aggiungere ulteriori dettagli utili a
risolvere l'enigma .
Neanche il Mancini, mai avaro di informazioni, menziona il rifiuto,
ma cripticamente restituisce solo il passaggio in collezione Sannesio
,
ragion per cui, in questi ultimi anni, la critica contemporanea ha
preferito orientarsi diversamente, non propendendo per il rifiuto,
ma, ancora una volta, per una precisa scelta del Maestro .
Nel
1951, lo storico ed esperto del Caravaggio, Sir Denis Mahon sostiene
che sia stato il Milanese, di sua iniziativa, a decidere di
sostituire i quadri originari d'ascendenza ancora manierista, con
due nuove composizioni, probabilmente su impulso derivato dal
confronto con l'Assunzione del Carracci (1600-1, olio su
tela, 2,45 x 1,55 m. Roma, Chiesa di Santa Maria del Popolo,
Cappella Cerasi), L'ipotesi si basa sull'eventualità che
egli possa aver sentito la necessità di dare una risposta più
attuale alla suggestione di forte modernità nata dall'osservazione
della tela di Annibale .
Quindi, il Pittore potrebbe aver riflettuto sull'invenzione
carracesca dopo il compimento delle tavole ed aver deciso per una
nuova formulazione delle sue historie. E allora il momento in
cui il Cerasi entra in possesso della pala d'altare diventa
decisivo, ma non ci sono documenti al riguardo, e si ritiene che la
mancanza di documentazione di incarico/consegna nell'archivio del
tesoriere, costituisca di per sé un elemento a favore della tesi per
cui la tela possa essere stata oggetto di dono da parte del card.
Odoardo Farnese, patrono di Annibale ,
e dunque il prelato potrebbe essere già entrato in possesso nel
1600, ossia, prima dell'incarico al Caravaggio .
Contro questa possibilità, sostenuta anche negli anni Settanta dal
Posner ,
è l'evenienza che l'Assunzione potrebbe essere stata
consegnata, prima della sua morte, pertanto Caravaggio avrebbe potuto
avere accesso all'opera, e quindi portare avanti la sua riflessione
personale, già al momento della commissione iniziale.
Anche
lo Spezzaferro opta per una riformulazione dei quadri dettata da una
scelta personale e ritiene che il pagamento da parte dell'Ospedale,
inferiore al pattuito, di soli 400 scudi ,
possa essere derivato proprio da questo cambiamento, frutto di una
ricontrattazione, più vantaggiosa per entrambe le parti .
Ulteriore posizione favorevole, è quella di Stephen Pepper che vede
nell'avvicendamento l'esito di una sfida “gomito a gomito”
tra i due artisti, Caravaggio può aver subito il peso del lavoro del
Bolognese e aver considerato le proprie composizioni non all'altezza
della moderna historia carraccesca ,
per Annibale, non è un segreto, che Michelangelo nutra apertamente
una certa ammirazione .
D'altra parte è plausibile che i due campioni si siano influenzati
a vicenda, essi, infatti, sono assolutamente consapevoli di trovarsi
al centro di una sfida sulla moderna pittura, latori di stili diversi
in via di affermazione, i Due sono chiamati a misurarsi
pubblicamente, alimentando una vera e propria competizione aperta .
E, infatti, in un Avviso di quei giorni si legge: “Alli
giorni passati si scoperse la non men vaga che bella galleria del
Ill.mo cardinal Farnese dipinta dal Carracci Bolognese (…) hora si
scorse che Roma fiorisce nella pittura, non meno che abbia fatto a
tempi a dietro. Attendesi ora a finir la sala di Campidoglio del cav.
Giuseppe, li dua quadri che fa il Caravaggio per la capella del già
Mons. Ceraseo, tesauriero, il quadro principale in essa capella di
detto Caraccio, essendo in somma quei tre quadri di tutta eccellenza
e bellezza” .
Intrepreta
diversamente la affermazione baglionesca il Longhi che, non sposando
l'idea del confronto tra l'Emiliano e il Nostro, riconduce la
scelta della sostituzione delle tavole ad una questione squisitamente
tecnica: non già, cioè, perché non sia piaciuta al committente,
piuttosto perché il cambio prevede il compimento di altri dipinti
con la tecnica dell'olio su tela al Pittore più congeniale del
supporto in legno
e, per ovviare all'umidità che avrebbe potuto rovinare le tele
prevede di porre un'armatura di travi lignee per isolare i quadri
dalle pareti ,
Calvesi,
nel '73, non addentrandosi nella questione, perché orientato ad
approfondire altri aspetti, riferisce semplicemente del rifiuto letto
nel Baglioni,
nel decennio seguente, rivede la sua posizione e ipotizza che possa
esservi stata una sostituzione come chiaro gesto di volontà, senza,
peraltro, analizzare significativamente la vicenda, ma limitandosi a
segnalare la conclusione .
Sostenitrice
di questo misterioso “scambio” diretto è anche la Vodret, la sua
convinzione si basa sul fatto che le tele attualmente nella Cerasi,
oltreché diversissime dal punto di vista stilistico, manierista
la prima, pienamente inserite nella nuova, lucida ed essenziale
visione della realtà elaborata dal Milanese, le seconde, esternano
una consapevolezza del contesto architettonico che la tavola
Odescalchi evidentemente non possiede. Di questa cognizione spaziale,
già, nel 1959, si è accorto Leo Steinberg che ha ascritto
l'adattamento attuato da Caravaggio allo spazio, come un'azione
di zelo volta ad esaltare la potenza essenziale delle sue opere .
Per il critico americano, come per la Storica, si è, dunque,
trattato di una precisa scelta estetico-visuale attuata dal Lombardo
coscientemente, in funzione dell'ambiente.
E
allora il Maestro potrebbe aver iniziato a lavorare alle tavole,
senza aver ben chiaro le dimensioni del vano, e, concluse le quali,
esse rimangono, abbiamo visto, nel suo atelier in attesa della
sistemazione architettonica della Cappella da parte del
Maderno, al termine della quale, si rende probabilmente conto che i
dipinti mal si inseriscono in quello stretto corridoio, ma
necessitano di un punto di vista diverso, di più ampio respiro,
rispetto a quello consentito dall'angusto spazio. La circostanza
può aver allora generato nel Maestro un senso di frustrazione,
nonché averlo indotto, in un momento non bene precisato, a prendere
la decisione di produrre i due sostituti che meglio potessero
interpretare la concezione spaziale del piccolo ambiente: un punto di
vista molto ravvicinato, di massimo 1,5 metri. Le tele della seconda
versione, infatti, sembrano essere elaborate in funzione della
ridotta spazialità e mostrano quella maturazione stilistico-creativa
tipica degli anni successivi. Questa ipotesi posticiperebbe la
datazione dei due quadri ancora in situ, solitamente ascritti,
sulla base del contratto, al 1600-1601, a un momento successivo e più
coerente con la parabola artistico-stilistica del Merisi (1604-05) .
Altra
opera su cui è calato il giudizio di un finto rigetto è la Madonna
del serpe o
dei Palafrenieri
(1605, olio su tela, 292 x 211 cm, Roma, Galleria
Borghese) ,
sembra, infatti, che il Cardinal Scipione
Borghese, noto ammiratore delle opere del Caravaggio,
abbia orchestrato la
rimozione del dipinto, dissimulando la propria bramosia per il
quadro, dietro il falso rifiuto. La tela, dunque, non subisce un
diniego, ma viene piuttosto “opzionata” dal Borghese per la
propria quadreria.
Dipinta
in pochi mesi, l'8 aprile del 1606, è esposta alla pietà dei devoti
alla presenza dello stesso Pittore, quindi, rimossa dall'altare a
distanza di pochi giorni, viene trasferita nella vicina chiesa
di Sant'Anna dei Palafrenieri,
nella stessa area vaticana, da dove Scipione la compra per soli 100
scudi .
Vi
è raffigurata una Madonna
nelle vesti di una
popolana verace, in compagnia di un bambino cresciuto ed una
visibilmente anziana, provata dalla vita, S.
Anna. L'opera avrebbe
dovuto decorare il nuovo altare della Confraternita, ricavato nella
Basilica di San Pietro,
appena ristrutturata, ma a qualche giorno dall'inaugurazione, viene
rimossa. Sui motivi che hanno portato al trasferimento si è molto
discusso, tradizionalmente la critica si è orientata sulla questione
iconografica: il dipinto si mostra eccessivamente “popolare”, con
un'invenzione troppo aderente alla realtà che toglie il senso del
sacro. Spiegazioni, per altro speculative, stante l'incertezza
generale che avvolge il quadro e la sua storia, sono ascrivibili a
ragioni teologiche e di decoro, per una rappresentazione non
rispettosa dei canoni tridentini, nonché brutale e realistica che
non svolge sui fedeli la funzione attribuita ad una pala d'altare.
In particolare oggetto di accusa sono: in
primis la provocante
Maria, il cui elegante e rosso abito, evidenzia un procace e formoso
seno, sottolineato da una scollatura velata di stoffa trasparente,
che poco concede all'immaginazione; il Gesù-ragazzino,
non più in età da
esibire una nudità
completa, la cui collocazione in primo piano, in scala maggiore del
naturale crea un effetto forzato e di imbarazzo, per troppa
vicinanza. sul riguardante; anche il gesto compiuto dai due che
agendo contro il male, calpestando in modo vigoroso il serpente, con
un fare esageratamente “terreno” e veemente, mal si addice allo
status
di santi cristiani; infine, l'anziana madre Meterza, protettrice
dei Palafrenieri e dunque soggetto principale della composizione, di
aspetto troppo plebeo e in posizione dimessa, raffigurata come
un'umile vecchia contadina, con mani, volto e decolté
segnati visibilmente dal tempo e dal lavoro all'aperto,
iconograficamente è troppo lontana dalla forma ideale di una Santa.
Negli
anni Cinquanta del secolo scorso, però, gli studi e le analisi di
diversi storici hanno superato queste “dicerie”, nate dalla
propaganda anticaravaggesca, già segnalata, che ha nell'invidioso
Baglione il suo iniziatore e che si assesta e continua attraverso il
Tardo-seicento fino a tutto l'Ottocento ,
e Walter Friedländer, seguito e sostenuto da Jacob Hess ,
suggerisce, sulla base delle sue ricerche che il “rifiuto” non
abbia implicazioni dogmatico-iconografiche, piuttosto sia dovuto
all'incompatibilità di spazio tra una tela di grandi dimensioni,
come quella concepita dal Lombardo, e un sacello troppo angusto il
cui piccolo altare dedicato alla S.
Anna mal avrebbe accolto
il quadro. Inoltre, lo studioso consultando gli archivi ha
individuato da parte di alcuni Confratelli la volontà di trovare
comunque una degna sistemazione alla pala del Maestro .
Questa circostanza da sola confuterebbe il rifiuto, ma viene
subdolamente manipolata, dalle smanie collezionistiche di Scipione,
desideroso di entrare in possesso del dipinto caravaggesco, che
chiede l'intervento dello stesso papa affinché si rimuova il
dipinto. Successivamente lo Spezzaferro lega la vicenda della
rimozione a quella del rifiuto della Morte
della Vergine per Santa
Maria delle Scala (fig.
2), l'esperto riporta che
i Palafrenieri in cerca di una soluzione percorribile, chiedano il
parere di Tolomeo Gallio di Como ,
Cardinale e Segretario di Stato Pontificio, virtuoso
controriformato, il quale memore della recentissima vicenda
trasteverina, di qualche giorno prima, può aver consigliato la
rimozione .
L'opinione del Gallio può, inoltre, essere stata influenzata da
dinamiche più politiche che teologico-culturali, filospagnolo il
primo, d'ambiente filofrancese il secondo, i cui mecenati e
protettori sono legati agli interessi di area francese, i pareri di
ricusazioni emessi dal clerico, anche se attualmente non dimostrati,
potrebbero aver avuto il fine di perseguire equilibri di altro
genere.
Negli
stessi anni, Salvatore Settis, professore alla Normale
di Pisa, rileva che
l'invenzione caravaggesca presenta, effettivamente, soluzioni un
po' eccessive per un dipinto religioso, in particolare, la
rappresentazione della Sant'Anna,
patrona dei Palafrenieri, potentemente umana e perturbante,
raffigurata come una vecchia popolana rugosa in posizione quasi
subalterna rispetto alla Vergine
con bambino, potrebbe,
sostiene lo studioso, non aver soddisfatto i Confratelli .
Secondo lo storico, al tempo, la Santa,
il cui nome in ebraico significa “grazia”, potrebbe essere stata
vista con sospetto dalla Chiesa stessa, in quanto la sua visione non
avrebbe ispirato il concetto di grazia e salvazione dovuti.
Riprendendo poi i soliti motivi della scollatura eccessiva, della
mancanza di decoro in un bambino troppo cresciuto per essere
raffigurato ignudo, lega la visione del gesto brutale, di uccisione
della serpe, al dualismo interpretativo del passo della Genesi tra
cristiani e protestanti, per cui la scena non sarebbe piaciuta ai
cattolici più intransigenti .
Per
il Marini la ragione della rimozione, invece, va ricercata nel
divieto emesso dal Concilio
di Trento di raffigurare
soggetti viventi riconoscibili nei panni di figure sacre .
Tra i dettami conciliari vige, infatti, il veto di utilizzare le
sembianze di personaggi noti ed individuabili, persone “particolari”,
nei panni di Santi
e Martiri,
per opere destinate al culto nei luoghi di pubblici, in cui la gente
possa identificare la/il modella/o. L'impedimento, evidentemente,
nasce dal proposito di voler evitare equivoci e reazioni scomposte.
Il Marini ravvisa nella Madonna
i tratti della Lena, alias Maddalena
Antognetti, amica del Lombardo ,
definita in un documento giudiziario “donna del Caravaggio” .
Questo
possibile riconoscimento, seguito variamente e per anni dalla critica
,
è stato recentemente messo in discussione dallo storico Sergio
Rossi, nel recente Convegno
sul Caravaggio ,
sulla basa la sua convinzione che se tale abbinamento tra la
modella-cortigiana-Lena, donna amata dal Merisi, e la Vergine
del quadro fosse vera, certamente non sarebbe passata inosservata ai
cronisti del tempo, e sicuramente il Baglione, notoriamente nemico
del Pittore, lo avrebbe riferito nelle sue Vite
e sbandierato ai quattro venti pur di mettere l'Artista in cattiva
luce, pertanto, conclude il Rossi non c'è nessuna prova, oltre che
nessun documento, che confermi tale riconoscimento .
Di
contro alcune fonti testimoniano che la Lena, soprannominata la
“roschina” per i capelli rosso ramato ,
avesse un difetto anatomico chiamato oggi “piede cavo”, ossia un
arco plantare particolarmente accentuato. Il dettaglio del piede può
essere osservato sia nella Madonna
dei Palafreni che nella
Vergine di Loreto,
questa evenienza potrebbe avvalorare, anche se debolmente,
l'individuazione della cortigiana, amica-amante del Merisi, con le
Madonne citate
.
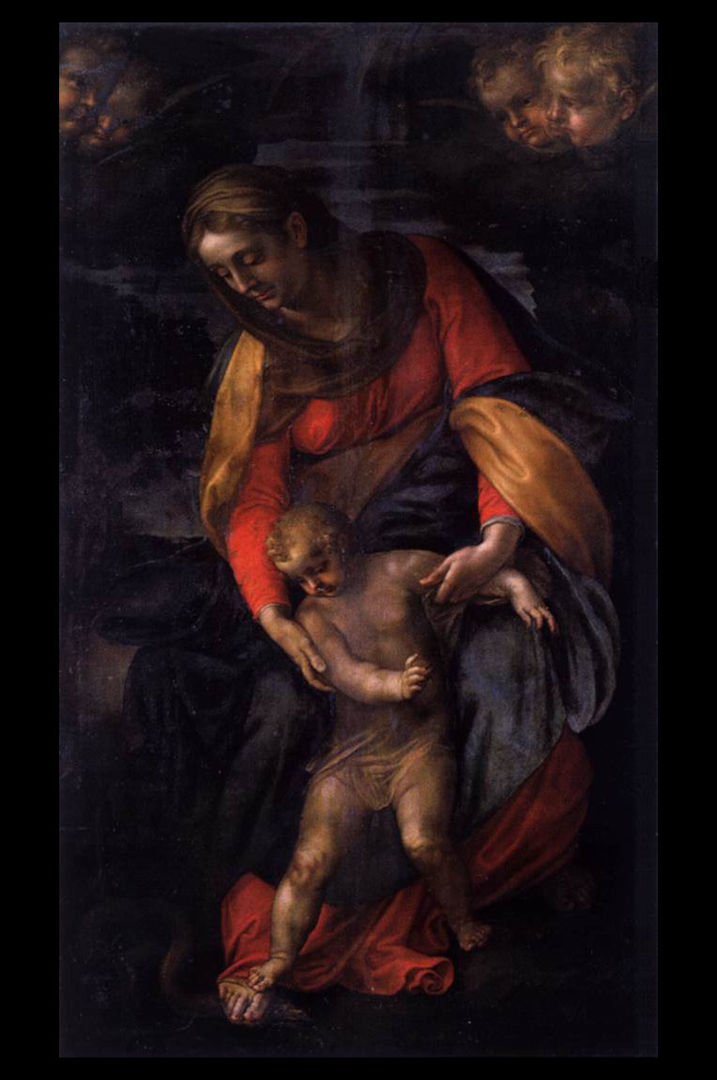 Fig. 5 - Ambrogio Figino, Madonna del serpe
Fig. 5 - Ambrogio Figino, Madonna del serpe
Olio su tela, 210x 150 cm
San Nazaro in Brolo, Milano
Cortesia di Giorgia Duò
Calvesi,
sulla base delle affermazioni del Longhi, che propone per la tela
un'ispirazione a un quadro di identico soggetto, realizzato, in
ambiente lombardo, da Ambrogio Figino (Fig. 5), per la chiesa
di San Fedele a Milano
,
un dipinto la cui concezione è imbevuta di quella religiosità di
ambito pauperistico-borromaico a cui lo stesso Merisi non è
indifferente, riporta che il dipinto, appena posto sull'altare,
viene ritirato, quasi certamente per ordine di Paolo V, appena eletto
al soglio pontificio (1605), zio di Scipione, che non a caso è
particolarmente ostile alle correnti pauperiste e all'interpretazione
che vuole la Madre e il Figlio alleati per sconfiggere il male. Per
lo storico la rimozione diventa una “condanna senza appello” ,
cui seguirà nel giro di poco tempo il rifiuto della Dormitio
.
Stando a tale ipotesi, il Cardinal Nepote, estimatore di Caravaggio,
volendo entrare a tutti i costi in possesso dell'opera, avrebbe
fatto pressioni sullo zio-papa, manipolandone le idee e suggerendo le
giuste informazioni, affinché il dipinto venisse rifiutato dai
Palafrenieri per poi acquistarlo .
In questo senso, Scipione potrebbe aver indotto Paolo V a vedere
nella tela un'immagine indecente, quand'anche pia espressione di
una religiosità profonda, ma estranea a quella dell'Urbe,
inducendo i confratelli a spostare l'opera, quindi a deliberarne la
vendita per 100 scudi (16 giugno) .
Indipendentemente, dunque, dai motivi reali, il Cardinale Scipione
ne approfitta si impossessa del dipinto che, per la prima volta, è
testimoniato nella pinacoteca nella sua residenza, l'attuale
Palazzo Rospigliosi,
nel 1613 .
La tesi del “complotto” per l'acquisizione del dipinto,
enunciata per la prima volta da Calvesi, è condivisa in massima
parte anche dalla critica attuale, in particolare ci riferiamo ad
Anna Coliva e Claudio Strinati .
Tra
il 1604 e il 1606, Caravaggio consegna ai Padri Carmelitani Scalzi
di Santa Maria della Scala, la Morte della Vergine
(fig. 2), oggi al Museo del Louvre ,
che rappresenta, forse l'unico lavoro del Maestro che sia stato
realmente rifiutato .
Baglioni tramanda di una rimozione dovuta ad un'iconografia con
poco decoro: “Per la Madonna della Scala in Trastevere dipinse il
transito di N. Donna, ma perché havea fatto con poco decoro la
Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via; e la comperò il
Duca di Mantova, e la mise in Mantova nella sua nobilissima Galleria”
.
Il Bellori, che non ha potuto vedere direttamente il quadro, in
quanto già traferito in Collezione Gonzaga, riporta che il
“Il Transito della Madonna
nella Chiesa della Scala (è) rimosso per avervi troppo imitato una
donna morta gonfia” .
Dall'altare,
testimonia il Mancini, il quadro viene prontamente rimosso dai
Carmelitani perché la Madonna non rispetta l'iconografia
tradizionale (“tavola d'altare
dov'è la morte della Madonna attorno con gli apostoli, quale
andava nella Madonna della Scala di Trastevere, per essere stata
spropositata di lascivia e di decoro, il Frate Scalzo l'ha fatta
levare”) .
E se la mancanza di qualsiasi attributo divino, la caratterizzazione
in senso troppo terreno, con una faccia umana, il ventre gonfio e un
braccio scompostamente abbandonato, sono già motivo di biasimo,
nelle Considerazioni l'autore propone l'ulteriore elemento
di scandalo per cui, per la Vergine, il Milanese avrebbe
ritratto la modella-prostituta! .
Le affermazioni del Medico riprendono ed arricchiscono la
testimonianza del Baglione che anni prima si è limitato ad asserire:
“perché havea fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe
scoperte, fu levata via” .
È,
dunque, noto che, una volta esposta, la tela, nel giro di pochi
giorni, viene levata dall'altare, sulle ragioni
dell'allontanamento, a cui il Maestro non può opporsi, in quanto
in fuga nei feudi Colonnesi di Palestrina, Zagarolo e Paliano ,
per aver ucciso accidentalmente un uomo ,
ancora una volta si è scritto molto.
Le
attestazioni secentesche, abbiamo visto, si limitano a riportare una
generica accusa di mancanza di decoro della Dormitio Virginis,
e si ipotizza che la modella sia stata una cortigiana annegata nel
Tevere. Queste motivazioni di natura iconografica perdono valore se
si tiene conto del contratto stipulato tra il committente Laerzio
o Laerte Cherubini da Norcia, ricco avvocato romano, amico del
Cardinale del Monte e del Marchese Giustiniani, entrambi protettori
del Milanese, che potrebbero aver favorito la commissione, e il
Caravaggio. Nel caso in questione il contratto ha, infatti,
applicato le clausole stringenti, previste per le commissioni
pubbliche in ambienti religiosi, delineate nell'ambito della
politica tridentina e fortemente volute e caldeggiate anche da San
Carlo Borromeo, secondo le quali gli artisti sono obbligati a
sottoporre preventivamente il “disegno generale” dell'opera
prima della traduzione finale
su tavola/tela/marmo a cui il designum
deve necessariamente essere similiter
.
Il
Nostro, firmando il documento, ha sottoscritto i vincoli e si è
impegnato a presentare le sue intenzioni attraverso un disegno,
sia al committente che ai rettori della chiesa. Inoltre, recenti
ricerche hanno dimostrato che il Giurista stesso ha partecipato
attivamente alla progettazione dell'Historia della
Vergine ed ha fornito, durante il lavoro di traduzione grafica,
indicazioni e disposizioni iconologico-iconografiche .
Riteniamo
pertanto che il Merisi, prima della trasposizione su tela, abbia
rispettato le postille, e coinvolgendo i religiosi nel progetto, i
quali hanno potuto prima visionare, quindi approvare lo “schizzo”,
l'accusa reiterata per il diniego di generica mancanza di decoro
dell'iconografia diventa sensibilmente debole e nonché vacillante;
credere, pertanto, alle vaghe insinuazioni dei biografi secenteschi,
che difficilmente avrebbero potuto conoscere i reali motivi della
vicenda di cronaca ,
sarebbe da parte nostra peccare di ingenuità.
D'altra
parte nessuna cronaca parla di rifiuto, ma solo di rimozione. Questa
sottigliezza semantica nei secoli successivi o non viene colta o si
crede che i due termini coincidano, per cui a
partire da fine Ottocento, si è attivato un intenso lavoro di
ricerca, studio ed indagine sul
corpus
del Maestro, volto ad
identificare, spesso in
maniera alquanto speculativa,
a partire dai resoconti
del'600, i motivi delle
supposte ricusazioni per assenza di decoro.
Nel
caso specifico dobbiamo considerare che il Merisi non sceglie
il classico momento della Dormitio,
quando, cioè, la Madonna
ormai morta è ricomposta ed adagiata sul letto, mentre, nel registro
superiore, la sua anima è accolta tra le braccia del Figlio-Gesù;
elegge piuttosto l'istante immediatamente successivo al Transito,
quando il suo corpo non è ancora stato sistemato, e l'incredulità
e la potenza del dolore crescono inesorabilmente, ossia, il momento
del primo lutto mentre, in un teatro di gesti ed espressioni, di mani
e volti, che comunicano un forte senso di smarrimento e sconforto, si
è appreso razionalmente della dipartita, ma ancora non ci si è resi
conto delle conseguenze.
La figura della Vergine
è scrutata minuziosamente alla ricerca di eccentricità ed eccessi
imperdonabili: è stato rilevato
che i piedi nudi avrebbero potuto creare disorientamento, che Maria
adagiata su una tavola e non su un letto, dalle dimensioni
insufficienti ad accogliere il suo corpo per intero, ha i piedi in
evidenza e si offrono alla visione del fedele in modo poco consono,
che anche gli Apostoli sono scalzi. Ma l'insieme di questi dettagli
più che a mancanza di decoro va ricondotto ad una sorta di omaggio
all'Ordine degli Scalzi .
Neanche l'ambientazione estremamente essenziale può essere motivo
di malcontento, in fondo, rispecchia verosimilmente quelle che
dovevano essere le reali condizioni di modestia del luogo dove la
Vergine ha passato gli ultimi anni della sua vita terrena ,
e ben si addice alla spiritualità pauperista che anima gli
Oratoriani e gli ordini minori a cui Caravaggio e
molti dei suoi principali mecenati sono legati .
Il
pianto ed il dolore vividi che gli astanti manifestano, palesemente
umani, smarriti e turbati, rientrano anch'essi nei dettami di
normalità e verosimiglianza e servono al popolo osservante per
riconoscersi nella vicenda, come gli indirizzi conciliari
consigliano, assolvendo così alla funzione didascalica dell'arte
come insegnamento. Gli Apostoli, i
santi Pietro e Paolo
,
il giovane al capezzale, identificato con San Giovanni, a cui Gesù
sulla croce affida la madre, e le pie, ma umane, donne corrispondono
ai racconti evangelici di Luca, Marco, Giovanni e Matteo, il che fa
supporre che Michelangelo abbia a disposizione, come già nel caso
del ciclo Contarelli, consulenti teologi che forniscono chiarimenti o
delucidazioni al bisogno, lo stesso Cherubini, si è detto, ha svolto
tale ruolo. La loro particolare umanità, sebbene dirompente, esclude
l‘eterodossia, il modus
operandi del Lombardo,
infatti, è ormai diffuso e praticato da molti artisti, pertanto la
stessa non può obiettivamente divenire giustificazione per la scelta
radicale degli Scalzi di sostituire la pala.
Anche
la bella, pure nella morte, giovane figura di Maria, attorniata dagli
statuari Apostoli ,
ha un insigne precedente nella Pietà
di Michelangelo, la cui giovinezza è dallo stesso Buonarroti
spiegata con il passo dantesco dell'Invocazione
di San Bernardo alla Vergine Maria
in cui si recita: “Vergine madre, figlia del tuo figlio” ( dal
XXXIII Canto del Paradiso)
.
Insomma,
dal punto di vista compositivo la solennità e la correttezza
teologiche, richiamate dai dettami controriformati, non risultano
sostanzialmente essere state violate, pertanto studiosi e critici
devono volgere il proprio interesse altrove.
Robert
Hinks, alla metà del XX secolo, parte ed accoglie l'idea della
“meretrice degli Ortacci” di memoria manciniana, e riconduce il
rifiuto all'ignobile, nonché indecorosa, associazione
prostituta-Vergine, una “prostituta degli Ortacci; caduta nel
Tevere, (…) ripescata già gonfia prima che Caravaggio iniziasse a
dipingerla”.
Nello
stesso periodo, argomenta bene Calvesi in diversi suoi studi e
scritti, e riconduce il significato dell'aspetto della Vergine
morta, con il ventre gonfio, a un “esercizio corretto della storia
dell'arte” per cui si ravvede nella raffigurazione della donna la
“Maria ‘piena di Grazia' sempre gravida della divina Grazia
ovvero del corpo di Cristo”, in altri termini, il ventre
gonfio altro non è che un richiamo alla funzione della Madre
Chiesa dispensatrice di grazia .
Tale lettura, peraltro, è presente anche nella, già
menzionata, Pietà michelangiolesca, dove una
Maria monumentale, con un corpo visibilmente e
simbolicamente più grande di
quello del Figlio, allusione anche in questo caso alla Madre
Chiesa, tiene in grembo e sulle sue ginocchia Gesù senza
vita,
Alla
fine degli anni Ottanta, Peter Robb, autore del romanzo M. L'enigma
Caravaggio, a seguito
delle sue ricerche effettuate per documentarsi sul personaggio,
riprende la parola “gonfia”, usata sia dal Baglione che dal
Bellori e la combina con l'informazione del Mancini, relativa
alle modelle-cortigiane per le Madonne,
e con l'argomentazione calvesiana di Madonna “gravida di grazia”
per generare romanzescamente la notizia inverosimile per cui la
sventurata modella morta, non è solo annegata nel Tevere, ma è
addirittura “incinta” !
Pamela
Askew, durante le sue ricerche sul Caravaggio, condotte negli anni
Novanta, si imbatte nella notizia secondo cui Laerzio
Cherubini sarebbe
stato in relazione con l'Arciconfraternita
di Santa Maria dell'Orazione e Morte,
il cui compito era quello di occuparsi della sepoltura dei morti non
reclamati, tra cui gli affogati nel Tevere. La studiosa, allora,
intravede la possibilità che il Milanese, a seguito della relazione
d'affari con il Giurista, avrebbe potuto trovarsi di frequente e
con una certa abitualità sotto gli occhi corpi femminili ripescati
dai Confratelli, e quindi, abbia potuto studiarli, come a suo tempo
Leonardo e Michelangelo hanno fatto, nonché utilizzarli come modelli
dal vero .
Ma si tratta solo di un congettura, per quanto suggestiva, che al
momento non ha altre conferme.
Anche il dettaglio del
ventre rigonfio, quindi, indagato variamente, e ripetutamente
ricondotto a motivo di ricusazione, sembra, invece, non essere stato
decisivo nel determinarla, altrimenti, già a partire dai riferimenti
nelle biografie del ‘600, avrebbe assunto nell'economia
letteraria dei resoconti un ruolo maggiormente significativo rispetto
a quello appendicolare che invece ha.
Con testimonianze e
considerazioni, si è sin qui svolta una disamina volta ad escludere
la supposta e, come verificato, non plausibile eterodossia
dell'iconografia della Vergine, nonché a confermare la
correttezza teologica del dipinto che, abbiamo spiegato, conforme
allo schizzo preliminare
(obbligatorio da contratto), i rettori di Santa
Maria della Scala hanno
certamente visionato e approvato.
Allo stato attuale,
continua a rimanere irrisolto l'interrogativo sull'accaduto,
sul perché dell'avvicendamento: richiamiamo come possibile
spiegazione il divieto, già enunciato precedentemente per la Madonna
della serpe, espresso
dai dettami conciliari, di utilizzare le sembianze di persone
riconoscibili (“facce de particolari”)
,
per raffigurare Santi,
Martiri e Madonne ,
esposti in luoghi di culto pubblici, si deve, cioè, “aver
cura di non riprodurre a bella posta l'effigie di un altro uomo
vivente o morto”
eccetto situazioni di evidente virtù .
La
proibizione ha la precipua funzione, si è detto, di evitare equivoci
e reazioni scomposte, forse quegli “schiamazzi” e quel “romore”
consegnatici dal Baglione.
Il
Mancini ci informa, però, che il Caravaggio anche nel realizzare il
Transito si
è ispirato alle fattezze di una cortigiana “da lui amata”.
Non ci sono conferme al riguardo, e la notizia, di seconda mano,
ricordiamo che il Mancini scrive nella seconda metà del Seicento,
non da testimone diretto, desta certamente qualche sospetto dal
momento che nessun biografo precedente ha riferito la circostanza, e,
soprattutto, come sottolinea Sergio Rossi, se l'abbinamento fosse
stato noto il Baglione non avrebbe di sicuro perso l'occasione per
denigrare e condannare il Merisi,
Roberto
Longhi, come testimonia Giovanni Previtali, negli anni Ottanta, pur
non approfondendo la questione, si domanda se effettivamente possa
essere stato questo il motivo della rimozione.
Il riconoscimento, seppur a distanza di qualche giorno, nella Madonna
di una prostituta, sarebbe stato chiaramente incompatibile con la
finalità devozionale della pala, il cui compito è quello di
indulgere alla preghiera, pertanto, la strada della ricusazione, in
questa circostanza, sarebbe più che plausibile. Il quadro è,
dunque, messo sul mercato del collezionismo secentesco, e, sfuggito
al
Mancini che,
nonostante la critichi (“spropositata
di lascivia e decoro”)
tenta comunque e per una somma piuttosto considerevole, di
accaparrarselo, l'opera prende la strada per Mantova .
Stante
il difetto all'anulare sinistro, di cui abbiamo già parlato (cfr.
infra,
n. 120 e Fig. 6),
la cortigiana, che avrebbe potuto prestare il volto a Maria nella
Vergine della Scala,
potrebbe essere la stessa Fillide rintracciata in altre opere; la
malformazione del dito è, seppur vagamente, intravista nell'oscurità
della scena (Fig. 7)
.
 Fig. 6 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Marta e Maria Maddalena, dettaglio della mano sinistra della Maddalena (1598, olio su tela, 100 x 134,5 cm, Detroit, Institue di Fine Arts). Cortesia di Giorgia Duò
Fig. 6 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Marta e Maria Maddalena, dettaglio della mano sinistra della Maddalena (1598, olio su tela, 100 x 134,5 cm, Detroit, Institue di Fine Arts). Cortesia di Giorgia Duò
 Fig. 7 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Morte della Vergine, dettaglio della mano sinistra (1604, olio su tela, 369 × 245 cm, Parigi, Museo del Louvre). Cortesia di Giorgia Duò
Fig. 7 - MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO, Morte della Vergine, dettaglio della mano sinistra (1604, olio su tela, 369 × 245 cm, Parigi, Museo del Louvre). Cortesia di Giorgia Duò
Ma
l'identificazione non convince ancora Sergio Rossi che non ravvede
nessuna identità in particolare nel volto della Madonna,
e lega piuttosto la rimozione al nome di Caravaggio che a 5 giorni
dallo scoprimento della tela si trova invischiato in un omicidio
(cfr. infra
n. 135). L'imbarazzo dei padri della Scala non nascerebbe pertanto
dall'irriverenza della composizione, ma, sostiene lo storico, dal
fatto che l'opera è connessa ad un uomo su cui pende la pena
capitale!
Già
nel 2005, Papa avanza la medesima supposizione come causa della
rimozione, la vicenda della morte del Tomassoni, in cui Caravaggio è
coinvolto, è motivo valido e credibile di allontanamento .
Contro questa ipotesi, rileviamo, però, che nessun'altra opera del
Maestro, escluso il caso della Madonna
della Serpe, la cui
vicenda ha una plausibile spiegazione nelle trame ordite da Scipione
Borghese per entrarne in possesso, ha subito il medesimo destino,
eppure di opere del Lombardo nelle chiese romane ce ne sono molte. In
sostanza, nessuna damnatio
memoriæ si è realmente
verificata.
Altra
possibile soluzione dell'interrogativo può riguardare, invece, un
dettaglio compositivo che integra un aspetto di natura
iconografico-teologica, che fino a questo momento non è stato
considerato, almeno dal punto di vista dottrinale. Alludiamo al ruolo
del pesante tendaggio rosso, catalizzatore dell'attenzione e dello
sguardo del fedele, nell'economia della dottrina cristiana e
dell'invenzione della Morte
della Vergine.
Necessario
presupposto al discorso è che i Carmelitani, tra gli ordini
religiosi, rappresentano forse il ramo più progressista della
cattolicità del tempo, e, consentendo al Cherubini di servirsi del
Pittore rivoluzionario, le cui opere radicalmente innovative sono
ormai note e ricercate, i frati sono, o dovrebbero essere,
perfettamente consci e consapevoli del tipo di raffigurazione “simile
al naturale” che il l'Artista avrebbe potuto ideare. Ciò
premesso, ribadiamo che, anche per questa considerazione, non sono
realisticamente credibili le ragioni tradizionalmente indagate legate
all'inventione
del Transito. La
dipartita terrena, in una stanza volutamente disadorna, come da
indicazioni pauperistiche, di una donna in carne ed ossa,
priva, se escludiamo l'elegante e leggera aureola d'oro, dei
classici attributi religiosi,
attorniata da amici affranti, distesa su un letto
improvvisato, in una posa ancora scomposta,
con i capelli spettinati, il corpetto slacciato, le braccia
abbandonate in una posizione che richiama allusivamente una
pseudo-crocifissione orizzontale ,
con le caviglie visibili, i piedi nudi disuniti, e al di là della
scena, lo spettatore ignaro e allo stesso tempo emotivamente
coinvolto, partecipe dell'evento doloroso per il trapasso della
madre di Cristo, attraverso l'espediente catartico-regressivo che
catapulta il pubblico nell'insopportabile vicenda della morte, non
ha concreti motivi di ricusazione. Siamo nel 1606 e il Caravaggio ha
abituato la società a questo tipo di rappresentazione. Pertanto
altrove va ricercata una spiegazione coerente e convincente. Nella
tradizione pittorica la Morte
della Vergine o Dormitio
è normalmente è preceduta dal Transito
ed è seguita dall'Assunzione
e dall'Incoronazione.
E allora proponiamo di spostare l'attenzione sull'ingombrante
cortina che, per l'ubicazione, ferma in un dolore eterno la pena
provata dagli astanti; quel drappo impedisce e congela in un destino
bloccato l'evento, e. sebbene si percepisca un'azione a ritroso,
ossia, l'apertura della tenda che precedentemente era chiusa, nel
rispetto dell'intimo momento del Transito-trapasso,
si apre alla visione dello spettatore per la contemplazione della
Morte, lo stesso non può dirsi per il procedere della storia, per
cui al fedele non è consentito di andare oltre, di immaginare le
conseguenti Assunzione
e Incoronazione della
Vergine.
Quindi,
nella percezione dei fedeli, il regolare procedere della vicenda è
in qualche modo contrastato e ostacolato da quella cortina rossa che
è allo stesso tempo fonte di forti emozioni e impedimento alla
sublimazione ed elaborazione del dolore. In una frase, il soffocante
paramento, occupante completamente tutto lo spazio superiore della
scena, impedisce il verificarsi del dogma
dell'Assunzione
e su questa sensazione, divenuta dopo alcuni giorni considerazione, i
Confratelli Scalzi devono aver riflettuto e ritenuto di allontanare
quella rappresentazione potente, ma sacrilega, in quanto incapace di
far comprendere la reale natura del trapasso di Maria, il cui corpo,
non soggetto alla morte terrena e alla corruzione delle carni,
ascende e viene accolto in cielo, per la successiva glorificazione
nella sua dimensione spirituale che fisica.
Già
Papa ha sottolineato come il Caravaggio, nel rappresentare la Morte
della Vergine, abbia
colto un aspetto nodale di tipo dottrinale, ossia, l'immunità del
corpo di Maria, in quanto madre di Dio, alla corruzione materiale
della carne .
E
allora, il rifiuto, non imputabile, abbiamo visto, alla troppa
umanità della Vergine
o della scena, né al profondo ed implacabile dolore provato dagli
Apostoli e dagli astanti, né al mancato decoro per i piedi scalzi o
il ventre gravido, è da ascrivere all'idea veicolata
dall'impedente drappo rosso di assoluta impossibilità per la
Vergine
di superare l'istante della Dormitio
e procedere all'Assunzione
e successiva Incoronazione.
Quando
a distanza di qualche giorno gli Scalzi hanno avuto chiara la
sensazione che quell'immagine avrebbe negato il dogma
dell'Assunzione, i frati non hanno potuto fare altro che chiederne
la rimozione. La tela del resto, in tempi più recenti, è dal Longhi
descritta con un'immagine lapidaria ed essenziale di angoscia
perenne, tutt'altro che transitoria; cioè, un'elaborazione
poetica dell'infinito tempo e dell'imperituro dolore a cui sono
tutti condannati e bloccati in una scena impossibile da superare in
quanto destinata a ripetersi di continuo: “ (...) l'angoscia
di questi astanti prende senso e autorità infinita dal chiarore
devastante che, irrompendo da sinistra nella cerchia di colori già
stranamente fiammanti e pur combattendo con tutte le specie
dell'ombra, soste per un attimo sul viso arrovesciato della Madonna
morta, sulle calvizie lunate, sui colli pulsanti, sulle mani disfatte
degli apostoli; fende di traverso il viso dolente di Giovanni; fa
della Maddalena seduta un solo massello luminoso; della sua mano sul
ginocchio un grumo solo di luce rappresa”.
NOTE
BIBLIOGRAFIA
Age 1985
The
Age of Caravaggio, a cura di Mina Gregori, Luigi Salerno e
Richard E. Spear , New York, 1985.
Annibale
2006
Annibale
Carracci, Milano, Electa, 2006.
AIELLO 2019
Patrizio AIELLO,
Caravaggio 1951, Milano, Officina Libraria, 2019.
ASKEW
1990
Pamela
ASKEW, Caravaggio's Death
of the Virgin,
Princeton, 1990, pp. 8-16.
ARSLAN 1951
Ermanno
ARSLAN, Appunto su Caravaggio, in: “Aut Aut”, n. 5,
1951, pp. 444-451.
BAGLIONE
1642
Giovanni BAGLIONE,
Le vite de' pittori, scultori et architetti dal pontificato di
Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di papa Urbano VIII nel 1642,
Roma, 1642, PP. 136-139.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/baglione1642/0157/image,info,thumbs
https://archive.org/details/gri_vitedepittor00bagl
BASSANI-BELLINI
1994
Riccardo
BASSANI, Fiora BELLINI, Caravaggio assassino. La carriera di
un «valenthuomo» fazioso nella Roma della Controriforma, Roma,
1994.
BASSANI
2021
Riccardo
BASSANI, La donna del Caravaggio. Vita e peripezie di Maddalena
Antognetti, Roma, Donzelli 2021.
BELLORI
1672
Gian
Pietro BELLORI, Le
vite de' pittori, Scultori et Architetti moderni,
Roma, 1672, II ed. 1728, pp. 201-216.
https://archive.org/details/levitedepittoris00bell
https://archive.org/details/levitedepittoris00bell/mode/
BELLORI
1672 (1728)
Gian
Pietro BELLORI, Le
vite de' pittori, Scultori et Architetti moderni,
Roma, 1672, II ed. 1728, pp. 119-130.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bellori1728/0149/image,info,thumbs
BELTRAMME
2001
Marcello
BELTRAMME, La pala dei Palafrenieri: precisazioni storiche e
ipotesi iconografiche su uno degli ultimi rifiuti romani di
Caravaggio, in “Studi Romani”, IL, 2001, pp. 72-79.
https://www.studiromani.it/wp-content/uploads/2019/01/STUDI-ROMANI-Anno-XLIX-NN-1-2-2001.pdf
BERENSON
1951 Caravaggio
Bernard BERENSON,
Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama, trad.
di Luisa Vertova, Firenze, Electa, 1951.
BERENSON
1951 Italian
Bernard
BERENSON, The
Italian Painters of the Renaissance,
1951.
BERNE–JOFFROY
2005
André
BERNE–JOFFROY, Dossier
Caravaggio, Psicologia delle attribuzioni e psicologia
dell'arte, [1959],
Milano,
5 Continents Editions,
2005.
BERTOLOTTI
1881
Antonino BERTOLOTTI, Artisti lombardi a Roma nei
secc. XV, XVI e XVII. Studi e ricerche negli archivi romani, II,
Milano 1881.
https://archive.org/details/artistilombardir01bert_0/page/22/mode/2up
BOLOGNA 2006
Ferdinando
BOLOGNA, L'incredulità del Caravaggi e l'esperienza delle cose
naturali, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.
BURCKHARDT
1951
Jacob
BURCKHARDT Der Cicerone. Eine Anleitung
zum Genuss der Kunstwerke Italiens, Basel,
1855.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/burckhardt1855/0001/image,info,thumbs
CALVESI 1975
Maurizio CALVESI,
Letture iconologiche sul Caravaggio, in Novità sul
Caravaggio, saggi e contributi, a cura di M. Cinotti, A. Pizzi,
Cinisiello Balsamo, Arti Graqfiche, 1975.
CALVESI 1986
Caravaggio
Maurizio
CALVESI, Caravaggio, Dossier n. 1, Firenze, Giunti, 1986.
CALVESI 1986
Dipinti
Maurizio
CALVESI, Caravaggio.
I dipinti d'altare del periodo romano, Dossier, Firenze, Giunti,
1986.
CALVESI 1990
Maurizio
CALVESI, La realtà del Caravaggio, Torino, G. Einaudi,
1990.
Caravaggio
2001
Caravaggio
Carracci Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma
a cura di, Maria Grazia Bernardini, Cinisello Balsamo, 2001.
Caravaggio
2002
Caravaggio
nel IV centenario della Cappella Contarelli, Convegno
internazionale di studi (Roma 24-26 maggio 2001), Città di Castello,
Petruzzi Stampa, 2002.
Caravaggio
2003
Caravaggio,
a cura di Renato Guttuso, collana “I classici dell'Arte”,
Milano, Rizzoli-Skira, 2003.
Caravaggio
2005
Caravaggio
e l'Europa: il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a
Mattia Preti, catalogo della mostra (Milano 15 ottobre 2005 - 6
febbraio 2006), a cura di Luigi Spezzaferro, Milano, Skira, 2005.
Caravaggio
2006
Il Caravaggio
Odescalchi, Le due versioni della Conversione di San Paolo a
confronto, a cura di Rossella Vodret, Milano 2006.
Caravaggio
2010
Caravaggio,
catalogo della mostra (Roma - Scuderie del Quirinale, 20
febbraio-13 giugno 2010), a cura di Claudio Strinati, Milano,
Electa, 2010
Caravaggio
2011
Caravaggio
a Roma. Una vita dal vero, catalogo della mostra (Roma –
Archivio di Stato, 11 febbraio-15 maggio 2011), a cura di
Michele Di Sivo, Orietta Verdi, Roma, De Luca Ed., 2011.
Carlo 2000
Carlo
Borromeo. Instructionum Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae
Libri II. Caroli S.R.E. Cardinalis tituli
s. Praxedis, Arichiepiscopi iussu, ex provinciali Decreto editi ad
provinciae Mediolanensis usum, Milano, 1577, Città del
Vaticano, 2000.
CELIO 1638
Gasparre
CELIO, Memoria delli nomi dell'artifici delle pitture, che
sono in alcune chiese, facciate, e palazzi di Roma, Napoli, 1638.
CELIO 2021
Gasparre
CELIO, Compendio delle Vite di Vasari con alcune altre aggiunte,
Leo S. Olschki editore, 2021.
CROCE
1920
Benedetto
CROCE, Storia della età barocca in Italia: pensiero, poesia e
letteratura, vita morale, Bari, Laterza, 1929.
COLIVA 2000
Anna COLIVA,
Caravaggio. La Madonna dei Palafrenieri, Milano, Silvana
Editoriale 2000.
CONTE 2022
Paolo
CONTE, Qui l'arte è dappertutto. Io la scoprii alle giostre insieme
a mio nonno, intervista a Claudio Strinati, in “Corriere della
Sera”, 6 agosto 2022.
Conversione
2008
La
Conversione di Saulo, Catalogo dell'Esposizione straordinaria
del Caravaggio Odescalchi (Milano, 16 novembre - 14 dicembre 2008), a
cura di Valeria Merlini e Daniela Storti, Milano, Skira, 2008.
CURTI 2007
Francesca CURTI, Committenza,
collezionismo e mercato dell'arte a Roma e Bologna nel Seicento,
Roma, Gangemi, 2007.
DANESI
SQUARZINA 2005
Silvia
DANESI SQUARZINA, La collezione Giustiniani: Inventari I-Inventari
II-Documenti, Torino, Einaudi, 2005.
Decorazione
2003
Decorazione e
collezionismo a Roma nel Seicento, a cura di Francesca
Cappelletti, Roma, Gangemi, 2003.
Da
Caravaggio 2009
Da
Caravaggio ai Caravaggeschi, in occasione del IV Centenario della
morte del Caravaggio, 1571-1610, pubblicazione a cura di Maurizio
Calvesi e Alessandro Zuccari, Roma, CAM ed., 2009.
da
Caravaggio 2017
da
Caravaggio a Bernini, capolavori del ‘600 italiano nelle
Collezioni Reali di Spagna, catalogo della mostra (Roma –
Scuderie del Quirinale, 14 aprile - 30 luglio 2017),
a cura di Gonzalo Redin Michaus, Roma, Skira, 2017.
Decretum
1546
Decretum
de libris sacris et de traditionibus recepiendis, Concilio di Trento
IV sessione, 8 aprile 1546.
DE MARCHI 2016
Andrea G. DE
MARCHI, Muziano: il San Matteo Contarelli e altro,
Roma, Campisano, 2016.
DI SIVO 2011
Michele DI SIVO, Uomini
valenti: il processo di Giovanni Baglione contro Caravaggio,
in Caravaggio a Roma: una vita dal vero, Roma, De Luca
Editori d'Arte, 2011, pp. 90-108.
DUO' 2019
Giorgia
DUO', “Caravaggio 1951” di Patrizio Aiello: una recensione,
in “Bollettino Telematico dell'Arte” (ISSN 1127-4883, 14
Novembre 2019, n. 879, http://www.bta.it/txt/a0/08/bta00879.html).
DUO' 2023
Giorgia
DUO', Edvard Munch: consapevolmente in bilico tra genialità,
follia e spiritualità, in “Bollettino Telematico dell'Arte”
(ISSN 1127-4883, 21 Maggio 2023, n. 938,
https://www.bta.it/txt/a0/09/bta00938.html).
Enigma
2023
L'enigma
Caravaggio 1951-2021. Nuovi studi a confronto, Atti del convegno
internazionale di studi e ricerche su Caravaggio on line (12-28
gennaio 2022), a cura di Sergio Rossi, Rita Randolfi e Rodolfo
Papa. Prefazione di Claudio Strinati, Foligno, EtGraphiae, 2023.
Essercitio 2012
“L'essercitio mio è
di pittore”. Caravaggio e l'ambiente artistico romano, a cura
di F. Curti, M. Di Sivo, O. Verdi, in “Roma moderna e
contemporanea”. Rivista interdisciplinare di storia, Anno XIX, n.
2, luglio-dicembre 2011, Roma, Università degli studi Roma Tre,
2012.
FRANCUCCI 1613
Scipione FRANCUCCI, La
Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione
Cardinale Borghese cantata in versi da Scipione Francucci
Arretino, 1613, MSS Borgh 184, BAV
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borgh.184
FRIEDLÄNDER
1974
Walter
FRIEDLÄNDER, Caravaggio
studies, Princeton, Princeton
University Press, 1974.
https://archive.org/details/caravaggiostudie0000frie_v8l3/page/192/mode/2up
FULLOTTI 2003
Barbara.
FULLOTTI, La collezioni Gonzaga. Il carteggio fra Roma e Mantova
(1587-1612), Cinisello Balsamo, Silvana ed., 2003.
Genio
2001
Il
genio di Roma. 1592-1623. Catalogo della mostra (Londra; Roma
2001) a cura di Beverly L. Brown, Claudio Strinati,
Rossella Vodret, Milano, Rizzoli, 2001.
GIUSTINIANI
1981
Vincenzo
GIUSTINIANI, Discorsi sulle arti e sui mestieri, con
prefazione di Anna Banti, Firenze, Sansoni, 1981.
HESS
1954
Jacob
HESS, Modelle e modelli
del Caravaggio, in
“Commentari”, 5, 1954, pp. 273-289.
HINKS
1953
Robert
HINKS, Caravaggio's “Death of
the Virgin”,
Oxford, 1953.
IOMMELLI
2023
Antonio
IOMMELLI, La Madonna dei
Palafrenieri, Merisi Michelangelo detto Caravaggio,
inv. 110, Roma: Galleria Borghese, 2023.
https://www.collezionegalleriaborghese.it/opere/la-madonna-dei-palafrenieri
JONES
2008
Pamela
M. JONES, Altarpieces and Their Viewers
in the Churches of Rome from Caravaggio to Guido Reni,
Aldershot, Ashgate, 2008.
KÖNIG 1997
Ebherard
KÖNIG, Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610,
Colonia, 1997, pp. 108-13, nn. 97-98.
LONGHI 1913
Roberto
LONGHI, Due opere di Caravaggio, in «L'Arte»,
1913, XVI, pp. 161-164.
LONGHI 1927
Roberto LONGHI,
Precisioni nelle Gallerie italiane, in «Vita
artistica», 6, II, 1927, pp. 28-31.
LONGHI 1943
Roberto LONGHI,
Ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, in
«Proporzioni», 1943, I, pp. 5-63.
LONGHI 1952
Roberto LONGHI, Il
Caravaggio, Milano, Ed. Martello, 1952.
LONGHI 1968
Roberto
LONGHI, 'Me
pinxit' e quesiti caravaggeschi, 1928-1934,
Firenze, Sansoni,
1968.
LONGHI 1973
Roberto LONGHI,
Da Cimabue a Morandi,
antologia di scritti sulla pittura italiana, a
cura di Gianfranco Contini, Torino,
Einaudi, 1973.
LONGHI 1998
Roberto LONGHI, Il palazzo non
finito: saggi inediti 1910 - 1926, Milano, Electa, 1998.
LONGHI 2006
Roberto
LONGHI, Il Caravaggio, Milano, 1952, ri-ed. 1968, a cura di
Giovanni Previtali, Roma, Editori Riuniti, 2006.
MACCHERINI 1997
Michele
MACCHERINI, Caravaggio nel carteggio familiare di Giulio
Mancini, in “Prospettiva”, LXXXVI, 1997, pp. 71-92.
MACIOCE 2023
Stefania
MACIOCE, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Documenti, fonti
e inventari 1513-1875, Roma, Ugo Bozzi editore, 2023.
Madonna
1998
La Madonna dei
Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese, a
cura di Anna Coliva, Venezia, Marsilio, 1998.
MAHON 1951
Denis
MAHON, Egregius in Urbe Pictor;Caravaggio revised, in “The
Burlington Magazine” , Londra, Burlington Magazine Publication”,
1951, Vol 93, n. 580, pp. 222-235.
MAHON
1971
Denis
MAHON, Studies in Seicento Art and
Theory, editore: Bloomsbury
Publishing USA, 1971.
MALVASIA
1678
Carlo Cesare
MALVASIA, La Felsina Pittrice, Vite dei pittori bolognesi,
Bologna, 1678.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/malvasia1678bd2
https://archive.org/details/bub_gb_eXxhLXtjJvYC
https://archive.org/details/bub_gb_cNpm_20VcWAC_2
MANCINI 1956
Giulio
MANCINI, Considerazioni sulla pittura. Viaggio per Roma,
a cura di Adriana Marucchi e Luigi Salerno, con presentazione di
Lionello Venturi, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1956.
https://books.google.it/books/about/Considerazioni_sulla_pittura_Considerazi.html?id=MHQRjLilDA0C&redir_esc=y
MARANGONI 1922
Matteo MARANGONI,
II Caravaggio, Firenze, Battistelli, 1922.
https://books.google.it/books?redir_esc=y&hl=it&id=euFBAQAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=concessione+alla+fantasia
MARINI 1987
Maurizio
MARINI, Caravaggio:
Michelangelo Merisi da Caravaggio "pictor praestantissimus".
La tragica esistenza, la raffinata cultura, il mondo sanguigno del
primo Seicento, nell'iter pittorico completo di uno dei massimi
rivoluzionari dell'arte di tutti i tempi,
Roma, Newton & Compton, 1987.
MENGS 1760-70
Anton F. MENGS,
Lezioni pratiche di pittura, 1760-70
https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE6349276
MERLINI-STORTI
2008
Valeria MERLINI, Daniela
STORTI, Caravaggio a Milano, La conversione di Saulo, Milano
2008.
MORELLI 1897
Giovanni
MORELLI, Le
Gallerie Borghese e Dorìa Pamphili in Roma,
Milano, 1897.
https://archive.org/details/dellapitturaital00more/page/n10/mode/1up?q=CARAVAGGIO
https://archive.org/details/dellapitturaital00more/page/229/mode/1up?q=CARAVAGGIO
NIFOSI' 2014
Giuseppe NIFOSI',
L'Arte svelata, Roma-Bari, Laterza ed., 2014, Vol II, pp. 276-277.
Novità 1975
Novità sul
Caravaggio, saggi e contributi, a cura di M. Cinotti, A. Pizzi,
Cinisiello Balsamo, Arti Grafiche, 1975.
OTTINO DELLA
CHIESA 1967
Angela
OTTINO DELLA CHIESA, L'opera completa del Caravaggio, Milano,
Rizzoli, 1967.
PACKMAN
HINKS 1953
Roger
PACKMAN
HINKS, Michelangelo Merisi Da
Caravaggio: His Life, His Legend, His Works, Faber
& Faber, 1953.
PALEOTTI 1582
Gabriele
PALEOTTI, Discorso
intorno alle immagini sacre et profane diviso in cinque Libri. Dove
si scuoprono varij abusi loro, et si dichiara il vero modo che
christianamente si doveria osservare nel porle nelle chiese, nelle
case, & in ogni altro luogo. Raccolto & posto insieme ad
utile delle anime per commissione di Monsignore Illustriss. &
Reverendiss. Card. Paleotti Vescovo di Bologna. Al popolo della Città
& Diocese sua, Bologna,
1582.
PEPPER 2000
Donald
PEPPER, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, in
Studi di storia dell'arte in onore di Denis Mahon, Milano,
Electa, 2000.
POSNER
1971
Donald
POSNER, Annibale
Carracci: A Study in the reform of Italian Painting around 1590,
Londra, 1971, Vol. II, N. 126.
RUSTICUCCI 1593
Girolamo
RUSTICUCCI, Editto
per gli altari e le pitture, 1593.
PANZERA 2011
Anna
Maria PANZERA, Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura
delle cose, Roma, L'Asino d'oro, 2011.
PAOLUCCI 2010
Antonio
PAOLUCCI, "Il pittore “maledetto” che capì il senso
della spiritualità moderna", in “L'Osservatore
Romano”, 18 febbraio 2010, p. 5.
PAPA 2002
Rodolfo PAPA,
Caravaggio, vita d'artista. Firenze, Giunti, 2002.
PAPA 2004
Rodolfo PAPA,
Caravaggio. Gli ultimi anni, Dossier n. 205, Firenze, Giunti,
2004.
PAPA 2005
Caravaggio pittore
Rodolfo PAPA, Caravaggio pittore di Maria, Milano, Ancora,
2005.
PAPA 2005
Caravaggio anni
ID., Caravaggio.
Gli anni giovanili, Dossier n. 217, Giunti, Firenze, 2005-
PAPA 2009
Rodolfo
PAPA, Caravaggio: lo stupore nell'arte,
San Giovanni Lupatoto: Arsenale, 2009.
PAPI 2011
Federica
PAPI, Ombre e luci nel processo a Caravaggio: ipotesi sulla
Resurrezione di Baglione, novità su Filippo Trisegni e una proposta
per Francesco Scarpellino, in Caravaggio a Roma: una vita
dal vero, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2011, pp. 109-116.
PASSERI 1678
(1762)
Giovanni
Battista PASSERI, Vite de' pittori, scultori et architetti che
hanno lavorato in Roma, 1678 c., Roma 1762.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/passeri1772/0003/image,info,thumbs
PEPPER
2000
Stephen
D. PEPPER, Caravaggio, Carracci and the Cerasi Chapel, in
Studi di storia dell'arte in onore di Denis Mahon, Milano,
2000, pp. 109-122.
PUGLISI 1998
Catherine
PUGLISI, Caravaggio, Londra, 1998, pp. 186-88, 400.
PUPILLO 2001
Marco
PUPILLO, La SS. Trinità dei Pellegrini di Roma. Artisti e
committenti al tempo di Caravaggio, Roma, Edizioni
dell'Associazione culturale Shakespeare and Company 2, 2001.
PUPILLO 2009
Marco
PUPILLO, Lo schiamazzo e la preghiera. Nuove considerazioni
sulla Madonna di Loreto e il pauperismo caravaggesco, in M.
Calvesi - A. Zuccari, Da Caravaggio ai Caravaggeschi,
Roma, CAM Editrice, 2009, pp. 213-234.
RICE
1997
Louise
RICE, The
Altars and Altarpieces of New St. Peter's, Cambridge,
Cambridge University Press, 1997.
RIEGL
1908
Alois
RIEGL, Die
Entstehung der Barockkunst in Rom; Akademische Vorlesungen gehalten
von Alois Riegl, aus seinen hinterlassenen Papieren. Hrsg. von Arthur
Burda und Max Dvoríak, Vienna, 1908.
https://archive.org/details/dellapitturaital00more/page/n9/mode/2up
Roberto 2006
Roberto Longhi.
Caravaggio, a cura di Giovanni
Previtali, Roma, 2006 [1982].
ROBB
1998
Peter
ROBB, M. L'enigma
Caravaggio, Milano, 1998, p.
310.
Roma 2011
Roma
al tempo di Caravaggio, 1600-1630, catalogo della mostra
(Roma – Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 16 novembre
2011 - 05 febbraio 2012), a cura di Rossella Vodret, Roma,
Skira, 2011.
ROSSI 2022
Sergio
ROSSI, Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione,
Napoli, Paparo Editori, 2022.
RÖTTGEN 1993
Herwarth
RÖTTGEN, Quel diavolo è Caravaggio: Giovanni Baglione e la
sua denuncia satirica dell'Amore terreno, in “Storia
dell'arte”, n. 79, 1993, pp. 326-340.
SALERNO
1985
Luigi
SALERNO, The Roman World of
Caravaggio: His Admirers and Patrons,
in The Age of Caravaggio,
New York, 1985.
SASSU 2023
Gianfranco
SASSU, La Cortigiana scandalosa, Roma, Prospettiva
Editrice, 2023.
SCHLOSSER
MAGNINO 1990
Julius SCHLOSSER
MAGNINO, La letteratura artistica, Firenze, La Nuova
Italia, 1990.
SELVATICO 1856
Pietro
SELVATICO, Storia estetìco-critica delle arti del disegno, vol. II,
Venezia, 1856.
https://books.google.it/books?id=KFIWAQAAMAAJ
SETTIS 1975
Salvatore
SETTIS, Immagini della meditazione, dell'incertezza e del
pentimento nell'arte antica, in “Prospettiva”, 2, 1975, pp.
4- 18.
SMITH 1998
Timothy Wilson
SMITH, Caravaggio, Londra, 1998, p. 76, n. 23.
SPEZZAFERRO
1974
Luigi SPEZZAFERRO,
La pala dei Palafrenieri, in Atti del Colloquio sul
tema Caravaggio e i Caravaggeschi, Roma, Accademia dei Lincei,
1974, pp. 125-138.
SPEZZAFERRO
1980
Luigi
SPEZZAFERRO Caravaggio rifiutato? Il problema della prima
versione del San Matteo, in “Ricerche di Storia
dell'Arte”, n. 10, 1980, 49-69.
SPEZZAFERRO
2001 Cappella
Luigi
SPEZZAFERRO, La Cappella Cerasi e il Caravaggio, in
Caravaggio Carracci Maderno. La cappella Cerasi in Santa Maria del
Popolo a Roma a cura di, Maria Grazia Bernardini, Cinisello
Balsamo, 2001, p. 31.
SPEZZAFERRO
2001 Caravaggio
Luigi
SPEZZAFERRO, Caravaggio accettato, in Caravaggio
nel IV centenario della Cappella Contarelli, Convegno
internazionale di studi (Roma 24-26 maggio 2001), Città di Castello,
Petruzzi Stampa, 2002, pp. 23-50.
SPEZZAFERRO
2001 Problemi
Luigi
SPEZZAFERRO, Problemi del collezionismo romano, Roma, 2001,
pp. 3 e sgg.
SPEZZAFERRO
2004
Luigi
SPEZZAFERRO, Mercanti di quadri, Quaderni storici, 2, 2004,
pp. 327-352.
SPEZZAFERRO
2005
Luigi
SPEZZAFERRO, Caravaggio in una prospettiva storica: proposte e
problemi, in Caravaggio e l'Europa: il
movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti,
catalogo della mostra Milano 15 ottobre 2005 - 6 febbraio 2006, a
cura di Luigi Spezzaferro, Milano, Skira, 2005, pp. 33-43; e schede
su Mao Salini.
STEINBERG 1959
Leo
STEINBERG, Observations in the Cerasi
Chapel, in “The Art Bulletin”, Vol.
41, No. 2, 1959, pp. 183-190.
STRINATI
1998
Claudio STRINATI, Il rifiuto. In La Madonna dei
Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese, a
cura di Anna Coliva, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 7-11.
Studi2000
Studi
di storia dell'arte in onore di Denis Mahon, Milano, 2000.
TREFFERS 2000
Bert
TREFFERS, Caravaggio nel sangue del Battista, Roma,
Shakespeare and Company 2, 2000.
A. VENTURI 1924
Adolfo VENTURI,
Disegno storico dell'arte italiana, Bologna, Zanichelli,
1924.
L. VENTURI 1909
L'Arte
Lionello
VENTURI, Note sulla Galleria Borghese, in «L'Arte», 1909,
XII, pp. 31-50.
L. VENTURI 1909
Nuova Antologia
ID.,
Il 1609 e la pittura italiana, in «Nuova Antologia», 16
dicembre 1909, pp. 613-619.
L. VENTURI 1910
Lionello
VENTURI, Studi su Michelangelo da Caravaggio, in «L'Arte»,
1910, XIII, pp. 191-201 e 268-284.
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arte1910/0007/image,info,thumbs
L.
VENTURI 1912
Lionello
VENTURI, Opere inedite di Michelangelo da Caravaggio, in
«Bollettino d'Arte», 1912, VI, 1, pp. 1-8, 7-8.
https://bollettinodarte.cultura.gov.it/
L. VENTURI 1921
Lionello
VENTURI, Il Caravaggio, Roma 1921; II ed., Roma 1925;
L. VENTURI 1930
Lionello
VENTURI, Caravaggio, in “Enciclopedia Italiana”, Roma,
VIII, 1930, pp. 942- 944.
L. VENTURI 1951
Lionello
VENTURI, Il Caravaggio, con prefazione di Benedetto Croce,
Novara 1951 (ultima ed. 1963).
VIAGGIANI 2009,
Claudia
VIAGGIANI, La cappella Cerasi, in Santa Maria del Popolo,
storia e restauri, a cura di Maria Richiello, Ilaria Miarelli
Mariani, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009.
VODRET
2010
Rossella
VODRET, Caravaggio a Roma, Milano, Silvana, 2010.
VOSS 1923
Hermann
VOSS, Caravaggio Frühzeit. Beiträge
zur Kritik seiner werke und seiner Entwicklung,
in “Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen”, n. 44, 1923, pp.
73-98.
ZAPPERI 1981
Roberto
ZAPPERI, Per la datazione degli
affreschi della Galleria Farnese, in “Mélanges
de l'école française de Rome”, Année 1981, pp. 821-822.
https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5110_1981_num_93_2_2625
ZUCCARI 1983
Alessandro
ZUCCARI, La Cappella della Pietà alla Chiesa Nuova e i
committenti del Caravaggio, in “Storia dell'Arte”, n. 47,
1983, pp.53-56.
ZUCCARI 2011
Alessandro
ZUCCARI, Caravaggio controluce. Ideali e capolavori, Milano,
Skira, 2011
ZUFFI
2010
Stefano
ZUFFI, Caravaggio. Simboli e segreti,
Milano, 2010.
|