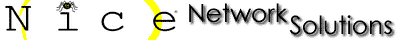|
Secondo
le teorie sostenute da Francisco de Hollanda, Giovanni Paolo Lomazzo
e Gabriele Paleotti, il ritratto, primo tra i generi minori,
sottintende un vero e proprio diritto all'immagine di quelle che
sono ritenute delle autorità: la realizzazione di un'effige è il
privilegio riservato unicamente ai personaggi la cui memoria è
meritevole di essere trasmessa ai posteri per il carattere esemplare
della loro vita, per le loro capacità nell'esercizio del potere,
della santità o delle attività spirituali, dove tra esse si
contemplano anche le arti figurative e la filosofia. Il ritratto è
considerato alla stregua di uno specchio figurativo, un vetro
purissimo attraverso il quale vedere le qualità della persona,
l'incontro tra le virtù umane e l'idea dove non contano
attributi od ornamenti. L'attinenza al realismo dell'effige è,
soprattutto nel caso dei ritratti ufficiali di personaggi, quello che
Pommier definisce il più alto esempio della normativa
politico-giuridica che si crea intorno al ritratto a partire dall'età
antica – i Romani ritenevano degni di essere rappresentati solo i
nobili – fino alla letteratura artistica italiana cinquecentesca.
È entro questa definizione teorica che si innesta la realizzazione di
un ritratto, ascrivibile alla mano di Santi di Tito, raffigurante il
senatore fiorentino Bartolomeo Panciatichi (fig. 1), che verrà
analizzata di seguito a partire dall'inserimento all'interno
delle vicende biografiche dell'artista.
 Fig. 1 - Santi di Tito (1536-1603), Ritratto di senatore fiorentino
Fig. 1 - Santi di Tito (1536-1603), Ritratto di senatore fiorentino
(Bartolomeo Panciatichi), collezione privata, olio su tavola
110,5 x 85,5 cm, ottavo decennio del XVI secolo
(Foto collezione privata, cortesia di Lara Scanu)
Fonti
e documenti. Annotazioni biografiche e testimonianze sulla produzione
di ritratti
Santi
di Tito nasce a Firenze il 5 dicembre 1536. Nonostante i suoi natali
fiorentini, il pittore viene spesso ricordato nei documenti come
«Santi di Tito dal Borgo», dal luogo originario del padre, Borgo
San Sepolcro, località toscana di confine oggi in provincia di
Arezzo.
Sebbene
non si sappia molto della sua formazione, dalle testimonianze
archivistiche si apprende che il 18 ottobre 1554 venne ammesso nella
Compagnia di San Luca, gilda dei pittori di Firenze, e che l'anno
successivo iniziò a redigere un proprio libro dei conti.
Di
fondamentale importanza fu il soggiorno a Roma che Santi ha
effettuato, secondo le attestazioni documentarie emerse, tra il 1561
e il 1564, ma che probabilmente iniziò l'anno precedente in seno
alla bottega di Taddeo Zuccari, dove lavoravano anche il fratello
Federico e il Barocci. Nonostante la frequentazione di questo
importante atelier artistico romano, l'artista fiorentino appare
assolutamente autonomo, capace di una vivacità compositiva che
rielabora i modi pittorici di Bronzino e Andrea del Sarto,
aggiornandoli attraverso il linguaggio delle ultime opere di
Raffaello e delle interpretazioni che di questi dipinti venivano
fornite dagli artisti della prima stagione del Manierismo, alle prese
con le innovazioni della pittura della Controriforma.
Oltre
all'ingrandimento in chiave monumentale, una delle caratteristiche
principali dell'arte di Santi di Tito è la caratterizzazione
psicologica dei personaggi raffigurati nelle sue composizioni, che
avrà una significativa fortuna nella produzione ritrattistica,
particolarmente valorizzata dalla biografia secentesca di Filippo
Baldinucci.
Nobili, borghesi e religiosi fiorentini richiesero spesso al pittore
la realizzazione delle effigi dei loro avi, spesso definite con
precisione anche grazie agli abiti indossati e alla presenza di
oggetti, che connotano il personaggio nel suo status
sociale.
Santi eseguì un significativo numero di ritratti, che il già citato
biografo ricorda con significativa enfasi come una delle sue più
importanti produzioni pittoriche:
«Fu
portato dal genio non meno che dal desiderio del guadagno a fare
ritratti, come quegli che possedendo un'istraordinaria sicurezza
nel disegno, gli conducea con gran facilità, e somigliantissimi dal
vivo, e quello ch'è più, anche dal morto. Dipigneva egli per lo
più teste, e forse le mani, ed a' giovani faceva dipignere
l'acconciature, se erano femmine, e tutti gli abiti, e delle
femmine, e de' maschi [...] De' ritratti però di tutta sua mano
se ne trovano molti, e bellissimi, ma moltissimi altresì alquanto
strapazzati, che poi in tempo sono venduti ad ogni prezzo più vile,
a segno, che noi potremmo dubitare, s'è fossero di sua mano, o de'
suoi giovani, se non ce ne rendesse moralmente certi il vedersi fuor
di ritratti, altri suoi quadri in quella guisa condotti, e molto più
il sapere per attestato di persona antica, e dell'arte, che bene il
conobbe, e praticò, aver'egli avuto per suo famigliare questo
dettato, cioè: io ho pennelli da tutti i prezzi.» (p. 113).
Santi
innovò il genere fondendo il realismo fisionomico con la vitalità
espressiva, capace di rendere nella stessa immagine il tono solenne
dell'ufficialità del personaggio ritratto insieme alla sua
dimensione più quotidiana ed emozionale. Questo consentì
all'artista fiorentino di ampliare la platea della sua committenza,
permettendogli di realizzare ritratti per ceti e soggetti tra i più
diversi, dagli anziani ai bambini, fino alla più complessa
raffigurazione familiare o all'effige di un donatore all'interno
della composizione sacra della pala d'altare. Un esempio è
ricordato da Baldinucci nella sua Vita dedicata al pittore, dove
rammenta che «[...] si vede nella Cappella de' Gaddi in S.
Domenico di Fiesole, e da un lato di detta tavola fece il ritratto al
naturale del defunto Sogliani.»
Purtroppo,
non tutti i personaggi ritratti da Santi sono identificabili, ma i
tratti inconfondibili del suo ductus
pittorico ne consentono un facile riconoscimento, come è già
avvenuto per il Ritratto
della piccola Lucrezia di Niccolò Gaddi
(1577), il Ritratto
di gentildonna con la figlia
(entro il 1575), il Ritratto
di Caterina de' Pazzi
(1583), il Don
Pietro de' Medici
(1586 circa), il Ritratto
di gentiluomo della famiglia Passerini con il figlio e il Ritratto di
famiglia di un cavaliere di S. Stefano,
effigi conservate nelle più importanti collezioni pubbliche e in
alcune delle più prestigiose raccolte private private. La sua
attività ritrattistica continuò nel corso degli anni Novanta fino
alla sua morte, avvenuta il 25 luglio 1603, anche con la
collaborazione della bottega e del figlio Tiberio Titi (1578–1637),
il quale si specializzò in questa arte affinando le qualità del
padre fin da questa prima fase di cooperazione, come è possibile
vedere nel Ritratto
dei figli di Virginio Orsini
(1597) e nel Ritratto
di Filippo, Marcantonio, Orazio e Luigi Magalotti
(1601)
.
Anche in questo caso, è Baldinucci ad offrire una significativa
panoramica delle più importanti effigi realizzate da Santi,
significative non solo per il personaggio raffigurato ma soprattutto
per l'altissima qualità raggiunta in questa tipologia pittorica:
«[...] e
piacemi dare il primo luogo, non già per singularità d'eccellenza
della pittura, ma per la cosa in esso rappresentata al ritratto fatto
da lui di Caterina di Cammillo de' Pazzi Nobile Fiorentina, che poi
vestito Abito Religioso dell'Ordine Carmelitano, mutando l'antico
nome in quello di Maria Maddalena, crebbe tanto in santità, che
meritamente oggi viene ascritta al catalogo de' Santi. Di questo
ritratto si fa menzione nella Vita di essa Santa scritta da Vincenzio
Puccini stato suo Confessore in questo modo. I suoi Genitori per
l'amore, che le portavano (da che per Divin volere s'eran privati
di lei) volevano almeno appresso di loro il suo ritratto, e restati
d'accordo colla Madre Priora, mandarono il Pittore, il quale si
chiamava Santi di Tito, a ritrarla; il che da lei udito cominciò
dirottamente a piangere, e non voleva in modo alcuno: e domandata
perchè faceva tanta resistenza, disse: Io son uscita dal mondo per
non più tornarvi, e per non esservi più vista in quelli panni; ne
fu mai possibile, che consentisse, finché dall'obbedienza della
Superiora, e del P. Confessore non fu costretta; e mentre il Pittore
la ritrasse non fece altro che piangere; nel che mostrò l'odio che
portava al mondo, poiché né anche vi voleva stare, né esservi
veduta dipinta; e per la sua umiltà lamentandoli di questo, diceva:
È possibile, che d'una creatura vile, come son io, che d'un po'
di polvere abbia a restar memoria nel mondo? Fin qui il Puccini.
Questo ritratto in quell'abito appunto, ch'ella lasciò al mondo
insìeme col mondo stesso, le cui pompe non mai avea gustate, o
desiderate, conserva oggi il Cav. Alamanno de' Pazzi, ed una copia
del medesimo hanno le Monache del suo Monasterio di S. Maria degli
Angeli, ed ogn'anno a vista del popolo sopra la porta di lor Chiesa
l'espongono il giorno della festa della stessa Santa. Seguitando
ora a far menzione de' ritratti, diciamo, che uno e bellissimo
d'una vecchia in abito vedovile, possìede il Marchese Francesco
Riccardi. Ipolito de' Ricci Avvocato del Collegio de' Nobili,
Gentiluomo, che per suo divertimento molto ha operato in pittura,
conserva nella sua casa da Santa Croce alcuni ritratti d'antichi
suoi ascendenti, e d'altri stati loro congiunti, fra' quali è
quello di Niccolò Macchiavelli già Segretario della Repubblica
Fiorentina, a cui per parer vivo altro non manca, che la voce; un
altro ritratto di costui, con altri pure di quella casa tutti di mano
di Santi conservano gli Eredi di Pierfrancesco della stessa nobil
famiglia de' Ricci. Il Senatore Ruberto Pandolfini Avvocato pure
del Collegio de' Nobili, Gentiluomo di somma integrità, prudenza,
e dottrina, ha nel suo Palazzo di via di S. Gallo architettato dal
gran Raffaello da Urbino, tre ritratti di mano dello stesso Santi, di
persone di casa Tornabuoni stati suoi ascendenti da canto di donne;
Simone, che fu Cav. Aurato, e godé la dignità di Senatore di Roma;
Donato figliuolo del medesimo Simone, e finalmente Niccolò figliuolo
dello stesso Donato, che fu Vescovo del Borgo a S. Sepolcro, e da'
Serenissimi di Toscana fu in molte legazioni adoperato.
L'eruditissimo Alessandro di Tommaso Segni Senator Fiorentino, al
presente degno Segretario dell'Illustriss. Accademia della Crusca,
ha pure un ritratto fatto da Santi per rappresentare Lorenzo di
Bernardo antico di sua famiglia, che fu de' Signori l'anno 1513 e
de' Dieci della Guerra nel 1529. Il Senator Carlo di Lionardo
Ginori ha di mano del medesimo il ritratto di Bartolommeo di Lionardo
Ginori suo Avolo; il quale vedesi dipinto in figura intiera armato, e
della stessa straordinaria grandezza di quattro braccia della nostra
misura, siccome era sua persona, ch'essendo stato fuori alle
guerre, ne era perciò stato cognominato il grande Italiano, di che
abbiamo noi più diffusamente fatta menzione nelle notizie della vita
di Gio. Bologna Scultore ed Architetto Fiammingo. Un bellislimo
ritratto fatto per mano del nostro Artefice conservano fra altre
opere di rinomati Pittori, il Cav. Iacopo, e Niccolò del Cav.
Lorenzo dal Borgo: rappresenta il ritratto la persona di Piero di
Iacopo di Piero loro Proavo, quegli per cui fu restaurata, ed
aggrandita l'antica casa di sua Nobil Famiglia in via della Scala;
nella facciata della quale fece dipingnere a sgraffio Istorie del
Trionfo di David, per alludere a' fatti della G. M. di Cosimo I
Granduca di Toscana, bellissimo concetto di quel Gentiluomo, il quale
anche volle, che venisse dichiarato nel seguente Dittico, che vi
leggiamo scritto per entro un fregio, che ricorre sopra le finestre
inginocchiate: En tibi qui quondam predixit Cosme triumphos, Et
docuit forte/ tam superare graves. Ma giacché il ritratto di Piero,
che veramente è bello a maraviglia, ci ha portato a far menzione di
lui, e delle storie da lui fatte dipignere, giusto è, che facciali
da noi memoria in questo luogo di cosa non punto lontana da tal
proposito, e dall'assunto nostro, ch'è di ragionare di materie
appartenenti alle nostre Arti; ed è che trovandosi in carica di
Scalco de' forestieri del serenissimo cardinale Carlo de' Medici
il soprannominato cavaliere Iacopo dal Borgo, come quegli, che ad un
singularissimo talento di nobile, e spiritosissima poesia, ha
congiunta la pratica in tutto ciò, che a disegno appartiene, erasi
per suo diletto posto a rappresentare in cera di basso stiacciato
rilievo l'effigie di quel Principe, in forma d'una bella medaglia
tonda; e perchè il ritratto riuscì bello, e somigliantissimo, volle
il Cardinale, che se gli facesse il rovescio, Francesco Rondinelli
bibliotecario del serenissimo Granduca, gentiluomo altresì
eruditissimo, a cui fu data l'incumbenza di formarne il pensiero,
disse al Cavaliere voler ogni giustizia, ch'essendo quel bel
ritratto uscito dalla sua mano , dalla casa pure di lui uscisse il
concetto per lo rovescio, e così volle, ch'egli v'improntasse
l'Arca Federis, col motto Pascit. Docet. Dirigit. Prin. Past: Prot.
La medaglia poi, che dalla parte del riesatto conteneva le parole
Carolus Card. Med. Sac. Col. Dec. fu incavata in Roma, e furonne
improntare assai in argento, che mandate a quel Serenissimo, andarono
per le mani di molti; ed alquante delle medesime furon poi dopo morte
del Cardinale poste nella cassa, che coperse il suo cadavero nel
darseli sepoltura. Tornando ora a Santi, egli fu per ordinario
adoperato a far ritratti de' Serenissimi Principi, e dovendo una
volta far quello di Madama Cristina di Lorena, allora sposa del
Granduca Ferdinando I, la quale abborriva il tedio di starsene ferma
al naturale, trovò modo di sbrigarsi in mezz'ora, pel qual tempo
(tanta era la franchezza di suo pennello) condusse il ritratto
bellissimo, che si meritò la lode del Granduca, e di tutta la
corte.»
Una
ulteriore testimonianza, stavolta documentaria, è l'inventario dei
beni di Santi di Tito, stilato dopo la sua morte il 5 novembre 1603 e
pubblicato da Julian Brooks nel 2002. Gran parte dell'atto notarile
è occupato dall'elenco delle opere presenti nella bottega
dell'artista, molte delle quali sono proprio ritratti, dove
talvolta la persona raffigurata non è riconoscibile oppure la
composizione si presenta ancora in stato di abbozzo:
«Un
ritratto de' Sernigi, finito la testa, et il resto bozzato tutto,
et ne ha hauto scudi 4 a buon conto.
Un ritratto
del Marchese Malespina finito tutto intero.
Un
ritratto d'uno de' Guidi finito mezzo, et a buon conto ne ha
hauto scudi dieci. Un ritratto del Salviato bozzato la testa finito
mezzo.
Un
ritratto di Rosso de' Medici di braccia 1 1/3 alto, bozzato.
Un
ritratto della cognata del Bali Cimenes di braccia 1 3/4, finito.
Un
ritratto d'un huomo, et non si sa chi sia.
Dua quadri
mesticati entrovi cosa nessuna.
Un
ritratto del Gran Duca non finito, et non si sa di chi sia.
Un quadro
con una testa del Gran Duca Cosimo, et non si sa di chi sia.
[...]
Quattro
ritratti da donne, non si sa di chi sieno.
Un
ritratto d'un huomo, non si sa di chi sia.
Un quadro
entrovi la testa del Cardinale de' Medici, non si sa di chi sia.
Un
ritratto d'una donna, non si sa di chi sia.
Un
ritratto d'una donna non finito, non si sa di chi sia.
Un
ritratto d'un huomo non finito non si sa di chi sia.
Un
ritratto d'un putto non finito, non si sa di chi sia.
Un
ritratto d'un giovane, non si sa di chi sia, non finito.
Un quadro
d'un ritratto morto, non si sa di chi sia.
Un
ritratto come sopra, non si sa di chi sia.
[...]
Un ritratto
d'un Prete, non finito.
[...]
Un
ritratto intero di Baccio del Tovaglia.
[...]
Un
ritratto di Lorenzo Salviati, bozzato la testa.
Un
ritratto del Nunzio, bozzato, del Canonico Dati, hauti scudi 4 a buon
conto [...]
Un
ritratto d'una donna non finito, non si sa di chi sia.
[...]
Un
ritratto della Principessa Maria Regina di Francia, di casa, finita
la testa.
Un
ritratto della Sig.ra Isabella, bozzato, di braccia 1/2, di casa.
[...]
Un ritratto
d'una vedova finito, non si sa di chi sia.
Un ritratto
finito, non si sa di chi sia.
Un ritratto
d'una donna non finito, non si sa di chi sia.
Dua
ritratti d'huomini non finiti, non si sa di chi sieno.
Un ritratto
d'una vedova non finito, non si sa di chi sia.
Un ritratto
del S.r Alfonso Piccolomini finito, di casa.»
Analisi
del dipinto. Effigiato, confronti stilistici e ipotesi di provenienza
Iniziando
dalle informazioni fornite dalla biografia secentesca, dai documenti
editi e nonostante il non eccelso stato di conservazione dell'opera
che vede parte della superficie pittorica – quella delle velature –
tra le meno conservate è possibile rintracciare proprio in Santi di
Tito l'autore del ritratto in analisi, anche grazie al recente
restauro che ha fatto emergere tutti i tratti caratteristici del
pittore, restituendo al suo antico splendore questa meravigliosa e
dettagliatissima effige.
La
grande tavola raffigura un senatore fiorentino in un ambiente chiuso,
probabilmente il suo studio privato. Alla sua destra si trova un
tavolo coperto da una tovaglia verde, sopra al quale sono appoggiati
un libro e un berretto nero; nella mano sinistra stringe un paio di
guanti, mentre tra le dita della mano opposta sorregge una lettera
che dichiara l'età dell'uomo raffigurato, riconoscibile già
dalla barba e dai capelli bianchi come una persona di età matura:
«Annus Aetatis suae 66 P.A.D. 1574» (fig. 2).
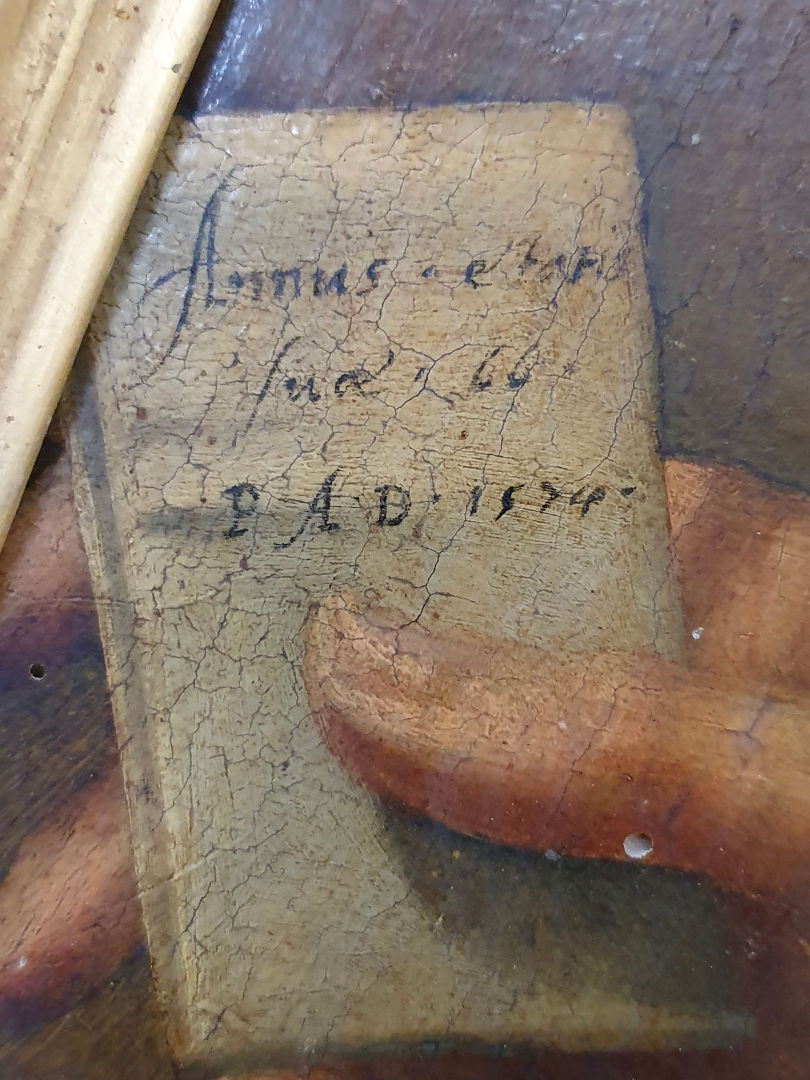 Fig. 2 - Santi di Tito (1536-1603), dettaglio della lettera
Fig. 2 - Santi di Tito (1536-1603), dettaglio della lettera
in Ritratto di senatore fiorentino (Bartolomeo Panciatichi)
collezione privata, olio su tavola
110,5 x 85,5 cm, ottavo decennio del XVI secolo
(Foto collezione privata, cortesia di Lara Scanu)
Nonostante
un'attenta lettura dei registri dei Senatori fiorentini, al momento
non si è riusciti a giungere all'identificazione del personaggio
effigiato. La precisione dei tratti, la commistione del dato
realistico ed ufficiale con le caratterizzazioni quotidiane ed umane,
l'analisi di alcuni dettagli posti a confronto con opere
inequivocabilmente attribuite a Santi di Tito confermano, come si
vedrà in seguito, l'attribuzione al pittore. Tuttavia, a partire
dai dati anagrafici forniti dalla Serie
dei Senatori fiorentini
pubblicata da Giuseppe Manni nel 1722
e confrontando l'effigiato con un ritratto di Bartolomeo
Panciatichi, realizzato dal Bronzino nel 1540 e ora presso la
Galleria degli Uffizi,
è possibile ipotizzare che il personaggio sia da riconoscere in
questo umanista e diplomatico nato in Francia nel 1507 e morto a
Firenze nel 1582.
L'epigrafe “P.A.D. 1574”, anche sulla base di questi dati,
potrebbe essere sciolta con “Pictus/Pinxit Anno Domini 1574”,
epoca in cui effettivamente il senatore fiorentino, che assunse tale
carica nel 1567, entrava nel sessantaseiesimo anno di età.
Originario
di Pistoia, Panciatichi era figlio di un commerciante e nacque in
Francia, dove il padre – suo omonimo – rappresentava la più
fiorente borghesia mercantile toscana operante oltralpe, in
particolare a Lione. Dapprima paggio di Francesco I, studiò
principalmente presso l'Ateneo di Padova e lasciando completamente
le imprese paterne. Traduttore di alcune opere di matrice religiosa
di Pietro Aretino, si interessò alla Riforma Protestante, facendo
entrare nei più importanti circoli culturali fiorentini alcune opere
iscritte nell'Indice dei Libri Proibiti, come ad esempio gli
scritti di Giovanni Calvino. Bartolomeo Panciatichi fu un
intellettuale di rilievo per la Firenze dell'epoca anche grazie al
suo ruolo nell'Accademia degli Umidi;
ricoprì anche, per Cosimo I, l'incarico di Cameriere, Revisore
degli Statuti e di console proprio in terra francese, dove era nato e
continuava ad intrattenere significativi rapporti diplomatici,
culturali e commerciali. Si sposò per due volte: la prima nel 1534
con Lucrezia Pucci, immortalata da Bronzino in un celeberrimo
ritratto oggi agli Uffizi,
e nel 1567 con Eleonora degli Albizi, ex amante del Granduca.
Dopo
questo sommario excursus
biografico,
utile a comprendere le ragioni di realizzazione di molteplici effigi
di uno stesso personaggio proprio in virtù delle sue doti morali che
lo rendono degno di avere delle immagini di sé da tramandare ai
posteri, si può tornare al ritratto in analisi.
Partendo
dal primo piano, è visibile una mano che stringe dei guanti,
confrontabile con quella presente nel Ritratto
di Niccolò Machiavelli
e nel Ritratto
di uomo con fazzoletto:
i tre personaggi sono accomunati dal compimento del medesimo gesto,
sebbene ruotato di novanta gradi, e la tensione dei nervi della mano
rileva la stretta, delicata ma decisa, che sostiene i due accessori.
Una
ulteriore prova della grandissima abilità di Santi di Tito nella
descrizione dei dettagli più minuti di arredamento ed oggetti è
data dalla precisione con cui descrive il libro e il berretto posti
sul tavolo, che molto assomigliano al trattamento dell'arredamento
presente nel Ritratto
di Maria de' Medici
(1600 circa).
Altro
espediente molto in uso a partire dalla grande stagione del
Rinascimento è proprio quello della lettera, che spesso ha il
compito di dichiarare l'identità dell'effigiato o di fornire
degli indizi per comprendere il nome della persona ritratta. Nel caso
di Santi di Tito, vi sono alcuni interessanti confronti da attuare
con il dipinto in analisi, in particolare con due opere che
presentano il medesimo supporto, la tavola: si tratta del Ritratto
di Guido di Francesco Guardi con i suoi figli
(1570 circa), dove proprio il personaggio principale ha in mano
un'epistola dove si legge «D[omi]no Guido Guardi»,
e del Ritratto
di Marcantonio Adimari in veste di Sant'Antonino
(1588 circa), in cui compare anche in questo caso una lettera con su
scritto «Mag[nifi]co Marchantonio Adimari / Adì [...] X [...]
1588».
Il
dipinto in analisi è sicuramente databile tra queste due opere, con
ogni probabilità intorno all'anno 1574, citato come ulteriore
termine identificativo per l'età dell'effigiato.
Proprio
riguardo il nome di questo senatore fiorentino e la provenienza
dell'opera si possono formulare delle ipotesi. Sulla base di quadri
apparsi recentemente sul mercato antiquario o presenti in collezioni
straniere, talvolta frutto del lavoro della bottega – così come è
visibile dalla resa pittorica meno attenta al dettaglio e al dato
psicologico – o di mano dello stesso Santi, capace di una
meticolosità quasi maniacale nella realizzazione di abiti, gioielli,
oggetti ed acconciature, è possibile stabilire che con ogni
probabilità il dipinto in analisi appartenga ad un ciclo di ritratti
dedicati a importanti personaggi fiorentini, presumibilmente tutti
senatori, sovente realizzati a partire dalle maschere funerarie dei
singoli personaggi, come ad esempio nel caso di Machiavelli: a questo
possibile ciclo pittorico appartiene anche il Ritratto
di Carlo Pitti
del Philadelphia Museum of Arts (inv. 87; fig. 3)
e altri due ritratti di senatori fiorentini – al momento non
identificabili - attribuiti al pittore e recentemente comparsi sul
mercato antiquario.
Questa ipotesi sarebbe avvalorata non solo dalle testimonianze
riportate da Baldinucci, il quale in più di un caso ricorda dei
piccoli gruppi di ritratti realizzati per specifici committenti, ma
anche dal consistente numero di opere di questa tipologia presenti
nello studio del pittore al momento della sua morte, così come
ricordato dal documento notarile che censisce diverse effigi talvolta
identificate, ma ancora più spesso sconosciute, forse perché prive
di specifiche indicazioni a riguardo all'interno della
composizione.
Si
può dunque concludere che l'effige del Panciatichi sia ascrivibile
alla mano di Santi di Tito e databile entro la prima metà degli anni
Settanta del Cinquecento.
 Fig. 3 - Santi di Tito (1536-1603)
Fig. 3 - Santi di Tito (1536-1603)
Ritratto di Carlo Pitti
Philadelphia Museum of Arts, John G. Johnson Collection
olio su tavola, 87,6 x 66,7 cm, 1586
(Foto John G. Johnson Collection, 1917, cortesia di Lara Scanu)
NOTE
BIBLIOGRAFIA
ARNOLDS
1934
Günther
ARNOLDS,
Santi
di Tito, pittore di Sansepolcro,
Arezzo, Reale Accademia Petrarca, 1934.
BALDINUCCI
1681
Filippo
BALDINUCCI,
Delle
notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua,
Firenze, Per Santi Franchi, 1681.
BASTOGI
2009
Nadia
BASTOGI,
Due
ritratti femminili di Santi di Tito,
«Paragone. Arte», 60, 2009, pp. 58-66.
BORGHINI
1584
Raffaello
BORGHINI,
Il
Riposo,
Firenze, Giorgio Maresotti, 1584.
BOSCH
2014
Lynette
M.F. BOSCH,
Orthodoxy
and heterodoxy in Agnolo Bronzino's paintings for Bartolomeo and
Lucrezia Panciatichi,
in Agnolo
Bronzino. The Muse of Florence,
a cura di Liana DE GIROLAMI CHENEY,
Washington, New Academia Publishing/The Spring, 2014, pp. 35-130.
Bronzino
2010
Bronzino.
Pittore e poeta alla corte dei Medici,
catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 24 settembre 2010 –
23 gennaio 2011) a cura di Carlo FALCIANI
e Antonio NATALI,
Firenze, Mandragora, 2010.
BROOKS
2002
Julian
BROOKS,
Santi
di Tito's studio: the contents of his house and workshop in 1603,
«The Burlington Magazine», 144, 2002, pp. 279-288.
CARAVALE
2014
Giorgio
CARAVALE,
Panciatichi,
Bartolomeo,
in DBI,
LXXX, 2014, ad
vocem.
CASCIU
1994
Stefano
CASCIU,
a cura di, Dal
Rosso a Santi di Tito: guida alle opere: la maniera moderna
nell'Aretino,
Provincia di Arezzo, Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Arezzo, Giunta Regionale
Toscana, Venezia, Marsilio, 1994.
CIABATTINI
2014
Roberto
CIABATTINI,
Santi di Tito (Sansepolcro 1536 - Firenze 1603) e i suoi allievi,
Firenze, s.n. [Toscana Nuova], 2014.
COLLARETA
1977
Marco
COLLARETA,
Tre
note su Santi di Tito,
«Annali Scuola Normale Superiore - Classe di Lettere e Filosofia»:
III, VII/1, 1977, pp. 351-369.
FREDERICKSEN,
ZERI 1972
Burton
B. FREDERICKSEN,
Federico ZERI,
Census
of Pre-nineteenth-century Italian Paintings in North American Public
Collections,
Harvard, Harvard University Press, 1972.
Il
Cinquecento a Firenze 2017
Il
Cinquecento a Firenze. “Maniera moderna” e Controriforma,
catalogo della mostra (Firenze, 21 settembre 2017-21 gennaio 2018) a
cura di Carlo Falciani
e Antonio Natali,
Firenze, Mandragora, 2017.
I
volti della Riforma
2017
I
volti della Riforma. Lutero e Cranach nelle collezioni medicee,
catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 30 ottobre
2017 – 3 febbraio 2018) a cura di Francesca DE
LUCA
e Giovanni Maria FARA,
Firenze, Mandragora,
2017.
LEPRI
2016
Nicoletta
LEPRI,
Vincenzo
De' Rossi e Santi di Tito: teatri di piazza e di strada nelle feste
fiorentine del 1565,
«Hvmanistica», 11, 1-2, 2016, pp. 203-220, 309.
MANNI
1722
Giuseppe
MANNI,
Serie
de' Senatori Fiorentini,
Firenze, Stamperia Giuseppe Manni, 1722.
MATTATELLI
2013 (2014)
Rosy
MATTATELLI,
La
casa di Santi di Tito in via delle Ruote: dimensione abitativa, arte
e vita quotidiana di un artista a Firenze tra XVI e XVII secolo,
«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 22, 2013 (2014),
pp. 344-355.
NESI
2020
Alessandro
NESI,
Santi
di Tito: Ritratto di Marcantonio Adimari in veste di Sant'Antonino
Pierozzi,
Firenze, Nuova Maniera, 2020.
PAULUSSEN
1980
Isabelle
M. J. PAULUSSEN,
Tiberio
Titi. Ritrattista dei Medici,
«Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», 42, 1980, pp.
101-128.
POMMIER
2003
Edouard
POMMIER,
Il
ritratto. Storia e teorie dal Rinascimento all'Età dei Lumi,
Torino, Einaudi, 2003.
RILLI
1700
Iacopo
RILLI,
Notizie
letterarie ed istoriche intorno agli uomini illustri dell'Accademia
Fiorentina,
Firenze, Piero Matini, 1700.
SCANU
2025
Lara
SCANU,
Un'assenza
presente. Il ritratto: un mito al limite diviso tra arte letteratura
e caratterizzazione psicologica nel Rinascimento italiano,
in Il
limite. Percorsi interdisciplinari di ricerca,
a cura di Mario LUPOLI,
Andrea BIZZOZERO,
Caltanissetta-Roma, Sciascia Editore, 2025, pp. 59-73.
SPALDING
1983
Jack
SPALDING,
Santi
di Tito and the Reform of Florentine Mannerism,
«Storia dell'Arte», 47/49, 1983, pp. 41-52.
VASARI
1550-1568 (1966-1987)
Giorgio
VASARI,
Vite
de' più eccellenti pittori scultori e architettori, 1550 e 1568,
a cura di Rosanna BETTARINI,
Paola BAROCCHI,
8 voll., Firenze, Sansoni, 1966-1987.
|