|
Lo studio riflette sulle analogie tra
archeologia e arte investigate attraverso il confronto tra il pensiero
creativo contemporaneo e il ricorso ai metodi e alle questioni propri
del contesto archeologico.
Il
pensiero creativo, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX
secolo, si è spesso legato ai processi, ai metodi e alle questioni
dell’archeologia. Lo scavo stratigrafico, il recupero, la
classificazione e catalogazione dei reperti, la policromia della
scultura antica, il calco sono diventati oggetto di approfondimento
artistico.
Le analogie tra archeologia e arte sono state investigate dall’archeologo britannico Andrew Colin Renfrew che, nel testo Figuring it Out, propone una riflessione sulle affinità tra i due ambiti di ricerca. “To figure out”
- capire, comprendere - è l’azione che sia gli archeologi sia gli
osservatori/autori dell’arte contemporanea compiono nel fruire
dell’oggetto artistico sia esso reperto o arte nuova. L’archeologo
scava, scova reperti, esplora antichi siti e cerca di dare un senso a
quel che trova; le azioni compiute dall’archeologo sono analoghe a ciò
che accade nel processo creativo dell’opera d’arte contemporanea che
coinvolge l’autore e il fruitore dell’oggetto artistico [1].
Per
dimostrare le connessioni tra l’archeologia e l’arte del tempo presente
è utile esplorare le strade percorse dagli artisti che inseriscono nel
proprio lavoro lo studio e la comprensione del passato dell’umanità.
C’è qualcosa in comune tra l’interazione dell’archeologo con gli
oggetti delle sue ricognizioni di scavo e il lavoro dello scultore
nell’approccio ai materiali da impiegare per creare oggetti artistici.
Un
approccio analogo a quello che ha l’archeologo nei confronti del
frammento è utilizzato sia da Michelangelo Pistoletto in opere come Paradiso contemporaneo (fig. 1), allestito alle terme di Caracalla, che da Jannis Kounellis con Senza l’antica prospettiva (fig. 2), presso lo stadio di Domiziano. Pistoletto e Kounellis considerano il ricorso all’antico come una necessità
insita nella natura umana, un elemento che sopravvive a se stesso e
ogni volta si presenta agli occhi di chi lo osserva allo stesso tempo
uguale e diverso [2].
Questi artisti intervengono usando materiale di scavo per dar forma a
opere fatte di forme semplici, linee o cerchi; la rovina in tal modo
diventa metafora della volontà di distruggere per rigenerare, di
decostruire per creare nuove forme, della possibilità di selezionare
per conoscere e offrire un’interpretazione critica. In entrambi il
ricorso alla rovina risente della condizione dell’uomo moderno che
abita una realtà frammentaria e, per questo, anela alla ricomposizione
di un’unità perduta.
Il processo sistematico di scavo, raffinato dall’impiego di un metodo
stratigrafico volto al recupero del contesto, torna anche in altri
artisti.
Lo studio
dell’archeologia e dei monumenti del passato ha indubbiamente stimolato
la ricerca artistica di Anne e Patrick Poirier che hanno sviluppato una
poetica basata principalmente sull’idea della memoria e della fragilità
umana, legata alla violenza distruttiva del tempo e della storia [3]. L’opera dei Poirier
si manifesta da subito come un lavoro di carattere concettuale sulle
modalità della catalogazione dei saperi. Nell’opera del 1970 Villa Medici. Quindici Erme
(fig. 3) calchi di statue romane sono inseriti in teche di legno
protette da un vetro molto sottile; sopra ogni erma, un cofanetto
custodisce alcune foglie e una fotografia della scultura. L’immagine
fotografica e l’idea del frammento sono metafora della memoria umana
che può ricordare gli eventi vissuti non in modo completo, ma solo per
singoli fotogrammi.
L’opera Ostia Antica. Costruzione (fig.
4), realizzata tra il 1971 e il 1972, è un plastico in terracotta che
riproduce la planimetria del sito mostrando una ricostruzione in
miniatura di tutta l’area degli scavi con grande precisione nei
dettagli. Con una tecnica simile vengono prodotte altre opere come Isola Sacra e la più complessa Domus Aurea la cui struttura si presenta divisa in vari reparti (Le Réduit des Antiques, Le Jardin Noir, La Bibliotèque Noir).
In una sorta di archeologia parallela a quella ufficiale, con calchi di
carta giapponese, fotografie, ricerche d’archivio, i due artisti
rilevano frammenti e rovine di siti archeologici, contemporanei o
immaginari.
I Poirier analizzano il significato profondo della rovina con l’opera Exegi Monumentum Aere Perennius [4]
(fig. 5) del 1988 che immobilizza l’immagine dinamica della caduta con
i singoli rocchi franati a terra. Intorno al grande zoccolo è scolpita
l’iscrizione, ironica e derisoria, che titola l’opera: Exegi Monumentum Aere Perennius;
un titolo ambiguo che ironicamente dimostra come la colonna -
realizzata con un materiale durevole quale è l’acciaio inossidabile -
seppur caduta e spezzata, sia testimonianza delle rovine prodotte dal
tempo e, allo stesso tempo, della permanenza delle forme antiche nel
presente [5].
La loro ricerca si basa sulla riflessione sul tempo e sui suoi effetti
rovinosi; in tal senso il termine rovina fa riferimento a tutto ciò che
proviene dal passato senza conservare l’aura del monumento ma solo il
suo valore testimoniale. Ciò dimostra come la ricostruzione del passato
non sia una materia solo dell’archeologia e che, con strumenti diversi,
anche l’artista può riattivare la memoria dei luoghi. I Poirier
ripristinano la realtà dei siti e degli oggetti antichi seguendo il
percorso scientifico di un archeologo e valorizzando l’approccio
emozionale dell’arte.
Come
appare evidente nel lavoro dei Poirier, anche l’oggetto principale
d’indagine archeologica, la rovina – impronta del passato che
rappresenta una sorta di materializzazione della memoria – è
divenuto materiale fertile per la ricerca artistica contemporanea.
In anni recenti le rovine antiche sono state spesso accostate alle
macerie contemporanee, in una visione sinottica che sembra voler
connettere la fine dell’età antica con il crollo delle moderne
certezze. A occuparsi di rovine contemporanee è il fotografo
Massimo Siragusa con la serie Twentynineseconds che, citandone la durata, fissa la devastazione del sisma del 2009 in Abruzzo. In uno degli scatti, titolato Onna
(fig. 6), l’ambiente barocco e la luce chiara di una chiesa stridono
con gli accumuli di macerie in primo piano esprimendo un contrasto
dall’aspetto quasi teatrale. L’artista invita l’osservatore a
contemplare le rovine del presente proponendo una rilettura critica
delle conseguenze materiali del terremoto [6].
Con simile accento teatrale, Piranesi aveva indagato le rovine del
passato riflettendo sul crollo del mondo antico, costretto dal tempo e
dalla storia a soccombere al moderno divenire [7] (fig. 7).
Una
tecnica legata all’archeologia ripresa dagli artisti - in modo
particolare per l’applicazione che ne viene fatta a Pompei - è il
calco. Nel febbraio del 1863 Giuseppe Fiorelli, al tempo direttore
degli scavi, diede l’ordine di versare del gesso liquido in una cavità
incontrata dagli operai che scavavano nel vicolo tra le insulae
VII 9 e VII 14 (da quel momento chiamato Vicolo degli Scheletri). Si
ottenne così il primo calco completo di un corpo umano al quale si
aggiunsero nel tempo quelli di molte altre vittime. Le carni erano
consunte, ma la cenere che aveva ricoperto i corpi ne aveva conservato
l’impronta. Nei giorni immediatamente successivi Luigi Settembrini,
letterato amico di Fiorelli, descriveva i ritrovamenti con lirico
entusiasmo sul “Giornale di Napoli”:
«è
impossibile vedere quelle tre sformate figure, e non sentirsi
commosso […]. Sono morti da diciotto secoli, ma sono creature umane che
si vedono nella loro agonia. Lì non è arte, non è imitazione; […] è il
dolore nella morte che racquista corpo e figura. Finora si è scoverto
templi, case ed altri oggetti che interessano la curiosità delle
persone colte, degli artisti e degli archeologi. Tu, o mio Fiorelli,
hai scoperto il dolore umano, e chiunque è uomo lo sente». [8]
L’impronta
da cui si ottiene il calco è strettamente connessa con ciò che l’ha
generata: ne costituisce il sostituto, il doppio. Volendo utilizzare le
categorie semiologiche di Charles Sanders Peirce [9], i calchi pompeiani hanno valore di indice
perché mantengono una connessione reale col referente, presupponendo un
contatto fisico con esso e condividendone alcune proprietà. I calchi
furono ammirati non solo come eccezionali documenti archeologici, ma
come opere d’arte.
L’artista
che nel secolo scorso ha più di ogni altro fatto riferimento ai calchi
pompeiani è George Segal. A partire dagli anni Sessanta egli realizza
delle sculture applicando sui modelli bende su cui poi versa del gesso
liquido; tagliando e ricomponendo la bende ottiene figure immobilizzate
in un preciso istante. La suggestione delle vittime di Pompei è
evidente in opere come L’olocausto
(fig. 8) composta da undici figure in bronzo smaltato, dieci delle
quali giacciono inerti al suolo coprendosi parzialmente una con l’altra
in un abbraccio di morte, mentre l’undicesima è in piedi dietro il filo
spinato.
Ai calchi pompeiani si sono ispirati più recentemente anche altri scultori. Critical Mass (fig.
9) è un’installazione realizzata nel 1994 dall’inglese Antony Gormley
nella quale oltre sessanta corpi giacenti in varie posizioni
riecheggiano il celebre Orto dei Fuggiaschi scavato nel 1961 a Pompei
dall’archeologo Amedeo Maiuri. Guardando all’ambito italiano, I dormienti
(fig. 10) di Mimmo Paladino eseguiti a partire dal 1998 devono molto ai
calchi pompeiani: figure dalle teste ovali, calve e con ridotti cenni
somatici, realizzate in terracotta o in bronzo che giacciono
rannicchiate in posizione fetale. Secondo George Kubler un’opera d’arte
è sempre «un pezzo di divenire immobilizzato, o un’emanazione del tempo passato» [10].
Proprio tale aspetto e ciò che accomuna i calchi di Pompei alle opere
che a essi si ispirano: in entrambi i casi ciò che si osserva è la
rappresentazione dell’arresto di un movimento in atto, di un’azione
potenziale.
Il metodo scientifico di raccolta, ordinamento ed esposizione degli
oggetti proprio dell’archeologia viene impiegato dall’artista americano
Mark Dion. Un esempio è l’opera Tate Thames Dig
(fig. 11) realizzata nel 1999 setacciando con un gruppo di archeologi e
volontari il terreno lungo le rive del Tamigi prima a Millbank poi a
Bankside ed esponendo i risultati di questo scavo in una vetrina
alla Tate Gallery (un lato contiene oggetti trovati a Millbank, l’altro
quelli di Bankside). Frammenti di ceramica, ossa, vetri rotti e ogni
sorta di oggetto restituito dallo “scavo” viene pulito, ordinato per
tipo, peso e colore, catalogato e collocato all’interno della vetrina;
Dion trasforma il banale in oggetto d’arte. Ciò che Dion ottiene è un
gabinetto delle curiosità, un contenitore con forti allusioni al
fenomeno tipicamente cinquecentesco delle Wunderkammer [11] per l’esposizione delle mirabilia.
Già in precedenza Dion aveva adottato metodi pseudo-archeologici per
creare le proprie istallazioni. L’incontro con il metodo archeologico
avviene nel 1996 con History Trash Scan opera realizzata con oggetti recuperati durante uno scavo eseguito a Perugia. Sempre uno scavo sta alla base dell’istallazione Raiding Neptune’s Vault
esposta nel 1997 alla Biennale di Venezia costituita dagli oggetti
dissepolti, sempre tramite il setaccio, in una decina di metri cubi di
laguna veneta. Le raccolte di Dion hanno un potenziale culturale in
quanto raccontano i mutamenti della società che ha prodotto quegli
oggetti.
La sua ricerca artistica è volta anche all’analisi dei metodi e dei
luoghi istituzionali che creano una struttura rappresentativa della
natura e della storia umana. Il riferimento alle Wunderkammer rinascimentali diventa palese con la realizzazione di opere come Theatrum Mundi - Armarium
(fig. 12) realizzata nel 2001 in collaborazione con lo scultore Robert
Williams ed esposta a Cambridge nella cappella medievale dello Jesus
College. La connessione alla tradizione cinquecentesca questa volta non
riguarda soltanto la struttura ma anche la scelta espositiva che
ricalca
l’ordinamento del mondo (Deus, verbum, intelligensus, intellectus, ratio, immaginatio e sensus)
elaborato dall’alchimista Robert Fludd (1574-1637). Dion e Williams
mettono insieme una grande quantità di oggetti - ossa, animali
impagliati, giochi per bambini, libri, pietre, strumenti musicali - e
li collocano in armadi e teche allo scopo di ricreare l’atmosfera dei
musei di storia naturale. L’osservatore è spinto a guardarsi intorno e
ipotizzare connessioni possibili tra la gran varietà di elementi
ordinatamente esposti. Il cabinet de curiosités
diventa un campo da perlustrare ed esperire attraverso una modalità di
indagine tipica di tanta arte contemporanea e propria delle collezioni
museali: l’osservatore percorre lo spazio del museo/installazione e
cerca di coglierne il significato profondo analizzando oggetti e
connessioni. Dion allo Jesus College associa oggetti dalle provenienze
più disparate ricreando un microcosmo in cui a teschi, animali
impagliati e piante essiccate si aggiungono giochi per bambini, video e
libri: la Wunderkammer diventa un contenitore fisico e concettuale in cui convergono cultura antica e sapere moderno [12].
Un’altra questione legata all’archeologia indagata dall’arte
contemporanea è il colore. La policromia dell’arte classica inizia a
essere analizzata già nell’Ottocento quando gli scavi operati a Egina nel
1811 dall’architetto britannico Charles Robert Cockerell avevano
rilevato tracce di policromia nelle sculture frontali del tempio dorico
dedicato alla dea Afaia. Pochi anni dopo anche l’opera di Quatremère de
Quincy, Le Jupiter Olympien
del 1814, contribuì al dibattito sulla policromia delle sculture
antiche; posizioni poi rafforzate negli anni Venti dell’Ottocento dagli
studi dell’architetto Gottfried Semper che, viaggiando prima in Italia
e poi in Grecia, contribuirà ad alimentare la diatriba con scavi che
dimostrarono come statue, templi e terrecotte antiche fossero in
origine dipinti con colori squillanti.
Lo studio di tale aspetto è stato affrontato in tempi recenti
dall’archeologo tedesco Vinzenz Brinkmann che, studiando i pigmenti
ancora presenti sulle opere antiche, si arma degli strumenti
dell’artista e fa rivivere la policromia dell’arte antica mostrando il
colore originario delle opere e cancellando gli effetti del tempo e
dell’ossidazione. È questo un aspetto della classicità che per lungo
tempo la storia dell’arte sembrerebbe aver voluto negare. A partire
dagli anni Ottanta del Novecento, attraverso un’attenta analisi dei
residui di pigmenti ancora presenti sui bronzi e i marmi antichi,
Brinkmann ha dato forma a scrupolose ricostruzioni a colori delle
sculture classiche messe in mostra per la prima volta al Glyptothek di
Monaco di Baviera nel 2003 (in virtù dell’interesse suscitato, la
mostra è ben presto diventata itinerante). Queste copie, realizzate in
marmo o gesso e dipinte con pigmenti naturali, sono frutto di accurati
studi: le aree dove non c’è alcuna prova della colorazione originale
vengono, ad esempio, lasciate bianche (fig. 13). Brinkmann intende far
riflettere sull’uso della policromia in statue che si immaginano
esclusivamente nel colore del marmo o del bronzo ossidato; una vivacità
spesso disturbante che, tuttavia, offre una declinazione inattesa
dell’arte classica.
Tra gli artisti che guardano alle sperimentazioni di Brinkmann c’è
Hans-Peter Feldmann. Egli a partire dagli anni Settanta del Novecento,
realizza sgargianti riproduzioni in gesso di sculture classiche e
rinascimentali ricoprendone il bianco candore con colori brillanti e
saturi che disturbano la percezione tradizionale dell’antico (fig. 14).
Il ricorso alle forme della stratigrafia è presente, invece, nel lavoro
di Tony Cragg che costruisce le proprie opere riflettendo sui concetti
di frammentazione e ricomposizione (fig. 15). Assemblando materiali di
scarto da forma a cubi solidi costituiti da pezzi di legno di varie
dimensioni posizionati orizzontalmente a comprimere gli oggetti in
densi strati che ricordano le sezioni geologiche o archeologiche [13].
Nell’ordinamento di frammenti che spaziano dai materiali da costruzione
alle riviste scartate, la geometria incontra la selezione casuale.
L’attualizzazione dell’archeologia e la ricerca di connessioni tra
antico e presente è uno degli aspetti su cui si concreta molta arte
contemporanea. L’artista, come l’archeologo, sottrae al passato le sue
forme e, riesumandole, le colloca nello spazio dell’agire presente. È
interessante notare come tale “vivificazione” dell’antico passi anche
attraverso la riappropriazione del sito archeologico che, sempre più,
diventa spazio da contaminare con il contemporaneo. Disseppellire i
resti archeologici ha, in fondo, il limite di creare una frattura tra
il presente attivo e un passato che ha ormai perso la sua vitalità
svuotandosi delle proprie funzioni. L’arte contemporanea che si ispira
o viene istallata in questi luoghi tenta di sanare questa frattura
promuovendo un confronto dialettico tra il moderno e l’antico. Il
connubio tra antico e contemporaneo sarebbe, dunque, in grado di
riportare in superficie la memoria dei luoghi e il loro valore storico.
Attraverso la ricerca dell’equilibrio tra ciò che è stato e ciò che
potrebbe essere, il contemporaneo aggiunge all’antico nuovi
significati, legati alle tracce passate ma rispondenti ai bisogni
attuali e ne favorisce la comprensione profonda e la fruizione attiva.
L'argomento trattato in
questo articolo è un approfondimento legato alle ricerche compiute nel
redigere il capitolo di chiusura della mia tesi di laurea magistrale Arte Classica - Arte Povera. La ripresa del classico tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento in Italia.
Ringrazio, pertanto, il Prof. Claudio Zambianchi, relatore della tesi,
per i preziosi insegnamenti e le proficue conversazioni che hanno
guidato la mia riflessione e il Prof. Marcello Barbanera, correlatore,
per avermi fornito testi e dati indispensabili per la redazione della
ricerca offrendomi utili consigli che mi hanno aiutato ad approcciare
gli aspetti dell’articolo più strettamente legati all'ambito
archeologico.
NOTE
[1] RENFREW (2003), pp. 26-94.
[2] SETTIS (2004), pp. 101-114.
[3] MARCONE (2010), pp. 217-239.
[4] ORAZIO, Odi, III, 30, 1.
[5] AUGÉ (2004), pp. 98-99.
[6] NORCIA (2015), p. 38.
[7] BEVILACQUA (2015), pp. 126-133.
[8] SETTEMBRINI (1863), p. 1.
[9] Charles Sanders Peirce (1839-1914) individua tre tipi principali di segni: indici, icone e simboli.
Gli indici sono dei segni in cui l’espressione e il contenuto sono legati da un rapporto di origine naturale e di tipo causale. Le icone
sono segni che rinviano a un oggetto o a un evento per analogia, in
virtù di una somiglianza con esso. Si tratta di segni prodotti
volontariamente, con l’intenzione di comunicare qualcosa. I simboli
sono segni nei quali il legame tra espressione e contenuto non ha
motivazioni di tipo naturale o analogico, come avviene per gli indici e
le icone. Il rapporto tra espressione e contenuto nei simboli è invece
di tipo convenzionale, cioè è garantito da una tradizione culturale a
cui partecipano tanto l’emittente quanto il destinatario del segno.
[10] KUBLER (2002), p. 28.
[11] Quello delle Wunderkammer (dette anche cabinets de curiosités
o camere delle meraviglie) fu un fenomeno tipico del Cinquecento, che
affonda le sue radici già nel Medioevo quando nascono le prime raccolte
di curiosità. Il termine è un’espressione usata per indicare
particolari ambienti in cui, in particolare modo tra XVI e XVIII
secolo, gli studiosi e appassionati collezionisti erano soliti
conservare raccolte di oggetti di ogni genere ritenuti straordinari
purché fossero mirabilia.
[12] RENFREW (2003), pp. 84-94.
[13] ECCHER (1994), pp. 34-47.
BIBLIOGRAFIA
AUGÉ 2004
Marc AUGÉ, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
BEVILACQUA 2015
Mario BEVILACQUA, Piranesi: crolli e rovine, in La forza delle rovine,
catalogo della mostra (Roma 2015-2016), a cura di Marcello BARBANERA,
Alessandra CAPODIFERRO, Verona, Electa, 2015, pp. 126-141.
COEN 2009
Ester COEN, Reperti e amnesie, in Relitti riletti. Metamorfosi delle rovine e identità culturale, a cura di Marcello BARBANERA, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, pp. 158-171.
ECCHER 1994
Danilo ECCHER, La poetica del frammento e della proporzione, in Cragg, catalogo della mostra (Trento 1994), a cura di Germano CELANT, Danilo ECCHER, Milano, Charta, 1994, pp. 34-47.
KUBLER 1972
George KUBLER, La forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle cose, Torino, Einaudi, 1972.
MARCONE 2010
Gaspare Luigi MARCONE, Introduzione all’arte di Anne e Patrick Poirier, “LANX” 7, Milano, 2010, pp. 217‐239.
NORCIA 2015
Audrey NORCIA, La rovina, nuovo paradigma del XX e del XXI secolo: per una riflessione sull’umanità, in La forza delle rovine, catalogo della mostra (Roma 2015-2016), a cura di Marcello BARBANERA, Alessandra CAPODIFERRO, Verona, Electa, 2015, pp. 34-45.
ORAZIO 2010
Quinto ORAZIO Flacco, Odi ed Epodi, traduzione a cura di Ugo DOTTI, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 338-339.
RENFREW 2003
Colin RENFREW, Figuring it out. What are we? Where do we come from? The parallel vision of artists and archaeologists, Londra, Thames & Hudson, 2003.
SETTEMBRINI 1863
Luigi SETTEMBRINI, I Pompeiani, in "Giornale di Napoli", 17 febbraio 1863, p. 1.
SETTIS 2004
Salvatore SETTIS, Futuro del “classico”, Torino, Einaudi, 2004.
|
|

Fig. 1
Michelangelo Pistoletto,
Paradiso contemporaneo, 2012,
marmi e mosaici,
9x5 m, Roma, Terme di Caracalla.

Fig. 2
Jannis Kounellis,
Senza l’antica prospettiva, 2013,
marmi e mosaici, misure non conosciute, Roma, Stadio di Domiziano.
Foto cortesia di
© Manuela Giusto (Inside Art).

Fig. 3
Anne e Patrick Poirier, Villa Medici. 15 erme, 1970, teche, calchi in carta, erbari e foto su ceramica, ciascuna 2x0,45x0,30 m,
Parigi, collezione Centre Georges Pompidou.
Foto cortesia di
© Anne e Patrick Poirier [2016].
Foto cortesia di
© Centre Georges Pompidou, Parigi [2016].

Fig. 4
Anne e Patrick Poirier, Ostia antica. Costruzioni, 1971-72,
terra cotta, 12x6 m,
Vienna, collezione Ludwig.
Foto cortesia di
© Anne e Patrick Poirier [2016].
Foto cortesia di
© Bildrecht, Wien [2016].

Fig. 5
Anne e Patrick Poirier, Erexit monumentum aere perennis, 1988,
acciaio inossidabile, 6x18 m,
Prato, Giardino del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci.

Fig. 6
Massimo Siragusa, Twentynineseconds. Onna, 2009.
Foto cortesia di
© Massimo Siragusa [2017].

Fig. 7
Giovanni Battista Piranesi, Veduta dei resti del tempio di Nettuno a Paestum, 1778, incisione all’acquaforte, 50,5x68,5 cm,
Napoli, Fondazione Giambattista Vico.
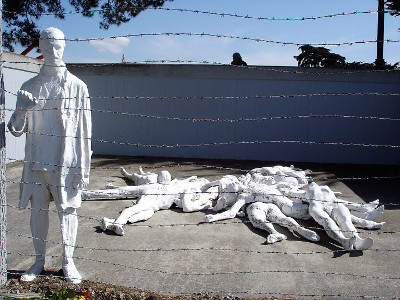
Fig. 8
George Segal, L’olocausto, 1982,
bronzo smaltato, installazione ambientale variabile,
San Francisco, Legion of Honor Park.

Fig. 9
Antony Gormley, Critical mass II, 1995,
acciaio, 200x30 m,
Vienna, Remise.
Foto cortesia di
© Antony Gormley.
Foto cortesia di
© Stephen White Photo.

Fig. 10
Mimmo Paladino I dormienti, 1999,
terracotta, installazione ambientale variabile,
Castelbasso, VARIeAZIONI.
Foto cortesia di
© Gino Di Paolo e Mario Di Paolo (Artribune).

Fig. 11
Mark Dion, Tate Themes Dig, 1999,
struttura in legno contenente porcellana, terracotta, metallo, ossa di animali,
vetro e carta, 2,66x3,70x1,26 m,
Londra, Tate Gallery.
Foto cortesia di
© Mark Dion [2017].
Foto cortesia di ©Tate, London [2017].

Fig. 12
Mark Dion, Theatrum Mundi - Armarium, 2001, struttura in legno contenente porcellana, terracotta, metallo, ossa, vetro e carta, 5,02x5,63 m,
Cambridge, Jesus College.
Foto cortesia di
© Mark Dion and Robert Williams.
Foto cortesia di
© Roger Lee Photo.

Fig. 13
Vinzenz Brinkmann,
Statua di arciere troiano dal Tempio di Egina, 2007,
modellino policromo in gesso, 1,04 m,
Monaco, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek.

Fig. 14
Hans Peter Feldmann,
David, 2009,
gesso dipinto, 90 cm,
Brescia, Galleria Massimo Minini.

Fig. 15
Tony Cragg, Stack, 1976, legno, cemento, mattoni, metallo, plastica, tessuto, cartone e carta,
2x2x2 m,
Londra, Tate Gallery.
|


