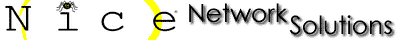|
Il
2009 segna una tappa storica per i trasporti italiani: la linea
ferroviaria ad alta velocità collega per la prima volta il Nord e il
Sud Italia, nel percorso tra Torino e Salerno, passando per Milano,
Bologna, Firenze, Roma e Napoli. I lavori per la realizzazione di una
rete ferroviaria capace di raggiungere velocità fino a 300 Km/h
erano già iniziati a partire dagli anni Novanta del XX secolo. Ai
fini della pianificazione, progettazione e realizzazione di tale
ambiziosa infrastruttura, nel 1991 fu fondata a Roma la TAV S.p.a.,
una società per azioni interamente controllata da RFI (Rete
Ferroviaria Italiana), a cui verrà definitivamente incorporata nel
2010 in un'Italia ormai attraversata - seppur non per intero -
dalle ferrovie ad alta velocità. Fu un processo graduale che
richiese anni di pianificazioni e lavori. La prima tratta ad alta
velocità, inaugurata nel 1992, fu la Firenze - Roma. Nel 2005 la
capitale fu collegata dall'alta velocità pure a Napoli. Il 2008 fu
l'anno delle tratte Bologna - Milano e Napoli - Salerno. Nel
dicembre 2009 furono conclusi i percorsi tra Torino e Milano e tra
Bologna e Firenze. Negli anni la linea ad alta velocità è stata
estesa e tutt'ora si pianificano e realizzano nuove tratte.
L'avvento
di tale innovazione segnò l'inizio di una nuova era per i
trasporti, offrendo al Paese una ‘metropolitana nazionale' capace
di accorciare significativamente le distanze tra le principali città
italiane ed europee, risparmiando quantità considerevoli di CO2
rispetto ai viaggi in macchina o in aereo. Un passo tanto importante
richiedeva però stazioni adeguate, capaci di far fronte alle nuove
esigenze della modernità. Nei primi anni del XXI secolo, furono
imbanditi grandi concorsi internazionali per la realizzazione di
nuove grandi stazioni o per l'adeguamento di quelle esistenti. Tali
concorsi riscossero un certo successo, attirando progetti da parte di
architetti di fama internazionale, tra cui Zaha Hadid e Santiago
Calatrava.
Sin
dall'Ottocento, le stazioni ferroviarie hanno rappresentato una
preziosa occasione di sperimentazione architettonica, in quanto prive
di riferimenti nella tradizione edilizia passata. Si pensi alle
grandi stazioni ottocentesche di Parigi, come la Gare
du Nord,
un edificio a metà tra neogotico e neoclassico, così come la Gare
de l'Est.
Tra le grandi stazioni che hanno fatto storia in Italia si possono
citare Torino Porta Nuova, Milano Centrale e la vecchia Roma Termini,
smantellata a inizio anni Quaranta per essere sostituita dall'attuale
edificio di Mazzoni. Architetture eclettiche che uniscono e combinano
tra loro gli stili architettonici giungendo a forme inedite.
Sebbene
nel nuovo millennio la stazione non rappresenti più una tipologia
architettonica nuova, la progettazione di nuove stazioni ferroviarie
continua ad offrire un'opportunità per sperimentare soluzioni in
linea con le nuove tendenze dell'architettura contemporanea. Un
esempio significativo è rappresentato dai concorsi internazionali
per le stazioni dell'alta velocità imbanditi nei primi anni
Duemila, che hanno visto la presentazione di progetti caratterizzati
dai principi dell'architettura liquida.
Non a caso, questi progetti si sono aggiudicati le gare, dando vita a
opere che incarnano perfettamente l'estetica e la funzionalità
richieste dalla modernità.
Torino
Porta Susa
La
Stazione di Torino Porta Susa, inaugurata nel 1856 su progetto di
Carlo Promis, era originariamente un elegante edificio in stile
eclettico, progettato per servire la linea ferroviaria verso Milano.
Il fabbricato ottocentesco, tuttavia, si rivelò inadatto ad ospitare
le esigenze della nuova linea ad alta velocità, che richiedeva spazi
maggiori sia nell'area del fabbricato viaggiatori che in quella dei
binari. Per questa ragione, nel 2001 fu indetto uno dei primi grandi
concorsi internazionali per la progettazione delle nuove stazioni
destinate all'alta velocità. L'esigenza di una nuova grande
stazione in quel contesto urbano non si limitava alla questione degli
spazi ampliati, ma era motivata anche da altri fattori cruciali. In
primo luogo, vi era l'esigenza di garantire un accesso agevole non
solo da sud, verso Piazza XVII Dicembre e via Cernaia, prossime al
centro storico, ma anche da nord, un'area in rapido sviluppo. In
questa zona, nel 2001 fu inaugurato il nuovo Palazzo di Giustizia di
Torino, accanto ad un edificio noto come ‘grattacielo orizzontale',
una sede storica di uffici Telecom, ceduta alla provincia nel 1999.
Nella stessa area nel 2015 verrà inaugurato il Grattacielo Intesa
Sanpaolo, opera di Renzo Piano concepita come nuova sede dell'omonimo
gruppo bancario.
Un
altro elemento determinante fu la necessità di liberare un'ampia
area della città dai binari ferroviari, interrandoli per restituire
gli spazi soprastanti alla cittadinanza. Sin dall'introduzione
delle prime reti ferroviarie, fino alla fine del Novecento, la prassi
prevedeva la costruzione di binari in superficie, a prescindere che
ci si trovasse in area di campagna o in piena città, in una valle
montana o lungo la costa. La priorità era quella di rincorrere la
modernità rappresentata dal trasporto ferroviario, pur non curandosi
dell'impatto che tali infrastrutture avrebbero avuto sul paesaggio.
Fu adottato lo stesso approccio per la costruzione di nuove strade e
parcheggi nel Novecento. Negli ultimi decenni si è compreso che
questa direzione non sarebbe più stata sostenibile. Oggi, la
tendenza è quella opposta: interrare le infrastrutture dedicate ai
trasporti per restituire alla città gli spazi di superficie,
valorizzandoli per usi pubblici e migliorando la qualità della vita.
Interventi di questo genere rappresentano un'importante occasione
di riqualificazione urbana, proprio come è avvenuto a Torino con il
progetto della Spina Centrale, un piano urbanistico che si è posto
l'obiettivo di creare nuovi punti di centralità tramite il
recupero delle aree dismesse. Si è configurato come una sorta di
‘spina dorsale cittadina' costituita da un viale lungo 12 km e
diviso in quattro aree. La nuova stazione di Torino Porta Susa si
inserisce nell'ambito della Spina 2, che si estende lungo corso
Inghilterra, da corso Vittorio Emanuele II a piazza Statuto.
 Fig. 1 - Vista panoramica sulla Spina 2
Fig. 1 - Vista panoramica sulla Spina 2
A sinistra: GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino
a destra: RENZO PIANO, Grattacielo Intesa Sanpaolo, 2005, Torino. (©La Stampa)
Cortesia di Enrico Finocchiaro
Il
concorso del 2001 per la progettazione della stazione fu vinto dal
gruppo italo-francese AREP. I lavori furono avviati nel 2008 e la
stazione fu attivata a partire dal 2013. Il progetto richiese un
intervento complessivo di 79 milioni di euro, per una superficie
coperta utile pari a 47.500 mq che ospita sei binari. Si tratta di
una stazione di dimensioni medio-grandi, adeguata a una città che,
pur avendo consolidato la sua identità industriale negli anni del
boom economico, oggi ha pure una vocazione turistica in quanto città
d'arte, di storia, di cultura e di scienza. La posizione di Torino,
sul piano dei percorsi ferroviari, è decentrata rispetto all'asse
strategico Roma - Milano, ma ha la fortuna di porsi alle porte della
Francia, fungendo da passaggio obbligato per le connessioni
transalpine.
Il
progetto presentato dal gruppo AREP prevedeva un fabbricato
passeggeri ispirato ai passages
ottocenteschi, realizzato interamente in ferro e vetro. Da un punto
di vista geometrico, l'edificio è un semicilindro schiacciato, con
una particolarità: il punto di schiacciamento non si trova al
centro, come ci si attenderebbe secondo il principio di simmetria,
bensì in una posizione decentrata rispetto all'asse del
fabbricato, rendendolo asimmetrico e, di conseguenza, anticlassico.
Un ulteriore elemento di architettura liquida dell'edificio è
rappresentato dalla presenza del tema dello specchio. La superficie
vetrata della galleria, infatti, è riflettente, integrandosi con il
cielo e mutando aspetto in base alle condizioni atmosferiche e
all'orario del giorno. All'imbrunire, invece, la stazione diviene
una sorta di ‘lanterna' che illumina il paesaggio urbano
circostante, con cui si pone in costante dialogo.
 Fig. 2 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino
Fig. 2 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino
sul fondo: RENZO PIANO, Grattacielo Intesa Sanpaolo, 2015, Torino
© e cortesia di Enrico Finocchiaro
I
binari sono interrati e decentrati rispetto al fabbricato
viaggiatori, che si presenta come una grande piazza coperta
irregolare. Gli spazi si articolano in terrazzamenti, passerelle,
rampe e percorsi non lineari che permettono uno sviluppo su più
livelli.
 Fig. 3 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino
Fig. 3 - GRUPPO AREP, Stazione di Torino Porta Susa, 2008, Torino
© e cortesia di Enrico Finocchiaro
La
stazione, inoltre, è progettata seguendo i principi di sostenibilità
ambientale. Le lastre di vetro della copertura, infatti, presentano
celle fotovoltaiche monocristalline che producono ogni anno 680.000
KWh, coprendo la maggior parte del fabbisogno energetico diurno
dell'edificio.
Nel 2013 Torino Porta Susa è stata insignita del Premio Solare
Europeo da Eurosolar e, nello stesso anno, ha ricevuto il
riconoscimento di ‘migliore stazione europea dell'anno' in
occasione dell'European
Rail Congress,
confermandosi un esempio virtuoso di architettura moderna,
sostenibile e innovativa.
Tra
i progetti presentati al concorso, quello del gruppo italo-francese
AREP non fu l'unico a distinguersi per le caratteristiche di
architettura liquida. Tra i progetti finalisti, quello di Turner &
Townsend Group era caratterizzato da una grande copertura
dall'andamento dissimmetrico, quello del gruppo Iaw proponeva
un'articolazione degli interni labirintica e vorticosa, e infine
quello di Lisandro Gambogi presentava un corpo di fabbrica sviluppato
longitudinalmente secondo un percorso a zig zag, non lineare.
Reggio
Emilia AV Mediopadana
Il
caso della stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana è molto diverso
rispetto a quello di Torino Porta Susa, a partire dal contesto di
ubicazione. Reggio Emilia, con i suoi 171.316 abitanti, è una città
di medie-piccole dimensioni. La nuova stazione dell'alta velocità,
inoltre, si trova a ben 4 Km dal centro abitato, in un'area
extraurbana adiacente all'Autostrada del Sole. Tale stazione,
infatti, non è progettata per servire la singola città, ma una
vasta area regionale che comprende le province di Reggio Emilia,
Parma, Modena e Mantova. Uno dei principali vantaggi che conduce
molti viaggiatori a preferire il treno all'aereo per gli
spostamenti tra le città italiane è costituito dalla comodità di
partire dal centro di una città per arrivare direttamente nel centro
di un'altra, evitando i lunghi trasferimenti verso gli aeroporti, i
tempi di attesa per l'imbarco di eventuali bagagli e i controlli di
sicurezza. La stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana, invece,
adotta una logica simile a quella degli aeroporti: situata fuori dal
centro urbano, compensa però questa caratteristica con il vantaggio
di servire un bacino territoriale molto più vasto.
Il
concorso, bandito nel 2008, fu vinto dall'architetto di fama
internazionale Santiago Calatrava, il cui progetto prevedeva la
realizzazione di una stazione dotata di due binari, oltre a quelli
centrali per i treni di passaggio. I lavori iniziarono nel 2010 e
furono completati in breve tempo, consentendo di inaugurare la
stazione nel 2013, con un costo complessivo di 79 milioni di euro.
L'edificio,
emblematico esempio di architettura liquida, è caratterizzato dalla
successione di portali in acciaio disposti in maniera irregolare e
asimmetrica, che generano un suggestivo andamento ondulatorio. Tra i
riferimenti che hanno influenzato questa soluzione architettonica
spiccano Casa
Batlò di
Antoni Gaudì a Barcellona e il Padiglione
Quadracci,
progettato dallo stesso Calatrava negli Stati Uniti. La stazione è
priva di una facciata propriamente intesa, come nel caso di Torino
Porta Susa; tuttavia, a differenza di quest'ultima, i binari sono
in superficie, data la collocazione extraurbana dell'opera.
 Fig. 4 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana
Fig. 4 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana
2013, Reggio Emilia. (©Fanpage). Cortesia di Enrico Finocchiaro
La
presenza di Calatrava nella provincia di Reggio Emilia non era nuova.
L'architetto aveva già lasciato il suo segno nella zona con la
realizzazione di tre ponti, posti in successione lungo l'Autostrada
del Sole, diventati simboli architettonici della zona. Un altro
progetto di Calatrava nella stessa provincia, pur mai realizzato, è
quello per il nuovo casello autostradale di Reggio Emilia, che
ricorda la conformazione di un passaggio a livello misto ad un ponte.
Calatrava è infatti noto a livello internazionale per le sue
straordinarie opere nel campo della costruzione di ponti.
 Fig. 5 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana
Fig. 5 - SANTIAGO CALATRAVA, Stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana
2013, Reggio Emilia, sul fondo:
SANTIAGO CALATRAVA, Ponte centrale, ponte sud e ponte nord sull'Autostrada A1
2007, Reggio Emilia, (©Luigi Paesano Photography). Cortesia di Enrico Finocchiaro
Firenze
Belfiore
Firenze
è la quarta città più turistica d'Italia, ma attualmente dispone
di una sola stazione dell'alta velocità: la storica stazione di
Santa Maria Novella. La sua posizione è molto comoda per i turisti,
che arrivano direttamente nel centro storico, ma risulta meno
funzionale per il traffico ferroviario essendo una stazione di testa.
È
utile a questo punto chiarire il concetto di stazione di testa e
stazione passante. Le stazioni possono essere classificate in due
tipologie principali, in base all'ubicazione del fabbricato
viaggiatori rispetto ai binari. Nelle stazioni di testa i binari
terminano con un respingitore posto alle soglie del fabbricato
viaggiatori. Per ripartire, dunque, i treni devono invertire la
marcia. Questo tipo di stazione era tipico delle grandi costruzioni
ferroviarie dell'Ottocento e del Novecento, come Roma Termini,
Torino Porta Nuova e la stessa Firenze Santa Maria Novella. Le
stazioni passanti, invece, permettono al treno di fermarsi e
ripartire senza dover invertire la marcia, rendendo il traffico
ferroviario più scorrevole e riducendo i tempi di viaggio. Per
questa ragione, la tendenza attuale è quella di progettare anche le
grandi stazioni seguendo questo modello. Firenze Belfiore sarà una
stazione di transito, ma situata in un'area della città meno
centrale rispetto a Santa Maria Novella.
A
differenza dei casi precedentemente esposti di Torino Porta Susa e
Reggio Emilia AV Mediopadana, il cantiere per la stazione di Firenze
Belfiore è stato vittima di vicende travagliate che si sono tradotte
in una dilatazione dei tempi ed un conseguente significativo aumento
dei costi. Il concorso fu bandito nel 2002, solo un anno dopo quello
di Torino, e vinto dal team
composto da Foster & Partners per l'architettura e Ove Arup &
Partners per l'ingegneria. Il cantiere fu aperto nel 2007 con
duecentocinquanta operai, ma fu presto interrotto a causa della crisi
industriale di Condotte, grande azienda di costruzioni, che ha
trascinato con sé le controllate, tra cui Nodavia, azienda
appaltatrice dell'opera. A questi problemi si aggiunsero polemiche
politiche e vicende giudiziarie.
Matteo Renzi, sindaco di Firenze dal 2009 al 2014, si dichiarò
contrario alla realizzazione dell'opera, dichiarando che era in
corso “una battaglia tra Firenze e le Ferrovie”.
I lavori ripresero, pur lentamente, nel 2021 con il sostegno del
nuovo sindaco Dario Nardella. Tutti questi ritardi hanno portato i
costi a lievitare fino a una stima attuale di 1,6 miliardi di euro,
mentre l'inaugurazione è prevista per il 2028. Di certo il
progetto dell'architetto britannico Foster è molto ambizioso e,
già in principio, stimava dei costi pari a 350 milioni di euro, una
cifra ben più alta rispetto a quella spesa per il progetto di
Calatrava a Reggio Emilia o per il progetto del gruppo AREP a Torino.
La stazione, con quattro binari per ben 48.700 mq di superficie
coperta utile, si presenterà come un enorme edificio dalle
caratteristiche liquide. Dai rendering
si evince che il fabbricato viaggiatori avrà la conformazione di un
grande semicilindro slanciato verso l'esterno alle estremità,
evocando delle vele triangolari. Quest'ultime lasceranno sotto di
sé un ampio spazio vuoto, come fosse una facciata invisibile, o
meglio inesistente, che segnerà una continuità con lo spazio
urbano. La struttura semicilindrica sarà composta da elementi di
copertura accostati tra loro come pezzi un puzzle irregolare e dalla
figura non comprensibile, creando un effetto visivo complesso e
dinamico.
 Fig. 6 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore
Fig. 6 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore
da realizzare, Firenze, computer rendering
(©RFI). Cortesia di Enrico Finocchiaro
Gli
interni saranno organizzati su più livelli tramite terrazzamenti e
passerelle che collegheranno i piani superiori al piano binari,
situato sotto il livello stradale. Quest'ultimo beneficerà di
illuminazione naturale, perché sarà in asse con la stazione, a
differenza di Torino Porta Susa, dove i binari sono decentrati
rispetto al fabbricato viaggiatori.
 Fig. 7 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore
Fig. 7 - NORMAN FOSTER & ARUP, Stazione di Firenze Belfiore
da realizzare, Firenze, computer rendering. (©RFI)
Cortesia di Enrico Finocchiaro
La
stazione di Firenze Belfiore, così come quella di Torino Porta Susa,
è progettata come una grande piazza coperta, un'estensione dello
spazio urbano destinata a ospitare attività commerciali e di
ristorazione. Nel caso di Torino Porta Susa, tuttavia, la stragrande
maggioranza dei locali commerciali è rimasta vuota, aspetto che
suggerisce la necessità di un'attenta valutazione interna e di
un'attività di pianificazione da parte Ferrovie dello Stato.
Almeno nelle intenzioni, entrambe le stazioni vogliono svolgere il
ruolo di piazze coperte nel tessuto urbano. Non dobbiamo pensare
all'immaginario della piazza rinascimentale, lineare, dalla forma
geometrica ben connotata, simmetrica e proporzionata. Insomma, la
piazza de La
città ideale.
Le nuove grandi stazioni dell'alta velocità sono piazze
asimmetriche, irregolari, labirintiche, su più livelli,
sproporzionate nelle misure. Piazze liquide.
Napoli
Afragola
Afragola
è un comune di 61.432 abitanti situato a nord di Napoli. La città
partenopea già disponeva di una stazione per i treni ad alta
velocità, quella di Napoli Centrale, collocata vicino al centro
storico. La realizzazione di un'altra grande stazione dell'alta
velocità a pochi chilometri trova giustificazione nella stessa
logica che ha portato all'apertura di Reggio Emilia AV Mediopadana.
Napoli Afragola, infatti, non è una stazione destinata a servire una
singola città, ma un'intera area regionale, rispondendo alle
esigenze del vasto e densamente popolato territorio a nord di Napoli.
Il
concorso per la stazione di Napoli Afragola fu bandito nel 2003 e
vinto dal progetto dell'architetta internazionale Zaha Hadid. I
lavori furono avviati nel 2015 e si conclusero nel 2017, con un costo
complessivo pari a 80 milioni di euro, in linea con le spese
sostenute per le stazioni di Torino Porta Susa e Reggio Emilia AV
Mediopadana.
Al
concorso furono presentati diversi progetti che incarnavano i
principi dell'architettura liquida. Il progetto di Pica Ciamarra,
ad esempio, prevedeva una grande cupola emisferica ribassata, dalle
dimensioni imponenti e sproporzionate, molto distante dal prototipo
della cupola classica. Quello di Peter Eisenman si distingueva per la
complessità delle forme irregolari, simili ad un mostro che avrebbe
inglobato al suo interno i vani della stazione. Alberto Figuera,
invece, propose una successione di archi di altezze e dimensioni
diverse, accostati senza seguire principi di simmetria o regolarità.
Il progetto che ebbe la meglio, tuttavia, fu quello di Zaha Hadid,
una delle figure di spicco dell'architettura liquida, i cui
principi sono perfettamente esemplificati nella stazione di Napoli
Afragola. L'edificio si distingue per le forme irregolari e
asimmetriche, le pareti inclinate, la dissoluzione della finestra,
l'assenza di una facciata propriamente intesa. Questi aspetti
incarnano perfettamente l'estetica fluida e dinamica
dell'architettura liquida.
 Fig. 8 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)
Fig. 8 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)
(©Fabrizio Pivari). Cortesia di Enrico Finocchiaro
Un
altro aspetto rilevante è che Napoli Afragola è una stazione a
ponte. Tale configurazione consente ai binari di passare al centro
della struttura, mentre il fabbricato viaggiatori si sviluppa sopra
di essi, con accesso da entrambe le aree circostanti. La scelta di
realizzare una stazione di questo tipo nasce dall'esigenza pratica
di allargare la passerella, facendola diventare il nucleo del nuovo
parco naturalistico-tecnologico.
È dunque da inquadrare in un progetto più ampio di riqualificazione
del territorio, ma ha anche un valore altamente simbolico.
 Fig. 9 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)
Fig. 9 - ZAHA HADID, Stazione di Napoli Afragola, 2017, Afragola (NA)
(©Webuild). Cortesia di Enrico Finocchiaro
Il
ponte è un elemento architettonico che, per sua natura, richiede un
certo equilibrio statico per garantire funzionalità e sicurezza.
Tuttavia, il ponte rappresentato dalla stazione di Napoli Afragola
rompe gli schemi tradizionali: è asimmetrico, irregolare, privo di
simmetria.
Anche
la stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana presenta caratteristiche
simili. Qui, i portali in acciaio che compongono la struttura creano
un ponte - non abitabile - che sovrasta i binari. Pure in questo caso
il risultato è un ponte irregolare e privo di equilibrio.
L'idea del
ponte porta con sé un significato simbolico profondo. Esso è
l'espressione di una società in continua trasformazione,
perennemente ‘di passaggio', e un mondo sempre più
interconnesso. È un elemento di transizione che permette di superare
le distanze e al contempo dividere e connettere. Questo simbolismo
rende le stazioni a ponte non solo infrastrutture funzionali, ma
anche potenti metafore della modernità.
Il
logo: l'essenza di un brand
L'interconnessione
e la velocità sono concetti che stanno alla base dell'immagine che
una compagnia ferroviaria intende trasmettere. Nel mondo dei
trasporti si va alla costante ricerca di spostamenti sempre più
rapidi, capaci di ridurre le distanze fisiche e simboliche. Quest'
aspirazione all'efficienza e alla modernità si riflette non solo
nelle prestazioni tecniche, ma anche nell'identità visiva di
un'azienda che opera nell'ambito dei trasporti, in particolare
attraverso il logo. Quest'ultimo non è solo un elemento che
garantisce riconoscibilità al brand,
ma ne deve anche comunicare i principi e i valori.
Attraverso le forme, i colori e il design, il logo deve evocare
modernità, affidabilità e innovazione, trasmettendo al tempo stesso
il dinamismo e la velocità che caratterizzano il settore
ferroviario.
Il
logo di Ferrovie dello Stato (FS) ha subito numerosi cambiamenti nel
corso degli anni, adattandosi ai tempi e rispecchiando le
trasformazioni dell'azienda. Il primo logo, introdotto nel 1950,
era composto da una F e una S dal font
molto squadrato e spigoloso, intersecate tra loro. Questa scelta
rispecchiava bene un'epoca in cui le forme rigide e geometricamente
articolate erano sinonimo di solidità, ma appariva statica rispetto
ai valori di dinamicità che l'azienda avrebbe successivamente
abbracciato. A partire dal 1958 le due lettere furono separate,
divenendo indipendenti, pur conservando uno stile rigido e
geometrico. Questo logo, tuttavia, ebbe vita breve, infatti nel 1961
venne introdotto un nuovo un design
dalle forme più morbide e inclinate, in cui le lettere vennero
racchiuse all'interno di un quadrante di forma ovale e con sfondo
rosso. Questa versione rappresentò un primo passo verso un'immagine
più dinamica. Il quadrante fu mantenuto nel logo introdotto nel
1967, pur assumendo una forma rotonda, e fu attraversato da tre linee
grigie, simboleggianti la rete ferroviaria. Durante gli anni '70 il
design
assume forme più stilizzate, con un font
arrotondato e un aspetto complessivamente più armonioso. Tra gli
anni '80 e '90 si proseguì rispettando questa tendenza. La F e
la S, che adesso si toccano, vennero rese oblique inclinandole verso
destra, contribuendo a rendere un'idea di slancio e velocità.
Il
logo di Ferrovie dello Stato tutt'oggi utilizzato fu introdotto nel
1994, inizialmente subordinato alla scritta “Ferrovie dello Stato”
e con forme leggermente più squadrate. Inizialmente furono scelti
come colori il verde, il blu e l'azzurro, l'accostamento del
verde e del rosso, che evoca il tricolore italiano, fu introdotto a
partire dal 2007.
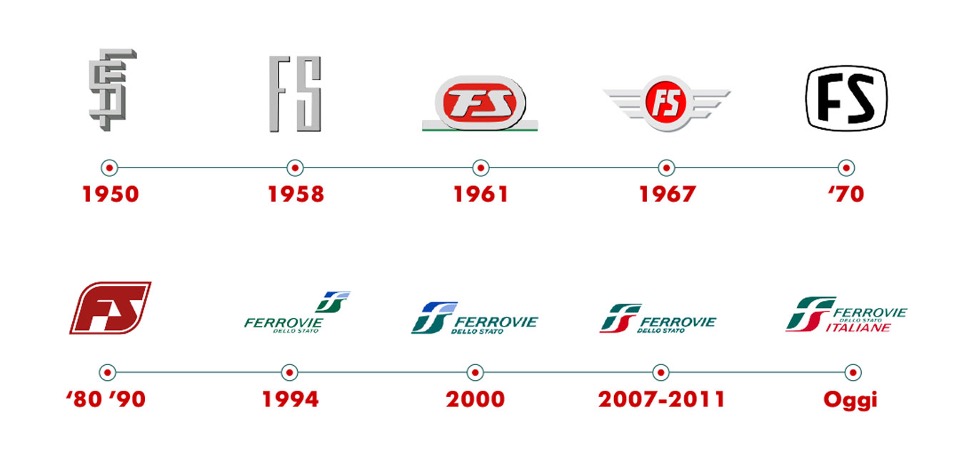 Fig. 10 - Evoluzione del logo di Ferrovie dello Stato
Fig. 10 - Evoluzione del logo di Ferrovie dello Stato
(©Ferrovie dello Stato Italiane). Cortesia di Enrico Finocchiaro
L'attuale
logo è il risultato di un processo evolutivo il cui risultato è un
design
dinamico e moderno. Le forme che lo compongono sono affiancate tra
loro ma senza toccarsi, separate ma al contempo interdipendenti,
formando una grande S che contiene al suo interno una F. Questa
configurazione sembra richiamare pure una T e una I, evocando il nome
di Trenitalia, il brand
dedicato al trasporto passeggeri. È un logo efficace, capace di
comunicare dinamismo, velocità e modernità attraverso
l'accostamento di forme apparentemente irregolari, non ben
definite, che non si toccano ma assumono un significato soltanto se
considerate insieme. Un po' come le monadi che compongono diversi
edifici di architettura liquida: forme geometriche complesse,
apparentemente disgiunte e difficili da inquadrare, ma che,
attraverso un rapporto di interdipendenza, si combinano per dar vita
ad architetture liquide.
Bauman
e la velocità nella modernità liquida
Il
tema della velocità non riguarda solo i trasporti ferroviari, ma
rappresenta anche un concetto centrale della modernità liquida
teorizzata da Zygmunt Bauman nell'omonimo saggio pubblicato nel
1999. La velocità, secondo Bauman, è uno degli elementi distintivi
del mondo liquido-moderno, in cui i cambiamenti sociali, culturali ed
economici avvengono a un ritmo sempre più rapido, con un impatto
profondo sulle relazioni sociali, sulla politica, sull'economia e
sulla vita quotidiana.
L'accelerazione
del cambiamento diventa così l'emblema di un presente in continuo
divenire, che corre più veloce di noi, determinando una sensazione
di instabilità e incertezza.
Un
esempio della rapidità dei cambiamenti a cui è soggetta la
contemporaneità è rappresentato dai progressi compiuti nell'ambito
delle tecnologie negli ultimi vent'anni. In poco tempo siamo
passati dal telefono cellulare con i tasti allo smartphone
che ci permette non solo di comunicare, ma anche di effettuare
acquisti e azioni bancarie, archiviare dati e documenti, accedere a
un numero illimitato di informazioni etc. I computer non sono più
ingombranti e necessariamente fissi, ma possono essere leggeri e
maneggevoli, dei dispositivi mobili da portare con sé a lezione per
prendere appunti, in treno e dovunque si desideri per studiare,
lavorare, vedere un film, informarsi. Persino l'orologio non è più
necessariamente quello con le lancette, ma può essere un mezzo
tecnologico che consente di connettersi al web, chiamare e ricevere
chiamate, ricevere e mandare messaggi etc.
Questi
strumenti hanno rivoluzionato profondamente la nostra quotidianità.
Uno dei risvolti più attuali della velocità di cambiamento nella
contemporaneità è costituito dall'intelligenza artificiale,
innovazione che, se sfruttata con responsabilità, può dare
molteplici vantaggi, ma che allo stesso tempo preoccupa non poco. A
livello europeo e nelle singole nazioni, Italia compresa, sono stati
istituiti comitati per l'IA, al fine di controllare questa
evoluzione con cautela, onde evitare che l'intelligenza artificiale
sfugga al controllo umano con una serie di pericolose conseguenze. La
velocità, dunque, è difficile da controllare e ha un impatto
significativo sulla politica e sull'economia.
Vi
sono, inoltre, degli impatti sul piano dei rapporti personali. Un
mondo sempre più veloce implica un'obsolescenza programmata dei
rapporti, che conduce ad un'erosione dei legami sociali. Non c'è
più tempo per creare rapporti profondi e, soprattutto, duraturi,
così si ricorre a relazioni superficiali, veloci, ‘usa e getta',
in un mondo in cui tutto è temporaneo e sostituibile.
Un
altro aspetto centrale evidenziato da Bauman nel suo saggio Modernità
liquida
è la stretta connessione tra il tema della velocità e il potere.
Nella modernità leggera, come lui stesso la definisce, il dominio è
esercitato da chi è in grado di agire e spostarsi più rapidamente,
motivo per cui la velocità è divenuta un elemento cruciale di
stratificazione sociale e gerarchia di dominio.
Chi può permettersi di essere veloce, sia nei movimenti che nelle
decisioni, detiene il potere.
Allo
stesso tempo Bauman sottolinea come la velocità sia anche un
elemento di salvezza. Non rimanere indietro è una necessità per chi
vive nella modernità liquida: per sopravvivere occorre rimanere al
passo con i cambiamenti. Tuttavia, l'autore ci ricorda che la
velocità non favorisce il pensiero.
Quest'ultimo, infatti, implica la necessità di una riflessione
profonda, un dialogo, una comprensione che richiedono tempo, un bene
raro in un'epoca dominata dall'immediatezza.
La
velocità, dunque, è un tema fondamentale della modernità liquida,
trovando una delle sue espressioni nell'alta velocità ferroviaria.
Alla luce di ciò, l'architettura liquida si configura come la
rappresentazione più adeguata dei valori di velocità, efficienza e
dinamismo. Non si limita a soddisfare esigenze meramente funzionali,
ma si fa portatrice dei significati simbolici.
NOTE
BIBLIOGRAFIA
AIREY
2014
BAUMAN 2011
Zygmunt
BAUMAN, Modernità
Liquida,
Roma e Bari, Editori Laterza, 2011.
CAPUTO
2015
COLONNA
2014
Stefano
COLONNA, La
dialettica classico/anticlassico tra Argan, Zevi e Novak per una
definizione critico-estetica di "Architettura Liquida",
in "BTA - Bollettino Telematico dell'Arte, 16 Giugno 2014, n.
715.
COLONNA
2016
Stefano
COLONNA, Per
uno Statuto di Architettura e Museologia liquida,
in "Lettera Orvietana", a. XVII, N. 43-44-45-46-47,
dicembre 2016.
DE
ROSSI 2008
FERRARINI
2007
Alessia
FERRARINI., La
stazione del XXI Secolo,
Milano, Electa Editrice, 2007.
GERLINI,
MORI, PAIELLA 2017
Massimo
GERLINI, Paolo MORI, Raffaele PAIELLA, Architettura
e progetti delle stazioni italiane… dall'Ottocento all'Alta
Velocità,
Roma 2017.
IL
NODO URBANO 2003
Il
nodo urbano. Il concorso della nuova stazione di Torino Porta Susa,
Milano, l'Arca, 2003.
JODIDO
2009
Philip
JODIDO, Reggio
Emilia Bridges,
in Santiago
Calatrava - Complete Works 1979-2009,
Köln, Taschen, 2009.
NUZZO
2008
Valeria
NUZZO, La
stazione ferroviaria verso l'alta velocità,
Roma 2008.
WHEELMER,
MEYERSON 2024
Alina
WHEELMER, Rob MEYERSON, Designing
Brand Identity,
Hoboken, Wiley, 2024.
Vedi anche nel BTA:
USCITE DI ARCHITETTURA LIQUIDA
|