|
|
|
|
|
|
|
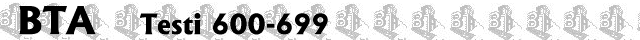
N.B. L'elenco è ordine inverso per facilitare la lettura delle novità BTA00699.html
Un tesoro nella Contea di Modica: S. Maria del Gesù
BTA00699.html
Un tesoro nella Contea di Modica: S. Maria del GesùLaura Fava, Ispica - RG, Italia, 18 Dicembre 2013, n. 699  BTA00698.html
Cinzia Mastropaolo. La fantasia è donna
BTA00698.html
Cinzia Mastropaolo. La fantasia è donnaMaria Filippone Colonna, 16 Dicembre 2013, n. 698  BTA00697.html |
PDF
BTA00697.html |
PDFFrancesco Franco, Baldo Diodato: una recensione Stefano Colonna, 6 Dicembre 2013, n. 697  BTA00696.html
Il giardino di Boboli
BTA00696.html
Il giardino di BoboliClaudia Maria Bucelli, 6 Dicembre 2013, n. 696 Il giardino di Boboli, straordinaria estensione di hortus urbano - soggetto interessante anche per la diversità floristica e faunistica che lo caratterizza – uno dei più importanti esempi di giardino formale del Rinascimento italiano nonché prototipo di complesso architettonico e paesaggistico unitario e coerente, si estende per circa 45 ettari nel cuore della città di Firenze. Vincolato per circa quattro secoli al ruolo di giardino di reggia, luogo di rappresentanza del potere e del fasto della famiglia regnante, teatro della vita di corte per sontuosi allestimenti scenici, festeggiamenti di sponsali e per i più celebri e magnifici episodi venatori dell'Europa intera, ha subito specialmente dalla metà del XVI ai primi decenni del XVII secolo quei lavori e integrazioni che lo hanno condotto alle attuali peculiari caratteristiche. La forma vagamente a triangolo allungato si misura con due assi quasi perpendicolari a partire dai quali si sviluppano una serie di terrazze, fontane, viali e percorsi secondari, vedute prospettiche con statuaria, radure, episodi a giardino e annessi architettonici in continua successione di visuali, corridoi prospettici, scorci scenografici e panorami sui rilievi all’orizzonte.  BTA00695.html
Jerry Uelsmann, il serbatoio dell'immaginazione
BTA00695.html
Jerry Uelsmann, il serbatoio dell'immaginazioneEleonora Rovida, 27 Novembre 2013, n. 695 Il celebre fotografo è noto al grande pubblico per i suoi capolavori, originati da una meticolosa lavorazione nella sovrapposizione di negativi, che danno origine a immagini oniriche di notevole impatto visivo. Uelsmann ha creato numerose opere dedicate a grandi artisti contemporanei che riflettono il suo gusto dada e surrealista: sono riflessioni e interpretazioni artistiche. Tra essi c'è un omaggio a Joseph Cornell come meditazione sull'assonanza tra l'io (“I”) e l'occhio (“eye”).  BTA00694.html
Il frontespizio alchimistico di François Béroalde de
Verville per l'edizione francese dell'Hypnerotomachia Poliphili
del 1600
BTA00694.html
Il frontespizio alchimistico di François Béroalde de
Verville per l'edizione francese dell'Hypnerotomachia Poliphili
del 1600Alessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 26 Novembre 2013, n. 694  BTA00693.html
La famiglia Capranica e il suo palazzo romano
BTA00693.html
La famiglia Capranica e il suo palazzo romanoMaria Beatrice Bongiovanni, Roma, Italia, 14 Novembre 2013, n. 693 In questo studio vengono messi in relazione la figura del cardinale Domenico Capranica (1400 – 1458), il problema della sua creazione cardinalizia, l'analisi storica e architettonica del palazzo in Roma, l'inserimento del palazzo nel contesto urbano e la creazione dell'Almo Collegio Capranica, fondato nel 1457 e ancora oggi una delle più eminenti istituzioni ecclesiastiche dell'Urbe. La nobile famiglia romana dei Capranica fu legata alla famiglia dei Colonna e fece fortuna sotto il pontificato di Martino V. Domenico Capranica fu un cardinale e umanista che influenzò molto la vita ecclesiastica, contrastò la corruzione e, per Nicolò V, redasse un memoriale per una riforma della Chiesa romana. Nel 1424 venne eletto vescovo di Fermo; partecipò ai concili di Basilea e di Ferrara – Firenze. Fu vicario generale della Marca Anconitana e più volte governatore di Perugia. Si distinse per aver sventato, insieme al cardinale Bessarione, la congiura di Stefano Porcari e per essere stato a capo della legazione ad Alfonso V re di Napoli. Il problema della creazione cardinalizia dipende, in massima parte, dalla pubblicazione del 1430; gli studiosi di storia della Chiesa e di Diritto canonico sono divisi nel determinare la data della nomina cardinalizia del Capranica. Pochi anni prima della morte fondò il Collegio Capranica nel suo palazzo, dove aveva raccolto una preziosa biblioteca di codici. Il palazzo quattrocentesco sorge quasi al limite occidentale del rione Colonna. Domenico da Sarteano, suo segretario, procuratore della Penitenziaria Apostolica e abitante dello stesso rione, stipulò per conto del cardinale i contratti di acquisto di case. Nel corso dei secoli il palazzo ha subito numerose alterazioni, tra cui la costruzione di un teatro al suo interno nel XVII secolo. Oggi ci appare completamente modificato nella struttura originaria e nella proporzione volumetrica.  BTA00692.html
Nuove acquisizioni documentarie sulla Sacrestia di S. Pietro in Vincoli
BTA00692.html
Nuove acquisizioni documentarie sulla Sacrestia di S. Pietro in VincoliRossana Castrovinci, Roma, Italia, 26 Ottobre 2013, n. 692  BTA00691.html
L'antica chiesa di Santa Maria della Pomice in Ravello
BTA00691.html
L'antica chiesa di Santa Maria della Pomice in RavelloSalvatore Amato, Ravello (SA), Italia, 7 Ottobre 2013, n. 691  BTA00690.html
Scipione Pulzone. Da Gaeta a Roma alle Corti europee: una recensione
BTA00690.html
Scipione Pulzone. Da Gaeta a Roma alle Corti europee: una recensioneGiorgia Duò, Roma, Italia, 29 Settembre 2013, n. 690  BTA00689.html
“Frankenweenie”: la tessitura del sogno
BTA00689.html
“Frankenweenie”: la tessitura del sognoEleonora Rovida, 28 Settembre 2013, n. 689 Il film d'animazione realizzato da Burton riprende il progetto del cortometraggio omonimo realizzato dallo stesso regista circa trent'anni prima. Lo stop motion, tecnica che ha reso celebre il regista, dona nuova vita alla storia, come a Sparky. Il suo (ri-creatore) Victor, nuovo dottor Frankenstein, diventa la personificazione di un deus ex machina che crea nel suo laboratorio da alchimista-stregone, rispecchiando il ruolo del regista nel remake di Frankewnweenie.
[english:]  BTA00688.html
La Biennale di Venezia 2013: 55.a Esposizione Internazionale d'Arte
BTA00688.html
La Biennale di Venezia 2013: 55.a Esposizione Internazionale d'ArteVeronica Caliendo, Fiumicino - RM, Italia, 27 Settembre 2013, n. 688  BTA00687.html
Palestrina nel Quattrocento. Riflessi dell'articolata cultura di un'epoca
BTA00687.html
Palestrina nel Quattrocento. Riflessi dell'articolata cultura di un'epocaSara Esposti, Ferentino (FR), Italia, 15 Agosto 2013, n. 687 Non una semplice sovrapposizione di edifici ma una evoluzione, integrazione e fusione di fasi storico-architettoniche: è in quest’ottica che nei restauri quattrocenteschi del monumento prenestino si rintracciano segni di un passato rispettosamente integrato e valorizzato e, contemporaneamente, spunti innovativi e soluzioni architettoniche che troveranno un largo impiego nei periodi successivi. Palestrina propone un esempio di Storia dell’Architettura nel suo scorrere fluido nel tempo senza soluzioni di continuità. Stringenti sono le corrispondenze tra l’impianto architettonico del monumento preso in esame e le costruzioni immaginarie dell’ Hypnerotomachia Poliphili: è proprio partendo da questo percorso di riflessione che lo studioso Maurizio Calvesi ha brillantemente intuito che il Francesco Colonna autore dell’incunabolo è il Francesco Colonna romano, signore di Praeneste che, da uomo colto e imbevuto dei principi dell’architettura, ha potuto guidare i lavori di ristrutturazione del suo palazzo e dell’intero complesso architettonico alla fine del Quattrocento. Un breve excursus sulla formazione culturale e sulle frequentazioni del principe prenestino con riferimento ad accertati avvenimenti storici e il rinvenimento di due documenti inediti presso l’Archivio di Subiaco chiudono materialmente il contributo aprendo la riflessione sull’argomento a nuovi studi e approfondimenti critici.  BTA00686.html
La Villa Medicea di Poggio Imperiale a Firenze
BTA00686.html
La Villa Medicea di Poggio Imperiale a FirenzeClaudia Maria Bucelli, 13 Agosto 2013, n. 686 La villa di Poggio Imperiale sorge a ridosso dell'Oltrarno fiorentino sulla collina di Arcetri, all’esterno delle antiche mura della città che comprendono il vicino giardino di Boboli. Si colloca a circa un chilometro dal piazzale di porta Romana e a due da palazzo Pitti, risiedendo dunque in un contesto di forte pregnanza storica e in un ambito paesaggistico e panoramico di rilevante suggestione e pregio. Vi si accede percorrendo per circa un chilometro, dal Piazzale di Porta Romana, un eminente asse urbano creato da Giulio Parigi come asse di proiezione della città nella campagna, con fuga prospettica sulla facciata della villa. Questo antico 'Stradone' fu costruito, per volontà di Maria Maddalena d’Austria, fiancheggiato da olmi, lecci, cipressi, e originariamente adornato da quattro vivai con statue di Lupa che allatta due piccoli infanti, Leone che schiaccia il globo, i fiumi Arno e Arbia e due Aquile Imperiali raffiguranti in corpo lo stemma mediceo, alle quali si richiamava un'altra aquila bicipite, posta in facciata alla villa.  BTA00685.html
“Roma, il più grande parco archeologico del mondo”: un futuro per l'antico? Parlano gli addetti ai lavori
BTA00685.html
“Roma, il più grande parco archeologico del mondo”: un futuro per l'antico? Parlano gli addetti ai lavoriSonia Modica, Aprilia - LT, 31 Luglio 2013, n. 685  BTA00684.html
Un incontro all'Accademia di San Luca in onore di Argan
BTA00684.html
Un incontro all'Accademia di San Luca in onore di ArganDavide Boschi, 31 Luglio 2013, n. 684  BTA00683.html
Baciami ancora di Manuela Mazzini
BTA00683.html
Baciami ancora di Manuela MazziniMaria Filippone Colonna, 31 Luglio 2013, n. 683  BTA00682.html
La committenza Barbo nella Casa dei Cavalieri di Rodi
BTA00682.html
La committenza Barbo nella Casa dei Cavalieri di RodiAlessia Dessì, 9 Giugno 2013, n. 682  BTA00681.html
C'era una volta Joseph Cornell nel Paese delle Meraviglie
BTA00681.html
C'era una volta Joseph Cornell nel Paese delle MeraviglieEleonora Rovida, 8 Giugno 2013, n. 681 L'artista statunitense è un grande appassionato del mondo vittoriano, epoca in cui vengono creati piccoli teatrini per l'immaginazione molto simili al principio creativo delle celebri Shadow Boxes. Due in particolare sembrano celebrare la “quadriglia dell'aragosta” contenuta nelle avventure di Alice. Lewis Carroll era un autore amato e illustrato dai Surrealisti. Questo scritto si propone di rintracciare le possibili influenze dell'autore vittoriano sull'opera cornelliana.
[english:]  BTA00680.html
Riflessioni sulla committenza storica e sull'attuale degrado della Villa Catena di Poli
BTA00680.html
Riflessioni sulla committenza storica e sull'attuale degrado della Villa Catena di PoliAlessio Gordiani, 8 Giugno 2013, n. 680  BTA00679.html
La Villa Medicea di Cerreto Guidi
BTA00679.html
La Villa Medicea di Cerreto GuidiClaudia Maria Bucelli, 1 Giugno 2013, n. 679 Emergente nella Valdinievole fra le propaggini meridionali del Montalbano occidentale e il fiume Arno, sul colle confinante con i luoghi strategici del Padule di Fucecchio, la villa di Cerreto Guidi deriva il proprio toponimo e l'arme, un albero di cerro, dall'abbondanza di Quercus cerris che fino all'anno mille caratterizzava le sue contrade. Si colloca al centro dell’abitato di Cerreto, definendone il disegno urbano a raggiera, orientandone lo sviluppo lungo le direttrici stradali estese verso la campagna e caratterizzando morfologicamente con la propria presenza i caratteri antropici del paesaggio circostante. Innalzata su un basamento che eleva il piano prospettico ampliando la percezione sull’intorno, la villa ricade nella tipologia di distribuzione planimetrica a blocco compatto, organizzata attorno ad un salone centrale a cui si accede direttamente dal portone d'ingresso. Una fondata ipotesi attribuisce a Bernardo Buontalenti, all'epoca maturo progettista attivo presso i committenti medicei, la concezione e monumentalità delle rampe d'accesso ‘a scalera’ denominate ‘ponti medicei’.  BTA00678.html
Le Scuderie del Quirinale celebrano “Tiziano”: “il più eccellente di quanti hanno dipinto”
BTA00678.html
Le Scuderie del Quirinale celebrano “Tiziano”: “il più eccellente di quanti hanno dipinto”Giorgia Duò, Roma, Italia, 13 Maggio 2013, n. 678  BTA00677.html
Fonti e simboli per il Satiro “scandagliatore” di Agostino Carracci
BTA00677.html
Fonti e simboli per il Satiro “scandagliatore” di Agostino CarracciGloria de Liberali, 13 Maggio 2013, n. 677  BTA00676.html
Identificata l'immagine di un angioletto nella Vocazione di San Matteo di Caravaggio
BTA00676.html
Identificata l'immagine di un angioletto nella Vocazione di San Matteo di CaravaggioNadia Scardeoni, Verona, Italia, 7 Maggio 2013, n. 676  BTA00675.html
Brueghel. Meraviglie dell'arte fiamminga: una recensione
BTA00675.html
Brueghel. Meraviglie dell'arte fiamminga: una recensioneGiulia Martina Weston, Roma, Italia, 7 Maggio 2013, n. 675  BTA00674.html
La Villa Medicea di Fiesole
BTA00674.html
La Villa Medicea di FiesoleClaudia Maria Bucelli, 7 Maggio 2013, n. 674 Villa Medici è ubicata in zona collinare, poco fuori dall’abitato di Fiesole e si estende con i giardini terrazzati a mezza costa verso Firenze, orientata ad uno dei paesaggi più belli della Toscana, in splendida posizione panoramica ed in contesto di alto valore ambientale nel tessuto agricolo storico degli oliveti e dei campi coltivati alternati a macchie di bosco. Considerata la prima villa fiorentina di tipo umanistico, impostata ex novo secondo gli innovativi criteri di Leon Battista Alberti, la villa fiesolana fu la prima residenza costruita in planimetria simmetrica aperta su logge verso il giardino, l'aperta campagna e i panorami della conca fiorentina: per la prima volta una residenza agreste si strutturava circondandosi di giardini finalizzati a scopi estetici invece di organizzarsi come una redditizia tenuta. Più volte riprodotta artisticamente, la villa compare nella Dormitio Virginis di Domenico Ghirlandaio e nell'Annunciazione di Biagio d'Antonio, mentre nell'Annunciazione di Antonio e Piero Pollaiolo il panorama di Firenze e della valle dell'Arno incorniciato dalla bifora dietro l'angelo nunziante è proprio la splendida veduta che si godeva dalla villa fiesolana, nelle cui stanze è ambientata la scena del dipinto.  BTA00673.html
La Villa Medicea di Cafaggiolo
BTA00673.html
La Villa Medicea di CafaggioloClaudia Maria Bucelli, 1 Maggio 2013, n. 673 Cafaggiolo nasce come primo nucleo di castello di caccia, fortilizio di difesa e controllo sulla viabilità verso Bologna, venendo in seguito trasformato nella più illustre fra le residenze medicee mugellane, nonché centro direzionale di gestione e governo di ampie aree agricole e boschive. Prototipo e modello di residenza signorile in campagna finalizzata alla villeggiatura, al riposo, allo studio, alla cura delle attività agricole, questa villa-fattoria era la preferita da Cosimo il Vecchio che vi godeva dei tanto amati testi antichi e moderni, sacri e profani, quando si ritirava in campagna per dedicarsi allo studio e alla frequentazione dei dotti umanisti del proprio circolo, nonché all'attività agricola e venatoria, emulando Cicerone nell’appassionata creazione di giardini e ricerca di opere d'arte con cui abbellirli. Fu proprio Cosimo che incaricò Michelozzo dei lavori di ampliamento alla villa, risolti in quel rigore geometrico di volumetrie e superfici intonacate ritmate da finestre listate in pietra, in seguito supporto compositivo dell'architettura fiorentina di campagna.  BTA00672.html
Nuova luce sugli affreschi dell'Appartamento Borgia in Vaticano
BTA00672.html
Nuova luce sugli affreschi dell'Appartamento Borgia in VaticanoAlessandra Masullo, 28 Aprile 2013, n. 672  BTA00671.html
La Villa Medicea del Trebbio
BTA00671.html
La Villa Medicea del TrebbioClaudia Maria Bucelli, 15 Aprile 2013, n. 671 Collocata a nord-est di Firenze, la villa del Trebbio fu edificata in cima ad una collina sui resti di un'antica fortificazione strategica longobarda, verso l’antica viabilità che da Firenze conduceva a Bologna: da qui toponomasticamente il nome, dal latino Trivium, indicante un crocicchio di tre vie. Una consolidata tradizione, appoggiandosi all'attribuzione vasariana, vede in Trebbio la prima, in ordine di tempo, delle grandi ville medicee a cui Michelozzo avrebbe lavorato su commissione di Cosimo il Vecchio. Il“luogo detto Trebbio, con orto, prato, corte e con due pezzi di vigna” si è tramandato identico per secoli, fino alla raffigurazione nella lunetta di Giusto Utens, e ad oggi Trebbio è fra quelle che meglio sopravvive fedele all’antica iconografia nell'aspetto serrato di fortificazione medioevale e nel celebre pergolato a vite, unico rimasto dei due originari, raro esempio di impianto di giardino umanistico-rinascimentale ad oggi sopravvissuto.  BTA00670.html
Il sistema delle ville medicee: caratteri distintivi e peculiarità paesaggistiche nell'approfondimento di alcuni casi studio
BTA00670.html
Il sistema delle ville medicee: caratteri distintivi e peculiarità paesaggistiche nell'approfondimento di alcuni casi studioClaudia Maria Bucelli, 13 Aprile 2013, n. 670 Dimore signorili suburbane nel duplice ruolo di unità agricole produttive e aristocratiche residenze di delizie, luoghi per la villeggiatura finalizzati a svago, riposo, attività fisica, contemplazione, organizzazione di circoli culturali e di ritiri spirituali di classica memoria, ma anche, in epoca granducale, apparati scenografici della vita di corte e di memorabili feste e cacce, le ville medicee costituirono, dal loro definirsi, dei prototipi architettonici, artistici, paesistici, generati da singolari connubi tra committenti e artisti. Definirono anche, quali innovativi esempi di connessione fra architettura, giardino e paesaggio, contestualmente alla nuova sensibilità estetica legata all’ideale umanistico, nuove modalità estetiche, visive, insediative, fruitive, funzionali. Nel tempo poi sempre più identificarono i caratteri architettonici salienti della villa rinascimentale, inquadrandone il valore di eminenza nel paesaggio, il rigore geometrico dell’impianto architettonico di edifici e giardini organizzati su terrazzi digradanti quali balconi affacciati sul dominio visivo, parafrasi di quello mediceo sui territori assoggettati al proprio governo.  BTA00669.html
Il pavimento musivo della Basilica di Santa Maria Antiqua. Un nuovo contributo per la sua datazione e attribuzione
BTA00669.html
Il pavimento musivo della Basilica di Santa Maria Antiqua. Un nuovo contributo per la sua datazione e attribuzioneNicola Severino, Roccasecca - FR, Italia, 3 Aprile 2013, n. 669  BTA00668.html
Top Old Masters - Le aste londinesi di Christie's e Sotheby's (4-6 dicembre 2012)
BTA00668.html
Top Old Masters - Le aste londinesi di Christie's e Sotheby's (4-6 dicembre 2012)Giulia Martina Weston, Roma, Italia, 27 Gennaio 2013, n. 668  BTA00667.html
Un pieno ... pieno di vuoto
BTA00667.html
Un pieno ... pieno di vuotoSara Sacco, Marino - RM, Italia, 4 Gennaio 2013, n. 667  BTA00666.html
Luigi Ontani - AnderSennoSogno: una recensione
BTA00666.html
Luigi Ontani - AnderSennoSogno: una recensioneRosanna Ruscio, Roma, Italia, 30 Dicembre 2012, n. 666  BTA00665.html
Cecilia Mazzetti di Pietralata Joachim von Sandrart (1606-1688). I disegni: una recensione
BTA00665.html
Cecilia Mazzetti di Pietralata Joachim von Sandrart (1606-1688). I disegni: una recensioneAlessio Calabresi, Roma, Italia, 19 Novembre 2012, n. 665  BTA00664.html
Il ruolo sociale ed educativo dell'arte a Città del Messico e la promessa dei musei universitari
BTA00664.html
Il ruolo sociale ed educativo dell'arte a Città del Messico e la promessa dei musei universitari Mercedes Auteri, Catania, Italia, 7 Novembre 2012, n. 664  BTA00663.html
Erranze
BTA00663.html
ErranzeOrnella Fazzina, Siracusa, Italia, 27 Ottobre 2012, n. 663  BTA00662.html |
PDF
BTA00662.html |
PDFRubens e l'eredità italiana. Il caso del corpus rubensiano della Courtauld Gallery di Londra Giulia Martina Weston, Roma, Italia, 12 Ottobre 2012, n. 662  BTA00661.html
L'assetto urbanistico di piazza del Popolo nel Seicento
BTA00661.html
L'assetto urbanistico di piazza del Popolo nel SeicentoElisabetta Caputo, Sapri - SA, Italia, 21 Settembre 2012, n. 661
Nel corso del Quattrocento, Roma, inizia ad avere un rinnovamento
sostanziale. Palazzi cardinalizi diventano centri di potere delle
ricche corti con centinaia di servitori e decine di sbirri, centri di
clientela e beneficenza; territori di un potere assolutamente diverso
da quelli dei baroni medievali, ma come quelli fondati sul
frazionamento, sulla divisione della città sia topograficamente che
per censo e potere. In tale contesto anche i papi si affrettano ad attuare sia in prima persona che no, trasformazioni
favorendo risoluzioni nelle varie zone della città.  BTA00660.html
Mauro Rea: quando la passione di esistere diventa comunicazione
BTA00660.html
Mauro Rea: quando la passione di esistere diventa comunicazioneMaria Filippone Colonna, 25 Agosto 2012, n. 660  BTA00659.html
L'Orto Botanico di Padova e l'Estate Carrarese 2012
BTA00659.html
L'Orto Botanico di Padova e l'Estate Carrarese 2012Roberta Balmas, 15 Agosto 2012, n. 659  BTA00658.html
Animazione tecnologica interattiva. Il sistema di presentazione delle informazioni del castello del Buonconsiglio di Trento
BTA00658.html
Animazione tecnologica interattiva. Il sistema di presentazione delle informazioni del castello del Buonconsiglio di TrentoMaria Filippone Colonna, 1 Agosto 2012, n. 658  BTA00657.html
La Certosa di San Lorenzo in Padula
BTA00657.html
La Certosa di San Lorenzo in PadulaElisabetta Caputo, Sapri - SA, Italia, 31 Luglio 2012, n. 657 Si trova nel piccolo sobborgo di Padula, posta nel sud d’Italia, la Certosa di San Lorenzo, uno fra i più splendidi complessi architettonici della nostra penisola che racchiude in sé molteplici stili dell’arte medievale e moderna: Romanico, Gotico, Rinascimento, Barocco, Roccocò. Fondata da Tommaso Sanseverino nel 1306, con lo scopo di mostrare la sua devozione nei confronti dell'ordine Certosino, si sviluppa su di una grancia detta appunto di San Lorenzo. La Certosa di Padula è la prima in tutto l’ordine che si denomini dal Santo, al quale ne furono dedicate altre due, una a Firenze e l’altra in Svizzera, ma ciò avvenne in seguito. All’interno dell' edificio possiamo vedere come gli spazî sono suddivisi in base all’organizzazione religiosa e amministrativa. Ovunque nella Certosa, si distingue nei fregi decorativi, il monogramma certosino CAR (Cartusia, termine latino di Certosa), e l’emblema della graticola, strumento del martirio di San Lorenzo. La Certosa è anche considerata figlia della Certosa di San Bartolomeo di Trisulti. Facendo un confronto fra le due possiamo renderci conto delle loro poche differenze e delle innumerevoli somiglianze. Il monumento ha avuto sempre il suo ritmo di splendore e di prosperità, grazie alla benevolenza dei pontefici e alla protezione dei monarchi. Dell’originaria costruzione restano in questo momento l’impianto iconografico d’insieme e le volte della chiesa, qualche frammento ed elemento architettonico sparsi ovunque: si tratta sostanzialmente di capitelli, che si allontanano però dall’epoca dell’inizio dei lavori. Nel corso dei secoli sono stati fatti vari rifacimenti, in realtà non è mai esistita un’immagine dell’edificio tutta intera. La Certosa, ha uno splendore unico e allo stesso modo, sfavillanti, sono i giardini che essa racchiude al suo interno. Il verde è parte integrante delle Certose e si articola in numerosi spazî.  BTA00656.html |
PDF
BTA00656.html |
PDFElementi di logudorese nelle epigrafi del S. Stefano di Oschiri e della S. Maria Iscalas di Bonnanaro Giuseppe Piras, Porto Torres - SS, Italia, 12 Luglio 2012, n. 656  BTA00655.html |
PDF
BTA00655.html |
PDFLo spettatore spett-attore al museo e le conseguenze del Metodo Abramovic Mercedes Auteri, Catania, Italia, 5 Luglio 2012, n. 655  BTA00654.html
Quegli “strani” guardiani al museo
BTA00654.html
Quegli “strani” guardiani al museoAndrea D'Agostino, 4 Luglio 2012, n. 654  BTA00653.html
La città e la Cattedrale: visioni di Napoli tra '300 e '500
BTA00653.html
La città e la Cattedrale: visioni di Napoli tra '300 e '500Ettore Janulardo, Roma, Italia, 30 Giugno 2012, n. 653 La Tavola Strozzi (1472-73) – prima significativa rappresentazione topografica moderna della città partenopea, immagine che fonda una spazialità orizzontalmente tripartita fra acqua, terra e cielo –, introduce lo sguardo nelle stratificazioni di Napoli. Punto di vista dal mare, questa rappresentazione tardo-quattrocentesca condensa in sé e assume nella raffigurazione anche gli emblemi architettonici di Napoli: da Castel dell’Ovo al Castel Nuovo, dal porto alle porte murarie, da Capodimonte alle chiese e al Duomo. Alla stesura compatta ma aperta della Tavola Strozzi fa da contrappunto, oltre un secolo prima, la novella boccacciana che distilla della città gli interni e le interiora, per una visione dell’oscuro e del bassofondo, una percezione dal basso che si fa consapevolezza del pericolo e attesa della prossima condanna; alla misurata luminosità della raffigurazione fa da contrasto il buio degli inganni e dei pericoli, in un ritmo teso che condensa il nucleo dell’azione scenica in una notte. Con una narrazione che unisce particolari realistici e sfumature leggendarie, Boccaccio fa di Napoli l’epitome del pericolo, il centro gravitazionale degli inganni e dei sotterfugi, ove l’eterogenesi dei fini è norma che consente solo lievi variazioni, sottili scarti, e una cattedrale non è che l’approdo di un furto sacrilego.  BTA00652.html
Apre la Fondazione Bisazza per il Design e l'Architettura Contemporanea
BTA00652.html
Apre la Fondazione Bisazza per il Design e l'Architettura ContemporaneaGuido Faggion, Montagnana PD, Italia, 20 Giugno 2012, n. 652  BTA00651.html |
PDF
BTA00651.html |
PDFL'arte al tempo dei terremoti in televisione, la “memoria viva” del Belìce Mercedes Auteri, Catania, Italia, 6 Giugno 2012, n. 651  BTA00650.html
Giovanni Volpato: un imprenditore ante litteram
BTA00650.html
Giovanni Volpato: un imprenditore ante litteramGiorgia Duò, Roma, Italia, 3 Giugno 2012, n. 650  BTA00649.html |
PDF
BTA00649.html |
PDFL'Islam in Sicilia, un giardino tra due civiltà fiorito alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, dopo secoli di semina Mercedes Auteri, Catania, Italia, 9 Maggio 2012, n. 649  BTA00648.html
Arte classica e aniconismo geometrico. L'eredità del classico nel XX secolo
BTA00648.html
Arte classica e aniconismo geometrico. L'eredità del classico nel XX secoloLidia Pizzo, Siracusa, Italia, 8 Maggio 2012, n. 648  BTA00647.html
Azione e Reazione: binomio nell'arte di Paolo Troilo
BTA00647.html
Azione e Reazione: binomio nell'arte di Paolo TroiloSara Sacco, Marino - RM, Italia, 5 Maggio 2012, n. 647  BTA00646.html
Contatti: Modi/Tass
BTA00646.html
Contatti: Modi/TassEnrica Torelli Landini, 18 Aprile 2012, n. 646  BTA00645.html
A Roma come a New York l'Avanguardia americana:capolavori dal Guggenheim (1945/1980)
BTA00645.html
A Roma come a New York l'Avanguardia americana:capolavori dal Guggenheim (1945/1980)Giorgia Duò, Roma, Italia, 13 Marzo 2012, n. 645  BTA00644.html
Il facsimile dell'Hortus amoenissimus di Franciscus De Geest: una recensione
BTA00644.html
Il facsimile dell'Hortus amoenissimus di Franciscus De Geest: una recensioneAlessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 21 Febbraio 2012, n. 644  BTA00643.html
Un S. Agostino nella chiesa del Gran Priorato di S. Andrea a Piazza Armerina
BTA00643.html
Un S. Agostino nella chiesa del Gran Priorato di S. Andrea a Piazza ArmerinaGiovanna Di Marco, Palermo, Italia, 12 Febbraio 2012, n. 643  BTA00642.html
11 settembre, “Molto forte incredibilmente vicino”
BTA00642.html
11 settembre, “Molto forte incredibilmente vicino”Eleonora Rovida, 11 Febbraio 2012, n. 642 Il romanzo dell'autore di fama internazionale Jonathan Safran Foer è un terreno di gioco per cacciatori di relazioni. L'aspetto collagistico, della nota e dell'appunto, rappresentano la ricerca ludica del protagonista, che segue l'insegnamento “investigativo” del padre, e, allo stesso modo, il procedimento di realizzazione di questo scritto che mira a rintracciare nel romanzo l'influenza di dell'artista a cui Foer dedicò il suo primo libro.
[english:]  BTA00641.html
Natura morta: rappresentazione dell'oggetto, oggetto come rappresentazione
BTA00641.html
Natura morta: rappresentazione dell'oggetto, oggetto come rappresentazioneRosanna Ruscio, Roma, Italia, 8 Febbraio 2012, n. 641  BTA00640.html
Una mummia per amica
BTA00640.html
Una mummia per amicaTiziana Lanza, 5 Febbraio 2012, n. 640  BTA00639.html |
PDF
BTA00639.html |
PDFLa questione civile e il ruolo sociale del museo in tempi di crisi e post-democrazia Mercedes Auteri, Catania, Italia, 5 Febbraio 2012, n. 639  BTA00638.html
FARM CULTURAL PARK. Estetica e contemporaneità in Sicilia
BTA00638.html
FARM CULTURAL PARK. Estetica e contemporaneità in SiciliaGiuseppe Carrubba, Siracusa, Italia, 29 Gennaio 2012, n. 638  BTA00637.html
È nata la prima rivista patafisica di ’Patafisica in Italia: il “Quaderno” del Collage de ’Pataphysique
BTA00637.html
È nata la prima rivista patafisica di ’Patafisica in Italia: il “Quaderno” del Collage de ’PataphysiqueAntonio Castronuovo, Imola - BO, Italia, 1 Gennaio 2012, n. 637  BTA00636.html
Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani: una recensione
BTA00636.html
Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani: una recensioneGiorgia Duò, Roma, Italia, 28 Dicembre 2011, n. 636  BTA00635.html
Niccolò Tramontana: la pittura come percezione visiva della sostanza
BTA00635.html
Niccolò Tramontana: la pittura come percezione visiva della sostanzaAlessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 14 Dicembre 2011, n. 635  BTA00634.html
Novecento Privato. Arte italiana con vista su Padova
BTA00634.html
Novecento Privato. Arte italiana con vista su PadovaRoberta Balmas, Padova, Italia, 11 Dicembre 2011, n. 634  BTA00633.html
Gli Ologrammi di Dora Tass alla 54.ma Biennale di Venezia
BTA00633.html
Gli Ologrammi di Dora Tass alla 54.ma Biennale di VeneziaEnrica Torelli Landini, Italia, 17 Novembre 2011, n. 633  BTA00632.html
Ritratto dell' artista da giovane. Sull'esposizione “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli 1608-1624”
BTA00632.html
Ritratto dell' artista da giovane. Sull'esposizione “Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli 1608-1624”Massimo Maiorino, Nocera Inf., Salerno, Italia, 15 Novembre 2011, n. 632  BTA00631.html
“Inside the Cage”: il labirinto cornelliano
BTA00631.html
“Inside the Cage”: il labirinto cornellianoEleonora Rovida, 11 Novembre 2011, n. 631 Le celebri Shadow Boxes cornelliane sono slot machine oniriche che rappresentano la combinazione degli elementi più disparati collegati dal filtro personale dell'autore. La struttura a celle, come in una vetrina di Atget, una gabbia o un alveare, è un sistema in cui tutti gli elementi sono posizionati secondo una precisa relazione. L'idea è quella di vedere le scatole come un sistema di celle collegate sul modello di Excel giocando proprio come vorrebbe Cornell.
[english:]  BTA00630.html
Fluxus 1962 - 2012. Intervista a Ben Patterson
BTA00630.html
Fluxus 1962 - 2012. Intervista a Ben PattersonMecedes Auteri, Catania, Italia, 8 Novembre 2011, n. 630  BTA00629.html
Le Scuderie del Quirinale celebrano il “bellissimo ingegno” del Lippi
BTA00629.html
Le Scuderie del Quirinale celebrano il “bellissimo ingegno” del LippiGiorgia Duò, Roma, Italia, 7 Novembre 2011, n. 629  BTA00628.html
Il Simbolismo in Italia: Padova, Palazzo Zabarella
BTA00628.html
Il Simbolismo in Italia: Padova, Palazzo ZabarellaRoberta Balmas, Padova, Italia, 6 Novembre 2011, n. 628  BTA00627.html
La “Stele eburina”, il Potere sulla pietra. Testimonianze del Municipium eburinorum all'ombra della romanità imperiale
BTA00627.html
La “Stele eburina”, il Potere sulla pietra. Testimonianze del Municipium eburinorum all'ombra della romanità imperialeGianmatteo Funicelli, Eboli, Salerno, Italia, 5 Novembre 2011, n. 627  BTA00626.html |
PDF
BTA00626.html |
PDFArravutamm o'munn: L'universo sognante di Mauro Rea Maria Filippone Colonna, 25 Ottobre 2011, n. 626  BTA00625.html
Lo Shadowboxer di Cien años de soledad
BTA00625.html
Lo Shadowboxer di Cien años de soledadEleonora Rovida, 18 Ottobre 2011, n. 625 Gabriel Garcia Márquez ci ha regalato un mondo di infinita immaginazione: Macondo. Il personaggio di Rebeca porta con sé una malattia che dona agli abitanti un'allucinata lucidità che permette di vedere non solo i propri sogni, ma anche quelli degli altri distruggendo, allo stesso tempo, la memoria. Ci si affida ad un commesso viaggiatore con oggetti magici, un uomo delle ombre. L'articolo rilegge l'episodio attraverso i maestri del realismo magico tra arte e critica.  BTA00624.html
Break of Whiteness. Mijana Batinic and Robertina Sebjanic
BTA00624.html
Break of Whiteness. Mijana Batinic and Robertina SebjanicAlessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 5 Ottobre 2011, n. 624  BTA00623.html |
PDF
BTA00623.html |
PDFBianco come opportunità. Ristrutturazione di un appartamento nel “nuovo cuore” di Roma Gioia Rafanelli, 14 Settembre 2011, n. 623  BTA00622.html |
PDF
BTA00622.html |
PDFQuando la materia è luce. Puente Alamillo e altri ponti di Santiago Calatrava Maria Filippone Colonna, 27 Agosto 2011, n. 622  BTA00621.html
“Il favoloso mondo di Amélie”: un pastiche contemporaneo
BTA00621.html
“Il favoloso mondo di Amélie”: un pastiche contemporaneoEleonora Rovida, 23 Agosto 2011, n. 621 Il film è una favola contemporanea dove la protagonista vive un sogno ad occhi aperti: si camuffa da paladina della giustizia e cerca di aiutare gli altri senza destare sospetti perché tutto deve sembrare un semplice dono del quotidiano. Amélie trova la sua anima gemella, un giocatore come lei. Proprio come succede nella trama, viene qui realizzata una caccia al tesoro degli elementi del pastiche che rispecchiano l'arte contemporanea.  BTA00620.html
La rivoluzione educativa dell'arte, un apprendimento alla conquista di se stessi e del tempo
BTA00620.html
La rivoluzione educativa dell'arte, un apprendimento alla conquista di se stessi e del tempoMercedes Auteri, Catania, Italia, 17 Agosto 2011, n. 620  BTA00619.html
Grazie Ludovico Corrao, per questo sogno chiamato Gibellina, Fondazione Orestiadi, Museo delle trame mediterranee
BTA00619.html
Grazie Ludovico Corrao, per questo sogno chiamato Gibellina, Fondazione Orestiadi, Museo delle trame mediterraneeMercedes Auteri, Catania, Italia, 8 Agosto 2011, n. 619  BTA00618.html
Vasari e i pittori “de que' tempi”
BTA00618.html
Vasari e i pittori “de que' tempi”Guendalina Patrizi, Roma, Italia, 5 Agosto 2011, n. 618  BTA00617.html
La contaminazione: l'arte contemporanea tra sovrapposizione e volontà di potenza
BTA00617.html
La contaminazione: l'arte contemporanea tra sovrapposizione e volontà di potenzaCarmela Infarinato, Pistoia, Italia, 29 Luglio 2011, n. 617  BTA00616.html
Costruzioni e visioni: Roma e il mecenatismo spirituale alla metà del '400
BTA00616.html
Costruzioni e visioni: Roma e il mecenatismo spirituale alla metà del '400Ettore Janulardo, Roma, Italia, 29 Luglio 2011, n. 616 Negli otto anni di pontificato di Niccolò V, dal 1447 al 1455, a Roma si delineano le basi di una metamorfosi architettonico-urbanistica che si fa prospettiva culturale. Niccolò V pratica del “mecenatismo spirituale”: si operano costruzioni, restaurando e rinnovando ponti, acquedotti e chiese; si procede al riassestamento delle mura vaticane e delle fortificazioni di Castel S. Angelo; si determinano visioni delle articolazioni territoriali e delle relazioni tra i gruppi sociali nell’Urbe: vecchia e nuova nobiltà, strati mercantili, ripartizioni dei poteri all’ombra del pontificato, in un percorso che è di confronto politico ma anche di dialettica spaziale, tesa ed “illuminata”, lineare ed accidentata, segnata da successi e da drammi. Punto di avvio di un processo di metamorfosi del potere nell’Urbe, da entità tardo-medievale a nucleo di principato rinascimentale, il mecenatismo spirituale niccolino mostra anche il suo volto spietato, nella logica di un potere che, turbato dalla congiura e addolorato dalla caduta di Costantinopoli, non ritroverà più un andamento né sereno né aperto, concludendo la propria parabola nel 1455.  BTA00615.html
Il Casino di Caccia a pianta triangolare della famiglia Barberini a Palestrina
BTA00615.html
Il Casino di Caccia a pianta triangolare della famiglia Barberini a PalestrinaElisabetta Caputo, Sapri - SA, Italia, 16 Luglio 2011, n. 615
Il Triangolo Barberini sito nella piana sottostante la città di
Palestrina, è una struttura architettonica, che nonostante il suo
splendore e la sua rilevanza, ha avuto uno studio limitato nel corso
degli anni per la scarsità di documenti. La critica è stata
concorde nell’assegnare la realizzazione dell’opera a Francesco
Romano Contini, la cui figura emerge da molti documenti riguardanti
la famiglia Barberini, come Architetto di “Case”.  BTA00614.html
Dora Tass: Oggetti perturbanti
BTA00614.html
Dora Tass: Oggetti perturbantiEnrica Torelli Landini, 10 Luglio 2011, n. 614  BTA00613.html
LIVE ! - L’arte incontra il rock
BTA00613.html
LIVE ! - L’arte incontra il rockGiuseppe Carrubba, Prato, Italia, 30 Giugno 2011, n. 613  BTA00612.html
Padiglione Italia alla Biennale: Il Deposito dell'Arte
BTA00612.html
Padiglione Italia alla Biennale: Il Deposito dell'ArteCristina De Santis, Giulianova Lido - TE, Italia, 20 Giugno 2011, n. 612  BTA00611.html
“NO ONE BELONGS HERE MORE THAN YOU”.
BTA00611.html
“NO ONE BELONGS HERE MORE THAN YOU”.Budapest, MUCSARNOK Alessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 15 Giugno 2011, n. 611  BTA00610.html
Carla Accardi. E le altre donne che hanno reso possibile la rivoluzione dell'arte del Novecento
BTA00610.html
Carla Accardi. E le altre donne che hanno reso possibile la rivoluzione dell'arte del NovecentoMercedes Auteri, Catania, Italia, 8 Giugno 2011, n. 610  BTA00609.html
GLI IRRIPETIBILI ANNI ’60. Un dialogo tra Roma e Milano
BTA00609.html
GLI IRRIPETIBILI ANNI ’60. Un dialogo tra Roma e MilanoGiorgia Duò, Roma, Italia, 7 Giugno 2011, n. 609  BTA00608.html
Inediti di Medardo Rosso a Milano
BTA00608.html
Inediti di Medardo Rosso a MilanoAndrea D'Agostino, 6 Giugno 2011, n. 608  BTA00607.html
Integrazione, Liberazione, Speranza. Intervista a don Andrea Gallo
BTA00607.html
Integrazione, Liberazione, Speranza. Intervista a don Andrea GalloMercedes Auteri, Catania, Italia, 5 Giugno 2011, n. 607  BTA00606.html
L'alto e altro valore dell'arte: sui "valori" del patrimonio culturale con tre esempi virtuosi dal profondo sud
BTA00606.html
L'alto e altro valore dell'arte: sui "valori" del patrimonio culturale con tre esempi virtuosi dal profondo sudMercedes Auteri, Catania, Italia, 29 Maggio 2011, n. 606  BTA00605.html
Melozzo da Forlì: l'umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello
BTA00605.html
Melozzo da Forlì: l'umana bellezza tra Piero della Francesca e RaffaelloAlessandra Bertuzzi, Foligno - PG, Italia, 22 Maggio 2011, n. 605  BTA00604.html
"Outloo-King": la Mail Art di Joseph Cornell
BTA00604.html
"Outloo-King": la Mail Art di Joseph CornellEleonora Rovida, 21 Maggio 2011, n. 604 La corrispondenza personale costituisce un metodo per l'archivista visionario, Joseph Cornell. La raccolta, la selezione e la scelta sono alla base di un meccanismo che è parte del processo creativo dell'artista. La ricerca è rivolta a tutto quello che la grande città ha scartato, come un accumulo di elementi di una memoria abbandonata. L'idea di questo scritto è analizzare il sistema di Cornell, come un programma di posta elettronica dando particolare attenzione a quella indesiderata.
[english:]  BTA00603.html
Il nuovo archivio digitale d'immagini e la nuova rivista d'arte e archeologia dell'Università di Cagliari
BTA00603.html
Il nuovo archivio digitale d'immagini e la nuova rivista d'arte e archeologia dell'Università di CagliariLuigi Agus, Tempio Pausania - SS, Italia, 3 Maggio 2011, n. 603  BTA00602.html
DE-FORME
BTA00602.html
DE-FORMECarmela Infarinato, Pistoia, Italia, 22 Aprile 2011, n. 602  BTA00601.html
Cinerea res
BTA00601.html
Cinerea resGiuseppe Carrubba, Prato, Italia, 22 Aprile 2011, n. 601  BTA00600.html
Ci meritiamo la Venere di Morgantina ?
BTA00600.html
Ci meritiamo la Venere di Morgantina ?Mercedes Auteri, Catania, Italia, 16 Aprile 2011, n. 600 |
|
|
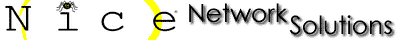
|
|